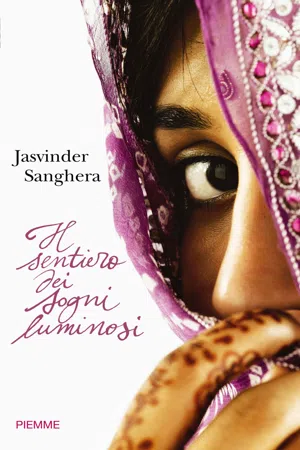![]()
1
Ogni mattina, alle cinque e mezza, mia madre attaccava a tutto volume con le sue preghiere. «Ik-cum-kar, ik-cum-kar...» Il baccano si aggirava lamentoso per tutta la casa ed era impossibile sfuggirgli. Potevi infilare la testa sotto il cuscino e pensare “basta, t-i p-r-e-g-o basta”, ma non riuscivi mai a bloccarlo completamente.
Eravamo in quattro a dormire nel letto: io, Lucy, Robina e Yasmin, due in testa e due ai piedi. Alla sera non facevamo che ridacchiare e contorcerci fra tutta una serie di «mi hai dato un calcio» e «levati» e «quel posto è mio» fino a quando non ci addormentavamo.
Nella nostra famiglia c’erano altre tre femmine. Bachanu, la mia sorellastra, che era rimasta in India quando la mamma era venuta qui, Prakash, che viveva a Londra, e Ginda, che aveva circa dieci anni più di me. Lei dormiva nella nostra stanza, nell’altro letto, ed era una presenza importantissima nella nostra vita; si potrebbe quasi dire che è stata lei a crescerci. Si occupava di noi mentre la mamma era al lavoro e, le sere in cui dovevamo fare il bagno, ci infilava tutte insieme nella vasca e ci lavava i capelli. Avevamo dei capelli molto lunghi e lei ce li massaggiava con un olio di mandorle e gelsomino che li rendeva orribilmente unti. Così ti rimanevano spiaccicati in testa e io odiavo quella sensazione e quell’odore. Man mano che crescevamo, però, a volte non c’era abbastanza spazio nella vasca e una di noi doveva prendere un catino di acqua calda e andare a lavarsi nel bagno esterno. In inverno era una cosa che odiavamo tutte.
La nostra prima casa aveva due camere da letto e mio fratello Balbir dormiva nella seconda. Qualche volta ci dormiva anche mia madre, altre volte lei dormiva sul divano in salotto. Solo quando me ne andai di casa cominciai a domandarmi perché non dormisse nello stesso letto con papà. Dovevano pur aver avuto dei rapporti fisici: insieme avevano messo al mondo sette figli. Ma fra loro non c’era traccia di romanticismo, nemmeno quando diventai abbastanza grande per notarlo; non li avevo mai visti baciarsi, nemmeno sulla guancia. Non sembravano molto uniti; il loro sembrava quasi più un accordo di tipo pratico. Non ricordo neanche di averli sentiti parlare mai molto, al di là delle tipiche domande e risposte della vita di tutti i giorni.
Balbir era quello che godeva di tutte le attenzioni di mia madre. Veniva trattato in modo completamente diverso da noi ragazze. La mamma gli preparava il cibo e lo incoraggiava a mangiarlo, era lei che gli lavava i vestiti, mentre da noi ci si aspettava che ci arrangiassimo a lavare i nostri, a tenere in ordine le nostre uniformi e a preparare qualcosa da mangiare quando avevamo fame.
Non ci sedevamo mai tutti insieme a tavola. La mamma ci lasciava una grande pentola piena di curry sul fuoco, tipo «servitevi e andate a mangiare davanti al televisore». Noi ci mettevamo lì a gambe incrociate con i piatti in bilico in grembo. Avevamo un televisore in bianco e nero ma da piccole, per fare finta che fosse a colori, attaccavamo allo schermo gli involucri di plastica trasparente delle bibite.
Avevo circa sette anni quando cominciai a chiedere perché per Balbir fosse tutto così diverso. Perché lui può uscire da solo e noi no? Perché io devo imparare a cucinare e lui no? Poi cominciai a fare domande su altri aspetti della nostra vita. Se i sikh pensano che siamo tutti uguali, perché noi guardiamo dall’alto in basso le persone che appartengono a una casta inferiore?
Proprio vicino a casa nostra c’era un gurdwara, il che per mia madre era molto importante, perché nutriva una fede molto forte. La nostra vecchia casa ora è stata abbattuta, ma il gurdwara è ancora lì, un imponente edificio di mattoni rossi con cupole argentate e sgargianti decorazioni sulla facciata.
Mia madre usciva di casa alle sei e mezza tutte le mattine, dava da mangiare agli uccellini sulla striscia di prato vicino al gurdwara e poi entrava a dire le sue preghiere prima di andare al lavoro. La sera ci tornava ancora per portare via acqua benedetta da spruzzare in giro per casa. Le mie sorelle e io a quell’ora stavamo guardando Charlie’s Angels e lei ci innaffiava tutte, accendeva bastoncini d’incenso e cantava i suoi salmi.
Il gurdwara era – e per me lo è ancora – il centro di smistamento pettegolezzi locale, dove le donne se ne stavano in piedi riunite in gruppetti, con i loro foulard avvolti attorno alla testa.
«Sapete che il figlio maggiore di Zeeta ha sposato una donna che viene dal Punjab?»
«Avete sentito che la nuora di Hasina ha avuto un’altra femmina? Penso che Hasina si stia davvero pentendo di questa unione.»
«E Zainab Singh? Sua madre l’ha sorpresa alla fermata dell’autobus che parlava con un ragazzo. È successo tre settimane fa e Mira non l’ha ancora lasciata uscire di casa. Le ho detto: “Mira, devi rimproverare solo te stessa. Se le fai frequentare delle ragazze bianche, lei imparerà le abitudini delle ragazze bianche”.»
La cosa peggiore che si possa dire a una ragazza asiatica è che si sta comportando come una bianca. Noi non avevamo il permesso di mescolarci ai bianchi perché la mamma sosteneva che non avessero nessuna morale e nessun rispetto per se stessi. Diceva che i bianchi erano brutte persone con brutte abitudini. E allo stesso modo la pensavano anche tutte le donne che chiamavo “zia” e chiunque altro all’interno della nostra comunità. Crescendo, un ragazzo asiatico poteva divertirsi un po’ con le ragazze bianche – “carne bianca” così dicevano – ma quando arrivava il momento di sistemarsi, la sua famiglia gli trovava una brava sposa asiatica. Se però una ragazza asiatica usciva con un ragazzo bianco era sbagliato e le cose andavano diversamente. I fratelli e gli “zii” della ragazza lo trovavano e lo picchiavano e poi picchiavano anche lei, per aver coperto di disonore la famiglia. E sarebbe stata rovinata; nessun onesto uomo asiatico l’avrebbe mai più voluta. Nella comunità lo sapevano tutti. A otto anni io lo avevo già imparato. Nessuno mi aveva consegnato un manuale con tutte le regole ma io sapevo in che modo ci si aspettava che mi comportassi, camminassi, parlassi e perfino respirassi. Sapevo che bastava una parola sbagliata per rovinare una reputazione.
Vivevamo a Derby, in Northumberland Street. Quando ero piccola avevamo l’abitudine di rimanere in piedi all’inizio della via a osservare la strada. E ci sembrava così lunga. Tutte le porte erano aperte e c’era sempre un gran daffare, la gente non faceva che girovagare di casa in casa. Ora tutta la zona è abitata completamente da asiatici, ma allora era una comunità mista; c’erano asiatici, irlandesi e italiani – Paki, Paddy e Eyetie, come li chiamavano in modo spregiativo gli inglesi –, tutte quelle persone cioè che nessun’altro voleva.
C’era una donna polacca che avevamo soprannominato Miss Stramba e un’altra vicina che chiamavamo Curiosona Parker perché non faceva che sbirciare da dietro le tende. Noi ci divertivamo sempre a bussare alla sua porta e a scappare via prima che aprisse. In cima alla strada c’era una casa disabitata che pensavamo fosse stregata e a noi piaceva girarle intorno di corsa per spaventarci a morte. Non c’erano praticamente macchine così giocavamo a campana sui marciapiedi, saltavamo la corda e ci divertivamo a scappare da un cane irascibile che si piazzava sempre a sedere in mezzo alla strada. All’una sentivamo la sirena della fonderia che avvisava quelli del turno di giorno che era ora del loro pasto.
Mio padre lavorava in fonderia di notte. Aveva trovato quel posto il giorno in cui ero nata io e vi era rimasto fino alla pensione. Durante la settimana, quando tornava a casa la mattina, gli preparavo il tè; dagli otto o nove anni quello era il mio compito, oltre a spazzare le scale. Avevamo tutti dei compiti, a parte Balbir ovviamente. Di pomeriggio, quando tornavo da scuola, svegliavo papà e gli preparavo la cena in un contenitore di metallo che sembrava una torre. Dentro c’erano tre scomparti e in ognuno sistemavo un cibo diverso – curry nel primo, insalata nel secondo e chapati nel terzo. Il curry lo preparava la mamma, ma al chapati dovevo pensarci io.
Impiegavo quasi un’ora per preparare la cena di papà e il suo thermos con il tè. Lo facevo perché adoravo mio padre e per me era un disturbo davvero piccolo. Mi piaceva sedermi accanto a lui mentre beveva il suo tè; a volte gli raccontavo piccoli aneddoti sulla mia giornata, ma più spesso rimanevamo seduti così, facendoci semplicemente compagnia. Una volta finito, usciva per andare al lavoro e io rimanevo in piedi sulla porta ad aspettare che si voltasse e mi facesse un cenno di saluto con la mano. Lo faceva sempre.
Mia madre rientrava un po’ più tardi. Lavorava dove capitava, soprattutto in fabbriche tessili. Portava sempre con sé una grande borsa di plastica intrecciata a fiori e quando tornava a casa le mie sorelle e io ci precipitavamo a frugarvi dentro, perché sapevamo che conteneva sempre qualcosa di dolce o del cioccolato. Lei rideva e diceva: «Prima fatemi almeno entrare a togliermi il cappotto...»; e noi ridacchiavamo e continuavamo a rovistare. Se riuscivo ad avere quella borsa tutta per me, la esploravo accuratamente. Non volevo correre il rischio di lasciarmi sfuggire un cioccolatino. Una volta trovai una bottiglietta seppellita proprio sul fondo e quando le tolsi il tappo e annusai, quasi caddi per terra. Dentro c’erano dei sali che puzzavano terribilmente, ti colpivano la gola e ti facevano riempire gli occhi di lacrime. Mia madre e le mie sorelle avevano pensato che fosse molto divertente.
Quella borsa è il ricordo più allegro che ho della mia infanzia con mia madre. Non ricordo che fossimo mai state molto vicine. Non nel modo in cui lo era mio fratello. Per me, lei era quella che ti rimetteva al tuo posto e che ti rimproverava. Non le piaceva che bighellonassimo in giro o che facessimo troppa confusione e le risate la infastidivano. Continuava a ripeterci: «Non dovreste ridere così tanto, smettetela. Non sapete che il troppo ridere finisce in piangere?».
Di tutte noi sorelle, io ero il maschiaccio; adoravo correre per strada e arrampicarmi sui muri; ma se la mamma mi vedeva, mi richiamava immediatamente in casa e io non osavo mai ignorarla: tornavo dentro subito. «Non ti importa di quello che pensa la gente di te? Vuoi farci vergognare?» mi rimproverava, prendendomi con forza per le spalle e guardandomi in faccia. «Sette figlie da tirare su... questo è il mio destino. Vuoi cercare di rendermelo ancora più difficile? Devi proprio comportarti sempre in modo diverso dagli altri?»
Poiché ero podalica, ero l’unica di tutti i suoi figli che mia madre avesse partorito in ospedale. Aveva dovuto rimanerci per sei giorni e la cosa l’aveva terribilmente infastidita. «Nata con i piedi in avanti, bah!» mi diceva quando era arrabbiata con me. «Sei stata un tipo difficile fin dall’inizio.»
La sua preoccupazione maggiore era che conservassimo il buon nome della famiglia e diventassimo delle brave nuore rispettose, servizievoli e capaci di cucinare. «Venite qui vicino a me davanti ai fornelli e imparate» ci diceva sempre tirando fuori le padelle e il mio cuore sprofondava. Ora ricordo ancora le sue ricette, ma quelle lezioni hanno lasciato dei ricordi spiacevoli altrettanto vividi: le gambe doloranti per tutto il tempo in cui dovevamo rimanere in piedi vicino a lei, la faccia bollente e arrossata dal vapore, il braccio che mi formicolava dove mi aveva colpita perché avevo permesso ai miei occhi di distrarsi. «Nessuna delle mie figlie arriverà impreparata nella casa di sua suocera.»
In casa nostra era mia madre la persona più autorevole. Papà era un uomo molto tranquillo e ascoltava quello che diceva lei. Durante la settimana lavorava per provvedere alla famiglia e poi, nei weekend, andava nel pub locale, il Byron, e si ubriacava. A volte tornava a casa ancora alticcio, si sedeva in salotto e ci chiedeva di cercargli le uova di pidocchio nei capelli. Noi ci radunavano attorno alla sua sedia e lui rimaneva seduto lì a raccontare barzellette e storielle, mentre noi gli passavamo le dita fra i capelli neri e unti, strillando quando ne trovavamo uno e lo schiacciavamo sotto le unghie. Una volta finito lui dava a tutti dieci centesimi di paghetta, che adesso non sembra granché, ma allora per noi era tantissimo. E nonostante i pidocchi, io amavo quei momenti perché eravamo tutti insieme e perfino la mamma sembrava ammorbidirsi un po’. Non si univa a noi, ma si sedeva a guardarci mentre ci affaccendavamo attorno a papà. Era come se la nostra famiglia fosse l’unica cosa importante, mentre per la maggior parte del tempo c’erano sempre altre persone in giro, “zie” e “zii”, e la mamma non faceva che preoccuparsi che ci comportassimo come si deve davanti a loro.
Per lei era molto importante salvare l’apparenza nella comunità. Sin da quando eravamo piccole ci aveva insegnato che non importava quello che accadeva nella tua vita, tu dovevi comunque tenere la testa alta e ostentare una facciata perfetta. Mia madre pensava che confidare un problema significasse farlo diventare argomento di conversazione per tutti i pettegoli del gurdwara. Molto meglio mantenere il segreto, così nessuno poteva giudicarti o umiliarti.
Ogni tanto, il sabato, andavo con mio padre nel suo orto. Ci andavamo solo noi due perché a tutti gli altri non interessava. Aveva un grande cancello di metallo arrugginito e io saltavo giù dalla macchina per correre ad aprirlo, così che mio padre potesse entrare. C’erano patate, cipolle, aglio, zucche e lui mi mostrava come innaffiarli e legarli. Io lo osservavo mentre lavorava la terra fra le dita con un’espressione distante. Qualche volta cominciava anche a cantare sommessamente fra sé e sé.
Quando aveva finito, si sedeva sulla sua sdraio a fumare una sigaretta. Di solito teneva una lattina di Tennent’s nella tasca del cappotto. E dopo averla bevuta diventava più ciarliero. Io mi sedevo accanto a lui sull’erba ad ascoltare mentre mi raccontava della sua fattoria nel Punjab e del grande albero ombroso al centro del suo paese, Kang Sabu, dove lui e gli altri uomini avevano l’abitudine di sedere alla fine della giornata.
«E io mi sarei seduta vicino a te, come faccio qui?» gli chiesi un giorno. Conoscevo la risposta, avevamo già fatto quella conversazione molte volte, ma io mi stavo godendo il momento, avere papà tutto per me. Gli appoggiai la testa sulle ginocchia e lasciai che la sua voce morbida e bassa si riversasse su di me, riempiendomi la mente di immagini esotiche sulla vita che avrei potuto condurre.
«Santo cielo, no. Di giorno, una volta terminati i tuoi lavoretti, avresti giocato sotto l’albero. Anzi, mi ricordo che c’era una fune che penzolava da uno dei rami; se non sbaglio era stato Govind, il figlio di Dalbir, ad arrampicarsi lassù per legarla. Si arrampicava come una scimmia quel ragazzo. Voi bambini avreste potuto giocarci di giorno, ma alla sera l’ombra sarebbe stata per gli uomini, era lì che ci rilassavamo e, in caso di necessità, discutevamo le questioni del villaggio. Il vostro posto sarebbe stato con le donne. Tu avresti tenuto d’occhio Lucy o avresti aiutato tua madre a macinare il grano. Ricordo Bachanu, avrà avuto solo cinque o sei anni, che trascinava una sedia di legno fino al bidone di grano alto il doppio di lei e cercava di arrivare dentro con la paletta. Voleva essere come le ragazze più grandi e aiutare la sua mamma.»
«Ma non poteva aiutare con l’acqua, vero papà?»
«No, putt. L’anfora che vostra madre portava alla fonte sarebbe stata troppo pesante per voi ragazzine, era fatta di bronzo, sai. Se fossimo rimasti, ora Ginda e Yasmin avrebbero potuto farlo, forse anche Robina, ma tu avresti dovuto crescere abbastanza per poterla trasportare come si deve, sollevandola sulla testa senza rovesciarne neanche una goccia.
L’acqua là era molto preziosa. Non come qui, dove apri il rubinetto e a nessuno importa se scorre inutilmente. A casa, dovevamo trasportare ogni singola goccia d’acqua che ci serviva e nemmeno i campi venivano irrigati come quelli dei tuoi zii adesso. Gli impianti di irrigazione sono stati installati due anni dopo la mia partenza e ti garantisco che la cosa ha aiutato parecchio. Ho letto che la produzione è andata alle stelle con tutta quell’acqua.»
La sua voce si era fatta sognante adesso, e sebbene potessi ancora sentire la sua mano sulla nuca, capivo che con la mente stava viaggiando a chilometri di distanza da me. Era tornato sotto quel grande albero ombroso insieme ai suoi compagni.
«Sai, credo che uno dei tuoi zii abbia anche un trattore adesso. Un trattore automatico, ci crederesti? Noi dovevamo arrangiarci con gli aratri trainati dai buoi. Avevo dei buoi eccellenti allora, ma uno, ragazzi, era la creatura più testarda e ostinata che fosse mai venuta al mondo e per guidarlo mi sono quasi spezzato la schiena.»
«Ti piaceva là, papà, vero? Perché non sei rimasto?»
Questa parte della storia mi rendeva sempre un po’ triste. Mi immaginavo la grande nave che aveva portato papà dal Punjab fino a Liverpool. Lui e gli uomini degli altri villaggi lì attorno che partivano con addosso i pantaloni e le camicie di cotone inamidato, gli occhi stretti contro il sole accecante per salutare con la mano le loro famiglie ferme sulla banchina.
La nave si era allontanata in mare aperto fra sbuffi di vapore, e non appena l’India era diventata solo un ricordo perso oltre l’orizzonte, mio padre aveva cominciato a svegliarsi infreddolito, pensando che ogni giorno fosse più buio di quello precedente.
Non lo diceva mai, ma credo che per lui sia stato difficile aggrapparsi alla speranza mentre rimaneva in piedi a rabbrividire sul ponte in mezzo all’oceano. In precedenza mi aveva raccontato che, per tirarsi un po’ su, lui e gli altri uomini ballavano la bangrha, una sfrenata danza tradizionale con la quale di solito si festeggia il raccolto. Non riuscivo a immaginarmelo. Con addosso i suoi monotoni vestiti marroni sembrava così serio e quieto. Non riuscivo nemmeno a immaginarmelo con gli orecchini, eppure aveva i buchi alle orecchie.
«Perché sei venuto qui, papà?» Gli urtai la punta della scarpa per spronarlo a raccontarmi il seguito della sua storia.
«Erano gli anni Cinquanta, le cose stavano cambiando, è sempre importante tenersi aggiornati. Io non volevo che nessuno della mia famiglia fosse costretto a guidare un aratro trainato da buoi per tutta la vita; per le mie figlie sognavo qualcosa di più che l’ingrato compito di trasportare anfore piene d’acqua sulla testa. Inoltre, il governo britannico ci stava chiedendo di venire qui, avevano bisogno di manodopera e ci offrivano condizioni vantaggiose. Avremmo avuto una vita meravigliosa, così dicevano.»
Ma quello che mio padre aveva scoperto quando era arrivato qui non era affatto così meraviglioso. All’inizio aveva diviso una casa con altri uomini asiatici. A volte arrivavano ad ammassarsi fino in dodici nella stessa stanza. Facevano fatica a trovare un posto dove vivere perché i padroni di casa non volevano affittare; c’erano cartelli che gridavano «NIENTE IRLANDESI, NIENTE NERI». Erano arrivati aspettandosi di essere i benvenuti e invece erano stati accolti da tanta ostilità. Quando entravano nei pub o nei negozi, la gente smetteva di parlare e li fissava. Una volta, a mio padre ordinarono di scendere dall’autobus perché era un paki. Non c’è da sorprendersi che rimasero attaccati gli uni agli altri.
Molti vivevano vicino a noi a Derby. Ed è lì che arrivò anche mia madre, quasi sette anni dopo mio padre. Lo aveva sposato che aveva solo quindici anni; le era stato imposto di farlo quando la prima moglie di papà, che era anche sua sorella maggiore, era morta per il morso di un serpente. Q...