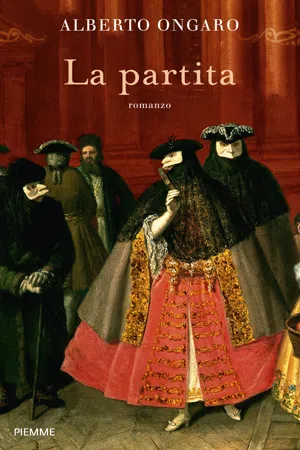![]()
ALBERTO ONGARO
LA PARTITA
![]()
Comincerò dal lontano mattino del mio ritorno a Venezia da Corfù dove gli Inquisitori della Repubblica, con discutibile decisione, mi avevano mandato per punirmi dell’eccessiva violenza con cui avevo reagito a una offesa subita.
Faccio soltanto questo breve accenno al mio soggiorno in quell’isola perché mi preme metter piede al più presto sul molo degli Schiavoni dove questa storia ha il suo inizio.
Dunque. Era un mattino di gran freddo e la galeazza Daniele Soranzo, che aveva risalito l’Adriatico quasi sempre in tempesta, si stava avvicinando alla innevata isola guardiana del Lido oltre la quale avrebbe trovato la quiete della laguna.
Dall’alto del ponte dove ero salito assieme al capitano Gianmarco Micene da Zara potevo vedere lontano le bocche del porto e uno stormo di gabbiani che ci venivano incontro come se volessero portare un saluto o un messaggio.
Erano – me ne avvidi quando giunsero alla nostra altezza – gabbiani più spauriti di quel che ricordavo, spennacchiati e febbrili, come rosi da un oscuro contagio e non gli uccelli dall’aristocratico volo che prima della mia partenza popolavano le barene della laguna e ne solcavano il cielo. Non portavano né saluti né messaggi ma lanciavano alte strida incattivite come se volessero coprirci di insulti o accusarci di orribili colpe.
«Hanno fame» disse il capitano Micene.
Lo guardai sorpreso, non per quel che diceva, ma perché in tanti giorni di viaggio e sebbene sedessimo alla stessa mensa per il pranzo del mezzogiorno e per la cena della sera, non lo avevo mai sentito rivolgere primo la parola a uno dei suoi passeggeri: solo ora che stavamo arrivando quel tetro anfitrione diventava loquace.
«Stanno morendo di fame» precisò «ed è ben strano, signor Sacredo, che abbiano fame perché la laguna d’estate e d’inverno ha sempre provveduto a nutrirli.»
A un tratto, quasi a conferma delle sue parole, un gabbiano interruppe con un grido di strega il suo volo e precipitò come un sasso spezzandosi le ali sul ponte.
Guardai quel corpicino scheletrico coperto di penne ammalate e subito mi prese un senso di angoscia, la paura che il mio ritorno sarebbe stato privo di quella gaiezza sulla quale avevo contato, quasi il presentimento di una imminente sciagura.
«Bisognerà fare qualcosa» disse il capitano.
Lanciò un grido di richiamo e al marinaio che accorse ordinò di buttare in mare il pane raffermo, le gallette ammuffite, gli stoccafissi affumicati eventualmente rimasti in cambusa e che, presumibilmente, una volta messo piede a terra, nessuno avrebbe preteso.
Non starò a raccontare l’ingordigia con la quale i gabbiani si avventarono sul cibo, la lotta efferata che scoppiò fra di loro e li trasformò in pochi istanti in selvaggi uccelli da preda. Non era la loro vicenda che mi interessava ma il suo significato: c’era la fame a Venezia? Oppure qualche orribile peste aveva ucciso i pesci della laguna, decimato i molluschi e gli insetti, fatto marcire le dispense cittadine, inquinato i canali?
Nessuna notizia in tal senso era pervenuta a Corfù, ma questo non escludeva che qualcosa di grave fosse successo dopo la nostra partenza e che, nelle settimane durante le quali noi avevamo risalito l’Adriatico, la situazione fosse precipitata.
Stavo per abbandonarmi alle congetture meno allegre quando – eravamo ormai entrati nel canale che unisce il mare alla laguna – il mio sguardo intravide lontano un biancore, un lucore di specchio che non potei riconoscere per quello che era e di cui capii soltanto, con una sorta di disorientata sorpresa, che innanzi tutto era qualcosa che non ci sarebbe dovuto essere.
Lanciai un’occhiata al capitano Micene pensando di scorgere in lui i segni della mia stessa sorpresa ma quel che vidi fu soltanto il viso di pietra che avevo visto davanti a me tante volte durante il viaggio. O il capitano aveva capito di che cosa si trattava o non se ne dava pensiero.
Cambiai posizione, salii inutilmente la scala che portava al ponte superiore e infine mi arrampicai su una sartia fino a raggiungere un punto dal quale potevo vedere il fenomeno in tutta la sua ampiezza e riconoscerlo: la laguna stava gelando, banchi di ghiaccio mai visti prima, nemmeno negli inverni più rigidi, sembravano essere saliti dal profondo di quelle acque familiari e ora galleggiavano come spettrali flottiglie.
La corrente che veniva dal mare attraverso le bocche di porto e il vento pannonico spingevano i banchi l’uno verso l’altro e, in certi punti, dove l’incontro era già avvenuto, i tratti gelati avevano raggiunto la vastità delle più grandi piazze cittadine.
Anche i marinai al lavoro in coperta avevano notato quel che stava accadendo in laguna e ne commentavano la singolarità con grida dettate più dalla stizza che dalla meraviglia, come a dire che ci mancava anche questa dopo tutte le pene sofferte durante il viaggio.
Bisognava far presto. Bisognava raggiungere la città prima che la lastra di ghiaccio costringesse la galeazza a fermarsi.
Cominciarono a risuonare da un punto all’altro della nave ordini concitati immediatamente seguiti da febbrili manovre e, per lunghi minuti, mentre gli altri passeggeri (pochi e troppo insignificanti perché qui se ne parli) salivano sul ponte, la nave fu tutta un grido, uno sbattere di vele, un cigolio di sartiami.
Fu presto abbastanza chiaro che ancora si poteva passare: lì dove l’incontro fra i banchi di ghiaccio non era ancora avvenuto appariva una rete di disordinati canali, un labirinto dal disegno mutevole in fondo al quale, se ci fossimo affrettati ad affrontarlo, c’era l’approdo sicuro della città.
Ripeto: non avevo mai visto niente di simile e la laguna che andava chiudendosi, le abitualmente selvagge piante del Lido ora addomesticate dalla neve, le isole dei frati dei disgraziati dei matti dei contagiosi immote e assediate dal ghiaccio offrivano alla vista uno spettacolo di sconvolgente bellezza.
Ma io ero inquieto. Era come se, in mia assenza, Venezia si fosse spostata più a nord per qualche miracolo e da città di acque temperate fosse diventata un’isola baltica o un fiordo di quel continente dell’estremo settentrione che si dice perennemente gelato.
Non era di buon auspicio, mi dicevo, essere ricevuto da una patria così mutata: quel suo insolito aspetto poteva nascondere qualcosa che non mi sarebbe piaciuto o quanto meno annunciare che la città avrebbe assunto nei miei confronti un freddo e indifferente contegno. Considerazioni irritanti cominciarono ad assalirmi, pensieri fastidiosi, destinati, pareva, a guastarmi la gioia del ritorno.
Ignoravo se la notizia del mio arrivo mi avesse preceduto e se potessi far conto sulla presenza di qualcuno che mi aspettasse sul molo. Mi lusingavo che Lucrezia D. e Marianna G., di cui mi ero invaghito durante il loro soggiorno a Corfù, mi aspettassero magari mascherate in qualche bottega di caffè della riva dove avremmo attraccato e che in quello stesso momento stessero spiando la laguna con la speranza di veder spuntare la nave.
Sapevo che ciò non era possibile e tuttavia non riuscivo a togliermi dalla testa l’immagine di due aristocratiche mascherine in attesa in un ambiente per lo più frequentato da arsenalotti e schiavoni. Qualcuno tentava di avvicinarle ma arretrava intimidito dallo sguardo di fuoco che saettava da dietro la bautta. Erano state le ultime amiche, le più recenti braccia amorevoli tra le quali il mio corpo esiliato aveva trovato conforto. Dopo di loro non era accaduto più nulla che meritasse ricordo...
La nave intanto aveva infilato uno dei canali dalle sponde di ghiaccio e si dava da fare per non restare incagliata. Virava a destra e a sinistra mentre marinai incanagliti bestemmianti urlanti tenevano a bada con lunghi remi quelle lastre tombali che si andavano addensando all’intorno.
Lontano, qua e là, si vedevano navi e barche da pesca rimaste prigioniere del ghiaccio, bragozzi dalle vele abbassate, burchi e burchielli ormai arresi, gli equipaggi al riparo sotto coperta.
Ovunque si guardasse la laguna sembrava avere l’immobilità delle quinte da teatro o dei dipinti appesi alle pareti dei palazzi, una immobilità così insolita da darmi una sensazione di perplessa incredulità come se quello che vedevo non fosse vero ma facesse parte di una lontana mattina d’inverno che qualcuno un tempo mi aveva raccontato e di cui soltanto ora mi ricordavo.
Attraccammo alla riva delle galeazze qualche ora dopo il nostro passaggio attraverso le bocche di porto. Attraccammo giusto in tempo: ancora pochi minuti e un precipitoso inasprirsi del freddo avrebbe fatto rabbrividire mortalmente le acque e le avrebbe chiuse del tutto.
Vidi subito che, sul molo, a parte i soliti scaricatori e i funzionari della dogana non c’era nessuno di cui si potesse dire che aveva aspettato con ansia l’arrivo della nave e dei suoi passeggeri; nessuna delicata mascherina, nessuna preziosa gentildonna avvolta in pesante mantello spiava dalle vetrine delle botteghe che guardavano il molo, nessuno della mia famiglia, né parente né servo, che accorresse gridando il mio nome.
Eppure a Venezia l’arrivo di una nave, di una qualsiasi nave appartenente alla marina della Repubblica o anche straniera, veniva abitualmente salutato, se non con grida festose e salve di cannone, con quei segni che bastano a spiegare l’animo benevolo con il quale l’evento viene accolto dalla città e a mettere a proprio agio il viaggiatore che arriva.
Nulla di tutto ciò stava invece accadendo. Solo l’indifferenza ci aspettava sul molo. Forse, pensai, era quell’insolito gelo polare a tenere lontani quei segni dal porto, ma dentro la città, fra le case, nelle calli, nelle piazze li avrei ritrovati.
Presi i miei bagagli, feci un cenno di saluto al capitano Micene e ai miei compagni di viaggio e sbarcai. Non che avessi una gran fretta di andare a casa e di rivedere mio padre con il quale non ero mai stato in rapporti affettuosi. Mancavo da Venezia da tredici mesi, e stranamente, più che vedere qualcuno, quel che desideravo era essere visto e salutato come chi ha vissuto una esperienza un po’ insolita, una persona che rincasa da altrove.
Ma non c’era nessuno nelle livide strade cittadine che dimostrasse qualche interesse per me. Gente infagottata mi passava accanto senza vedermi, diretta in gran fretta chissà dove, come inseguita. Io pensavo che, anziché di mattina, sarei dovuto arrivare con il buio, all’ora in cui i patrizi veneziani escono di casa per radunarsi nelle botteghe di caffè a ciarlare, a giocare, a sparlare del prossimo o a intessere quegli intrighi libertini che hanno reso la città famosa nel mondo.
Era un vero peccato, ad esempio, che non fosse quella l’ora migliore per entrare al caffè delle Rive o al Florian e farmi vedere in buona salute dalle giovani signore della cui benevolenza godevo e anche, e soprattutto, da chi nutriva verso di me sentimenti di altra natura e aveva applaudito alla decisione dei giudici di relegarmi per tredici mesi a Corfù.
Ero perfettamente consapevole della frivolezza dei miei pensieri ma ero anche ben lontano dal condannarli. Perché, lo ammetto senza riluttanza, io ho sempre avuto il più grande rispetto per la frivolezza che considero come una sorta di richiamo sul vuoto, un delicato disegno sullo sfondo del nulla.
All’uomo che aveva preso i miei bagagli dissi di dirigersi verso palazzo Sacredo di Santa Fosca ma di far sosta in merceria San Giuliano dove un cioccolato bollente mi avrebbe ripagato del freddo.
L’uomo mi lanciò uno sguardo stranito, sembrò sul punto di dirmi qualcosa poi cambiò idea e prese a parlarmi del gelo, del ghiaccio che in pochi giorni aveva interamente coperto la laguna. C’erano, disse, grosse difficoltà di comunicazione con la terraferma e con le altre isole. Molte barche che portavano frutta e verdura e altre derrate non erano riuscite a salpare o erano rimaste bloccate dal ghiaccio appena partite. Con grande disperazione, aggiunse, della Confraternita dei Fruttaroli e di quella dei Macellai di San Giobbe.
Non si era mai visto niente di simile tranne forse nel secolo passato quando, a stare a quello che raccontavano i vecchi, la laguna era gelata da un capo all’altro nel giro di una notte.
Io lo ascoltavo distrattamente. Continuavo a cercare nella gente che passava qualche segno che indicasse che ero stato riconosciuto, uno sguardo curioso, una voce che sussurrasse il mio nome. Ma era inutile. La strada sembrava occupata da sconosciuti solitari e selvatici. Alzai le spalle. Non era poi così importante. Non era il caso di prendersela se il mio arrivo non aveva la pienezza che avevo sperato.
Poco dopo entrai nel caffè al Tricorno che un tempo ero solito frequentare e che era noto in tutto il territorio della Repubblica per le sue porcellane e per lo splendore dei suoi vasellami d’oro massiccio e d’argento, dei quali si diceva che fossero il frutto del mercimonio che il proprietario, tale Busetto, aveva fatto della bellissima moglie.
Fu qui che ricevetti il primo saluto. Uno dei garzoni, il più anziano e autorevole che lavorava nella bottega da un maggior numero di anni di quanti potessi ricordare, mi venne incontro con aria di lieta sorpresa dandomi il benvenuto.
«Sapevo» disse «che eravate stato mandato a Corfù. Mi fa piacere rivedervi in buona salute. C’è bisogno di gente allegra da queste parti. Spero non ve la siate passata poi tanto male.»
Gente allegra? Mi si continuava dunque a considerare, sia pure nel ricordo, come una persona allegra la cui presenza è richiesta e di cui si avverte l’assenza. Sorrisi grato al garzone e lasciai cadere nella tasca del suo grembiule una moneta d’argento. Si inchinò.
«Avete sentito che freddo?» domandò poi. «Dicono» proseguì «che a Murano vi siano case incrostate di ghiaccio come se ne vedono in Russia. Finestre inchiodate, porte che non si aprono, gente che muore assiderata per mancanza di legna.»
Fece una pausa.
«Avete già visto vostro padre?»
«No» dissi «sono appena arrivato.»
E indicai il facchino che aspettava con i bagagli fuori della porta.
Nel girarmi incrociai lo sguardo di un uomo seduto a un tavolo non distante dal banco sul quale il cioccolato mi era stato servito. Era uno sguardo difficile a definirsi ma che sicuramente aveva qualcosa di malevolo e ottuso e anche, non so come dirlo, divertito da ciò che stava osservando. Nessun dubbio che quell’uomo guardasse me, che fossi io a suscitargli i sentimenti di volgare ironia che gli leggevo sul viso, anche se mi riusciva difficile capire da che cosa li ricavasse e quale legame vi potesse essere fra noi.
Sostenni il suo sguardo per qualche momento poi gli voltai le spalle con ben simulata indifferenza e ripresi a sorbire il cioccolato che assicurava un po’ di benessere al mio corpo intorpidito.
Ma non ero del tutto indifferente: per quanto grossolano quello sguardo sembrava sapere di me più di quanto ne sapessi io, alludeva a qualcosa che forse era accaduto in mia assenza e di cui ero stato tenuto all’oscuro.
Ma al diavolo! Posai la tazza, lasciai alcune monete sul banco e uscii dalla bottega.
Mentre la porta si chiudeva sentii alle mie spalle un trepestio di piedi: anche lo sconosciuto si era alzato e si affrettava a uscire. Ripresi a camminare verso casa perplesso, seguito a breve distanza dal facchino e da quella specie di animale malevolo che mi aveva preso di mira.
Non lo vedevo ma lo sentivo trotterellare alle mie spalle con un che di allegro nel passo. All’improvviso, mentre mi chiedevo se fosse il caso di affrontarlo subito o di aspettare da parte sua qualche segno più esplicito, me lo vidi sfrecciare al fianco e precedermi di corsa verso un ponte poco lontano.
C’era parecchia gente adesso per la strada e, ai piedi del ponte, c’era un gruppo di persone intabarrate che discutevano fra loro. L’uomo gli passò in mezzo, salì di corsa i gradini e, quando fu in cima al ponte, prese a fare frenetici segni verso di me.
«Guardatelo» lo sentii gridare mentre, sgomento, mi avvicinavo. «Guardate il figlio del nobiluomo Sacredo. Ha un aspetto magnifico. Veste come un gran signore, ha appena bevuto un cioccolato nella bottega più cara di Venezia. Ha lasciato anche una mancia al garzone! E intanto la sua famiglia sta andando in rovina. Suo padre è pieno di debiti e andrà pres...