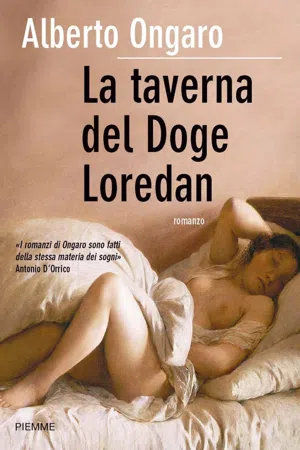![]()
Sempre più spesso nel luogo dove mi trovo un uomo senza volto mi compare davanti e mi si ferma accanto sempre più a lungo di quanto io possa sopportarlo. È un uomo alto e asciutto, vestito con eleganza, una lunga stretta redingote di velluto nero liscia e senza pieghe, pantaloni attillati dello stesso colore e dello stesso tessuto della giacca, camicia di seta bianca, scarpe con fibbie d’argento, un tricorno fuori moda che in parte copre la superficie vuota e piatta del suo viso. Non so se l’uomo in carne ed ossa di cui io qui presento soltanto il simulacro sia mai stato vestito in questo modo: io non l’ho mai visto a fin dal giorno in cui, ahimè, ebbi la certezza della sua esistenza mi accadde di attribuirgli l’atteggiamento e le vesti, se non il viso del resto nascosto dal cappello, del gentiluomo arrogante che rientra a casa dopo una notte di baldoria in uno dei dipinti chiamati Il Cavaliere di William Beckford, che fu buon amico di mio nonno e le cui opere furono appese per molti anni nella pinacoteca della mia famiglia prima di essere vendute alla National Gallery. Poiché gli ho fatto capire molte volte che farei volentieri a meno della sua compagnia lo sconosciuto ha, soprattutto negli ultimi tempi, raddoppiato la frequenza delle sue visite dicendo che se egli deve essere considerato una ossessione come tale deve comportarsi, che non si può pretendere da una ossessione una condotta da gentiluomo discreto e ragionevole e che quindi è suo dovere cogliermi di sorpresa quando meno me lo aspetto, infilarsi nei miei pensieri quando cerco di pensare ad altro, invadere la mia memoria quando tento di dimenticare. La sofferenza che le visite di questo vellutato fantasma mi danno moltiplica con risultati maligni la frustrazione di non essere riuscito a sapere qualcosa di più sul suo conto, di non conoscere il suo nome, di non poter immaginare del suo viso che una specie di macchia di gesso semicoperta da un tricorno. Di lui so infatti ben poco. Di lui so soltanto, per averne sentito parlare una sola volta e per pochi minuti che è un gentiluomo veneziano di bell’aspetto e di ricca famiglia, che ama sopra ogni cosa al mondo e ne è riamato quella che nel dialetto del suo paese viene chiamata la Mona, che possiede a Venezia una elegante palazzina dalle stanze adorne di preziosi oggetti orientali e africani e di molte altre testimonianze dei suoi viaggi e che pure dispone di una villa nella campagna veneta dove, suppongo, porta le giovani signore che grazia e fortuna gli consentono di sedurre. Nient’altro. A parte naturalmente ciò che ha fatto di lui la mia ossessione e l’oggetto del mio odio più profondo e cioè essere egli l’uomo che più di ogni altro ha contribuito alla mia rovina proprio nel momento in cui mi pareva di esserne più lontano, il profanatore di un tempio che mi era sacro, l’ultimo fra coloro che saccheggiarono qualcosa che mi apparteneva e ne godettero. Comincio a raccontare la mia storia parlando di quest’uomo sia perché è qui accanto a me per una delle sue solite visite, indifferente al fatto che io stia scrivendo o forse addirittura curioso di sapere quello che scriverò, sia perché il punto di partenza della memoria di un passato che è stato felice è sempre l’infelice presente.
Il luogo è una palazzina sul rio di San Felice ai piedi del Ponte del Molin della Racchetta, sul lato sinistro del canale per chi vi arrivi dalla laguna e dalla parte opposta a quella della chiesa. La palazzina appartiene a Schultz tipografo-editore di discreto nome locale (suoi sono ad esempio i libri Lettere di Marinai della Repubblica Veneta, Mercanti greci in piazza San Marco, Celebri imbroglioni di Rialto e di lui sono stati annunciati già da qualche tempo una Storia dei Casini Veneziani e il varo di una collana di romanzi popolari) ed è un edificio che ha più di qualche secolo alle spalle, non alto, di struttura orizzontale più che verticale, con un lungo porticato di marmo detto del “Tagliapietra” su cui appoggia il peso della facciata principale, le strette finestre ad arco, il balcone, un insieme di vuoti che sostengono il pieno come diceva il professor Fiocco, buonanima padovana della Facoltà di Lettere. È una sera di inverno fra le sette e le otto. Nella palazzina che ha certamente conosciuto tempi splendidi e che conserva ancora una certa corrosa dignità ci sono due luci accese: quella cruda e gialla dello scantinato dove si trovano le macchine tipografiche della ditta e quella ombrata dell’ufficio di Schultz al primo piano, un’ampia stanza dalle pareti quasi interamente coperte di libri di ogni genere e di ogni epoca, una stanza di sapore antico come è del resto antica l’intera palazzina che Schultz ha ereditato da uno zio e che conserva ancora le tracce di quello zio e di altri zii e nonni e prozii e bisnonni, su su fino al 1816, l’anno in cui gli Schultz, viennesi, arrivarono a Venezia come funzionari della amministrazione austriaca e vi rimasero. Ci sono divani di cuoio scuro, grandi contenitori di metallo, un quadro del pittore Favaretto, raffigurante il carnevale veneziano sistemato in uno spazio fra due scaffali della libreria, qualche maschera africana ed orientale, una massiccia scrivania ingombra di carte dalle quali emerge incongruo, quasi sconveniente, un telefono rosso di modernissimo disegno. Quanto a lui, Schultz, è un uomo alto sui quaranta, quarantacinque anni, di capelli e occhi chiari, la pelle scura di chi ha fatto per molti anni vita all’aria aperta, un corpo asciutto di quelli che hanno l’incomparabile fortuna di restar tali per una vita intera. Schultz veste a piacere di chi se lo immagina, ma per chi voglia indicazioni più precise si suggerisce, dal basso all’alto, questo abbigliamento: scarpe di camoscio con la suola di para, pantaloni di velluto a coste blu o marroni, maglione con il collo alto pure a coste blu o marrone oppure a coste soltanto i pantaloni e non il maglione o viceversa. Schultz è comunque un uomo che non corrisponde affatto all’idea che ci si può fare di un piccolo editore veneziano e che, eventualmente, più che assomigliare a quel che è assomiglia a quel che è stato: un ufficiale della marina mercantile con una lunga esperienza di navi da trasporto e petroliere, abituato ad avere a che fare con marinai e stivatori, e che tale avrebbe probabilmente continuato ad essere se un giorno non gli fosse capitato qualcosa di cui è meglio tacere ora e parlare più tardi. Schultz non è solo, con lui c’è un altro uomo sui quaranta, quarantacinque anni, anch’egli di capelli e occhi chiari, la pelle scura di chi ha fatto per molti anni vita all’aria aperta, qualcuno che nel corso di questa storia potrà essere chiamato in vari modi, il socio, l’inquilino, l’altro o, più spesso, Paso Doble, per una sua nota passione per la danza e che abitualmente accetta di essere chiamato in qualunque modo lo si chiami purché non gli si chieda mai chi esattamente sia e che cosa stia facendo in quella casa.
Schultz passeggia in su e in giù per la stanza, si ferma davanti alla finestra, guarda macchinalmente fuori quasi senza vedere la facciata della chiesa illuminata da una lampada. Allora, dice non proprio una domanda, ma l’inizio di un discorso. Allora cosa? Quelle bozze, dove sono? Oh, dice Paso Doble, quelle bozze, quelle bozze, perché te la prendi tanto? Le ho nascoste, le ho chiuse in uno dei miei cassetti più segreti. Sabotaggio. Ricompariranno quando non ne avrai più bisogno. Sai che in questa casa non va mai perso nulla. Schultz si volta. Questa sì che è buona, dice lo sguardo sorpreso di chi non ha mai sentito sfacciataggine più grande. Fa un rapido calcolo: il passaporto, la patente, una penna d’oro, un prezioso idolo papua dagli occhi di conchiglia ritrovato chissà come mentre se ne andava alla deriva in un canale e poi sparito un’altra volta, il portafoglio con centocinquantamila lire, le chiavi della casa di campagna, la bussola, ricordo di quando navigava, le copie fotostatiche dei documenti della Libreria Marciana da cui ha ricavato la Storia dei Casini Veneziani, tutto questo gli ha nascosto l’altro in pochi mesi ed ora anche le bozze dei medesimi Casini. Eh, be’, Paso Doble dice allegramente. Mi sei antipatico. Lo sai quanto mi sei antipatico. Non è una novità. Soprattutto nei giorni dispari. A volte ti prenderei per il collo e ti sbatterei la testa contro il muro. A volte vorrei che fossi morto. Un desiderio colposo come quello che confessa Falstaff alla signora Ford. Non che ti odii, bada. Al contrario. Ma, ripeto, non mi sei simpatico. Non posso farci nulla… Mi fa piacere, dice Schultz incassando senza batter ciglio. Si avvicina alla scrivania, sposta qualche libro, mette assieme qualche foglio. Una tua eventuale simpatia mi metterebbe in imbarazzo. Come dice mio padre certa gente è meglio averla contro che a favore. E adesso tira fuori le bozze prima che ti spacchi la faccia… L’altro fa un cenno con la testa. Aspetta, dice, aspetta. Prima devo dirti una cosa, un paio di cose, oh non tante, due o tre cosette. Schultz lo guarda da dietro il tavolo dando le spalle alla finestra. È davvero un bel tipo di capitano di marina (mercantile) Schultz, niente affatto guastato dagli anni di servizio né da quelli di comando passati a bordo del “Ramona” spensierata petroliera battitrice degli oceani. È calmo, ironico, autorevole quanto basta. Avanti, dice, sto aspettando. Quanti anni sono passati?, domanda l’altro, quattro o cinque? Comincia a muoversi per la stanza senza guardare Schultz. Quanti dalla sera che lo abbiamo incontrato su quel ponte e abbiamo fatto quattro passi assieme? Li hai mai contati? E se li hai contati davvero ti meravigli di avere un sabotatore in casa? Un’intera compagnia di guastatori è quello che ti meriti! Un attentato qua, un altro là… Schultz si mette a ridere. Di che cosa stai parlando sanguisuga? Hai capito benissimo di che cosa sto parlando, dice l’altro fermandosi di colpo. Berengo, l’avvocato, il principe del Foro veneziano. L’ho visto stamattina. Schultz fa con la mano un gesto rassegnato. Lo so, lo so, dice piano. Sta ancora aspettando una tua telefonata. Lo so, lo so, ripete Schultz. E va tutte le sere “Ai Senza Famiglia” sperando che anche tu ci vada. Pensa un poco. Ed è stato anche senatore. Riprende nervosamente a camminare lungo gli scaffali della libreria, si ferma sotto il Favaretto, torna indietro. Allora?, riprende, hai fatto questo calcolo? Schultz alza le spalle. Che ne so, dice, ho perso il conto. E poi che importanza vuoi che abbia? Che gli anni siano quattro o cinque non fa alcuna differenza. L’altro lo guarda con espressione incerta fra l’irritazione e la sorpresa. Per te forse, dice, non per chi aspetta una tua telefonata. Finirai come il gobbo Massariol che ci ha messo vent’anni a rispondere a una tua lettera. E quelli fermi, inchiodati al muro come farfalle imbalsamate…
Schultz torna a voltarsi verso la finestra. Guarda fuori. Stanotte, dice, ci sarà la neve. Poi aggiunge, ne abbiamo parlato tante volte. Io non gli ho mai detto quando lo avrei chiamato e nemmeno che lo avrei fatto. È stato lui a metterselo in testa. Del resto c’è sempre qualcosa che non quadra nei suoi discorsi. Potevano andar bene dieci anni fa o forse, non so, fra altri dieci anni. È difficile coglierne la misura anche se lui è convinto del contrario… Si volta, prende una scatola di sigari dalla scrivania e la infila nel taschino del maglione. Ho fame, dice, vado a mangiar fuori. È tutto qui quello che volevi dirmi? L’altro esita qualche istante come a riepilogare mentalmente le sue ragioni. No, dice poi, c’è ancora un paio di cosette. Sentiamole, dice paziente Schultz. Non c’è più birra nel frigorifero e questo io lo considero come un affronto personale, il caffè non è più quello di una volta e sono stufo di vederti sempre con quei maglioni e quei pantaloni di velluto, questo materiale immondo, stomachevole. Schultz ride ancora. Va bene, dice. Cercherò di provvedere. E adesso dimmi dove hai messo quelle bozze…
Sono in cima all’armadio in camera.
Escono assieme dall’ufficio e si trovano in una grande sala dal pavimento di marmo, con pochi mobili antichi, una lunga fratina, un bureau spagnolo, una cassapanca, qualche altro oggetto qua e là a piacere di chi si prenda la briga di immaginarlo e di collocarlo al posto giusto. È il salone della palazzina attorno al quale gira il resto dell’appartamento, qui si entra e si esce, da qui si va alle altre stanze, la camera da letto, la cucina, il corridoio che conduce ai bagni, l’ufficio, il soggiorno e la camera degli ospiti comunicanti e uniti da un unico poggiolo che guarda sul canale. Attraversano il salone dirigendosi verso la porta di ingresso accanto alla quale, sulla cassapanca, c’è un cappotto di renna con la pelliccia interna. Schultz lo prende e lo indossa mentre l’altro gli gira attorno aggressivo e insinuante. C’è anche tutto il resto?, domanda Schultz. Ma sì, ma sì. Se non proprio tutto quasi. Che non ti venga in mente, continua Schultz posando la mano sulla maniglia della porta, che non ti venga in mente di nasconderle da qualche altra parte. Ne ho abbastanza di giocare alla caccia al tesoro… La porta dà su una scala di marmo che splendidamente scende fino al cortile interno della palazzina, un tipico cortile veneziano con un gran pozzo in mezzo, i muri coperti d’edera e, sospesa a mezz’aria, una lanterna da marina che ne illumina il centro lasciando la periferia nella penombra. Nella zona buia del cortile c’è il massiccio portone nobiliare che conduce fuori, al sottoportico del “Tagliapietra”, snello colonnato di marmo cresciuto sopra il rio e comunicante, attraverso pochi gradini, con il Ponte del Molin della Racchetta e con la calle dallo stesso nome. Dove vai a mangiare?, domanda Paso Doble. Schultz comincia a scendere le scale sollevando sul collo il bavero di pelliccia del cappotto. “Ai Senza Famiglia”, dice, tu non vieni? No, risponde l’altro. Non ho fame. È rimasto in cima alle scale accanto alla porta, alta figura imbronciata contro la luce del salone. Anzi, ho un peso sullo stomaco. In alto, sopra il cortile il buio è come soffuso di una luce grigia, polverosa. Potrebbe cominciare a nevicare da un momento all’altro. E se trovi Berengo? Schultz alza le spalle. Saprò cavarmela in qualche modo, dice. Addio vampiro.
Può una figura come Paso Doble starsene tranquillamente a casa mentre Schultz se ne va a mangiare? Ma sì che può, per una volta, cosa vuoi che sia una volta sola nel corso di una storia che potrebbe essere assai lunga. Del resto non è che a casa se ne stia così tranquillo. Rimasto solo comincia a guardarsi attorno con l’aria di chi ha in mente qualche cosa.
La camera degli ospiti nella casa di Schultz. Penombra. Al centro della camera c’è una poltrona sulla quale è seduta con le lunghe gambe accavallate sotto un cappotto di cammello la statua di cera di una donna bellissima con i pesanti capelli brunodorati raccolti sulla nuca, brunodorati come certi occhi brasiliani gli occhi brunodorate la carnagione e le mani posate sulle cosce, grande la bocca socchiusa in un mezzo sorriso di impressionante realismo un sorriso stranamente senza fissità e senza enigma rivolto a qualcuno che non c’è ma che c’è sicuramente stato e che forse potrebbe esserci ancora, una bellezza aristocratica e zingaresca colta in un momento di grazia e di cui non si capisce bene se sia in attesa di qualcuno o se sia lei aspettata, se sia lei la concrezione dell’attesa di qualcuno. È ferma, raccolta, immota e tuttavia dà l’impressione che potrebbe alzarsi da un momento all’altro e camminare. Insomma chi abbia visto F, for Fake di Orson Welles e ricordi la ragazza statuaria e soffice, carne e pietra che cammina su e giù per la pellicola e che per qualche istante si vede posare nuda per uno dei pittori imbroglioni dell’isola di Ibiza, potrà farsi un’idea approssimativa di come questa statua-donna sia. Ad un tratto la porta della camera si apre e, preceduto dalla luce che si infila nella stanza, entra furtivamente Paso Doble che si avvicina senza rumore alla statua e le si ferma accanto a guardarla. Poi dice con un sussurro: «E tu presenza segreta che ruolo hai in questa storia? Te ne stai qui alla chetichella come una pura coincidenza oppure è da quando sei comparsa che è cominciato lo sfacelo?». Si mette a girare attorno alla statua guardandola ostilmente. Ansima, come se a malapena riuscisse a contenere qualcosa che gli pulsa dentro un po’ troppo forte, una aggressività, un rancore il cui bersaglio è il sorriso di cera della donna. Riprende a parlare con voce sussurrante. «Schultz mi chiama vampiro e sanguisuga… E tu cosa sei allora? Una passeggera dell’Orient-Express, un indovinello da salotto o una sonnambula arrivata qui per caso?» Poi la pulsione esplode e l’uomo si avventa sulla statua strappandola dalla sedia, sollevandola e portandola di corsa verso la vetrata che dà al poggiolo, esposto sul rio di San Felice. «Poiché non posso nascondere anche te in cima all’armadio come tutto il resto…» Una luce sospesa sul canale illumina la facciata della palazzina, la vetrata che si apre con uno sventolio di tende e l’uomo che esce sul balcone tenendo la statua fra le braccia e sollevandola alta sulla spalletta come se volesse scaraventarla in acqua. «…che ne diresti se ti buttassi in mare o ti trasformassi in una candela bruciando a poco a poco la tua cera, eh?!» Si teme per un momento per la statua, ma anche la si vorrebbe vedere (per ragioni plastiche se non proprio narrative) cadere a precipizio e affondare lentamente, i lunghi capelli che si sciolgono nell’acqua o andarsene piano come una barca alla deriva verso la laguna. Invece, di colpo, così come è esploso, il furore si spegne. Ora la lampada sospesa sul canale illumina una scena ben diversa. L’uomo posa con delicatezza la donna di cera sulla spalletta e rimane accanto a lei a guardarla. Da lontano, lei seduta sul davanzale con le gambe accavallate il cappotto di cammello aperto, lui in piedi accanto a lei, potrebbero essere scambiati per una elegante coppia uscita sul balcone a prendere un po’ di fresco. «Su torniamo dentro» mormora Paso Doble dopo qualche istante. «Non posso far questo a Schultz. Proibito dalla legge. Mi mollerebbe addosso tutti i vigili urbani del sestiere e io via a correre come Buster Keaton…»
Gialla e rossa nel buio un’insegna luminosa dice: «Ai Senza Famiglia». Troviamo uno spazio adatto all’osteria a Rialto, in qualche punto fra il mercato del pesce e il tribunale da dove si possa vedere qualcosa del Canal Grande, i vaporetti illuminati che lo risalgono e discendono, il traghetto adesso chiuso, e magari anche sentire l’odore del pesce venire dagli archi del mercato vuoto. Quanto alle ragioni del suo nome sono queste: “Ai Senza Famiglia” è nata parecchi decenni fa come regalo del conte Romoletto Bragadin alla sua amante Fulvia, allora la più bella popolana di Venezia, è nata con un altro nome, al quale con il tempo si è sovrapposto quello odierno per il tipo di clientela che la frequentava: scapoli, scapoli giovani, maturi o anziani, orfani attratti dalla bellezza straripante dell’ostessa e pure uomini sposati, ma disposti a piantare moglie e figli, appunto la famiglia, per le di lei dorate carni. È qui, in questa osteria, che Schultz sta mangiando, a un tavolo d’angolo, come si conviene a un cliente abituale e di un certo rango. C’è altra gente nel locale, ma è gente che non ha niente a che vedere con questa storia e che quindi non val la pena di descrivere per quanto interessante sia. Va detto invece di un uomo grasso, molto basso, in qualche modo unto, con pochi capelli in testa, con indosso un vestito con panciotto, seduto a un altro tavolo d’angolo. La caratteristica principale di quest’uomo appare evidente soltanto a chi lo conosca ed è questa: non sembra affatto quello che è, il famoso avvocato Berengo, titolare dello studio Berengo & Bardella, principi del Foro veneziano. Va descritto se non altro per la insistenza nervosa e un po’ sospetta con cui guarda verso Schultz. Se Schultz non fosse solo e stesse parlando con degli amici l’avvocato Berengo allungherebbe probabilmente il collo per sentire quel che dicono. Schultz adesso ha finito di mangiare. Si alza, attraversa l’osteria e va alla cassa dove la nipote della leggendaria ostessa amante del conte Romoletto Bragadin, anch’essa chiamata da tutti Fulvia anche se all’anagrafe figura come Maddalena, e anch’essa molto bella anche se non altrettanto bella della nonna, anch’essa bionda, con una camicetta di seta rosa, una collana di perle nere al collo, siede come una regina. «Schultz,» dice di punto in bianco la ragazza «ti ricordi l’estate scorsa, quella sera che tu eri a casa mia e sei salito in terrazza e io ero lì?» «Sì,» dice Schultz «mi ricordo.» «Sai cosa stavo facendo?» Schultz fa un cenno con la testa.
«Certo che lo so» dice. Non si accorge che a pochi metri di distanza l’avvocato Berengo si è precipitosamente alzato e ora cammina svelto verso l’angolo del locale dove sono appesi i cappotti dei clienti. Difficile capire se si sia alzato perché è arrivata anche per lui l’ora di andarsene o se, data l’insistenza con cui per tutta la sera ha guardato Schultz, se ne vada perché Schultz se ne sta andando. «L’hai detto a qualcuno?» domanda la ragazza. «No» dice Schultz. «Non l’ho detto a nessuno. Ma qualche volta lo racconto a me stesso.» Maddalena ride con gli occhi umidi e accesi.
Nell’ombra, giusto fuori dell’osteria, un po’ discosto dalla luce dell’insegna, l’avvocato Berengo aspetta. Ha un cappotto a doppio petto che pur essendo vecchio e unto gli conferisce un’aria dignitosa. Ora con quel cappotto, il bavero un po’ rialzato, le mani in tasca, l’avvocato potrebbe sembrare un po’ più di prima quello che è: Berengo, il celebre avvocato. Un’ombra appare dietro la spessa porta a vetri dell’osteria, poi la porta viene spinta dall’interno e Schultz ne esce abbottonandosi il cappotto. Si avvia verso la pescheria e non si accorge di Berengo se non dopo che questi, fatti pochi passi nella stessa direzione, lo raggiunge. «Allora, Schultz?» Schultz si ferma, guarda per un istante l’avvocato, poi riprende a camminare piano. «Cosa vuole che le dica, avvocato? Non posso dire nulla.» Camminano assieme l’uno accanto all’altro, Schultz a passi lenti, Berengo con i passi saltellanti di un colombo. «Cinque anni, Schultz» dice Berengo piano. «Se lei ha mai avuto la bontà di fare i conti. Cinque anni. Un periodo troppo lungo anche per uno spirito paziente come il mio. E in più la certezza di stancarla, Schultz, con la mia insistenza. Capisco che non è facile dare spiegazioni chiare lì dove le cose sono così complesse… Ma lei è un gentiluomo generoso, caro Schultz, e farebbe torto a se stesso se davvero credesse che non sia soltanto un’idea più o meno seducente quella di poter vivere per certe cose e non per altre. Ciò non avviene mai, caro Schultz. Neppure per un minuto. Questo volevo dirle. Soltanto questo. Non dico che questo io. E nessuno, credo, oserà dire di avermi mai sentito affermare il contrario.» Si interrompe. Alza lo sguardo sull’uomo che gli cammina al fianco come a volerne cogliere sul viso l’effetto delle sue parole. Poi prosegue lentamente: «Se fossi più giovane non esiterei un istante ad avventurarmi da solo in quel malvagio splendore. C’è stato infatti un tempo in cui, benché il mio aspetto attuale sembri escluderlo, c’è stato un tempo, dicevo, in cui mi arrampicavo sui campanili con un fucile in mano e correvo come una capra per le montagne…». «Sì» lo interrompe Schultz «probabilmente lei ha ragione e io torto. Come succede spesso da qualche tempo a questa parte. E tuttavia non posso farci nulla. Spingermi oltre, almeno per il momento, mi è impossibile…» C’è un breve istante di silenzio durante il quale Berengo sembra afflosciarsi un poco, deluso e spento. Ma dura un solo istante. Subito dopo l’avvocato s...