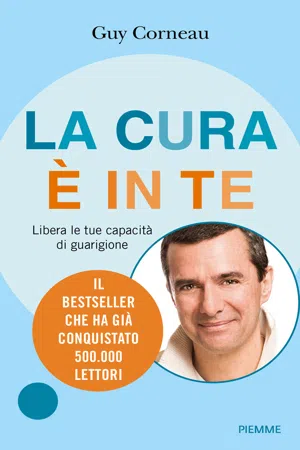![]()
Capitolo 1
LA SALA D’ATTESA
Prime avvisaglie
Qualche mese prima di morire, quando mio padre si è finalmente fatto visitare per i puntini neri che vedeva la mattina coltivando l’orto, il medico lo ha informato che doveva essere operato al cuore il più presto possibile.
«Dovrà mettere cinque by-pass e quattro lembi d’innesto, signor Corneau. Dev’essere da molto che si sente male!»
«Oh! Ogni tanto devo sedermi perché mi gira la testa, ma a parte questo sto benissimo.»
È morto per le conseguenze dell’operazione alcuni mesi dopo esservisi sottoposto. Dopo un secondo intervento, questa volta per un cancro all’intestino, il suo cuore ha ceduto. Poche settimane prima di morire riteneva ancora che quel buon dottore fosse l’unico responsabile dei suoi mali, e che senza quell’uomo avrebbe continuato a coltivare le sue verdure. Ne era fermamente convinto.
Sorprendente, non è vero? In un certo senso, mio padre era uno specialista del rifiuto. E devo constatare che ne sono il degno erede… Negli anni che hanno preceduto la diagnosi del cancro, ho conosciuto delle perdite di vitalità che ogni volta mi hanno rallentato per mesi interi. Siccome la mia vita era intensa e appagante, e quei malanni misteriosi sopraggiungevano sempre dopo estenuanti tournée, mi dicevo che era semplicemente stanchezza e che un po’ di riposo sarebbe bastato.
Tuttavia, nell’estate del 2006, nove mesi prima della diagnosi fatale, durante la notte sudo talmente tanto da inzuppare due t-shirt e una coppia di lenzuola. Galleggio letteralmente nel mio cuscino. Anche se faccio finta di niente, capisco che qualcosa non va. È qualche mese che un’amica mi sollecita a farmi vistare. Ogni volta, fiero della mia battuta, le rispondo immancabilmente: «Non ne vale la pena. Quello di cui soffro è troppo grave. Non si può curare!»
«Ma, Guy, non si suda così per niente.»
«Non ho tempo di essere malato.»
So bene che ha ragione lei. Il nostro primo informatore è il corpo, e non inganna. Prendo dunque appuntamento con un medico, l’interprete ufficiale del nostro organismo fisico nella società in cui viviamo. La maggior parte delle volte, essere un personaggio pubblico comporta dei vantaggi; ogni tanto implica degli inconvenienti. Durante il nostro primo incontro, il dottore ci tiene a dirmi che scrive anche lui e che presto pubblicherà. È tutto preso dalla competizione. Al punto che non vedo l’ora che stia zitto per parlargli di ciò che mi succede. Un mese dopo sono di ritorno nel suo studio per ricevere i risultati degli esami. Stavolta la fa breve.
«Signor Corneau,» mi dice, meno ciarliero della prima volta, «pensa che quello di cui soffre la farà morire?»
«Non lo so. Non credo.»
«Allora forse ce la farà. Il corpo tende a ripararsi da solo.»
Non credo alle mie orecchie. Non ha trovato niente. Torno a casa costernato, troppo felice di credere a questa versione ottimistica del mio stato. In parole povere, sudo come un maiale ma va tutto bene. Scoprirò qualche mese più tardi che aveva semplicemente cercato nella direzione sbagliata. Perché il cancro mi sta già rodendo.
La diagnosi
L’autunno che segue è particolarmente intenso: un mese di conferenze in Europa, uno di riprese per la mia trasmissione televisiva a Montréal e un altro ininterrotto di scrittura. Lo stress del libro da scrivere continua per tutte le vacanze di Natale.
Il febbraio 2007 è consacrato al giro mediatico e alla serie di conferenze che accompagnano l’uscita del mio ultimo lavoro. Concedo una sessantina di interviste a media di ogni genere e tipo, e in Québec il libro conosce un vero successo. All’inizio di marzo, parto per l’Irlanda dove animo con altri psicoanalisti junghiani un seminario di una decina di giorni. Riesco a fare il mio lavoro, ma di pomeriggio devo andare a coricarmi. Sono troppo stanco per partecipare alle escursioni di gruppo. Mi dispiace, perché metà della mia famiglia è di origine irlandese e immergermi nei paesaggi che hanno ispirato la musica della mia infanzia è una pura delizia. Alla fine del seminario passo qualche giorno a Dublino. La hall del mio albergo si apre su un grande caffè dai divani colorati e invitanti. Si può restare in quel bistrot tutto il giorno a scrivere, chiacchierare o mangiare qualcosa. Sono in paradiso. In una città come questa, dove gli scrittori possono perdere tempo senza vergogna nei caffè, mi sento a casa. Vado a teatro ogni sera.
Poi raggiungo la Francia, dove il mio libro esce in occasione del Salone del libro di Parigi. Ne traggo motivo di non poco orgoglio. Il giorno successivo al mio arrivo, la mia amica Marie Lise Labonté mi invita a bere una coppa di champagne per festeggiare il lieto evento in compagnia. Ho una tosse terribile.
«Non mi piace per niente!» esclama lei.
«È colpa dell’inverno parigino, l’umidità e l’inquinamento mi riattivano la bronchite.»
«No, non si tratta di questo. Chiamo il mio dottore e ti fisso un appuntamento.»
La sua inquietudine mi sembra quasi strampalata, ma le prometto di andare dal suo medico. Qualche giorno dopo, il dottor Junès mi ausculta a lungo.
«Sinceramente non piace neanche a me. Bisogna fare degli esami più approfonditi» mi dice.
Nel giro di una settimana mi trovano un’anemia così severa da far pensare che uno dei miei organi interni sanguini a goccia a goccia da ormai parecchio tempo.
«Lei deve avere qualcosa che funziona bene, visto che riesce ancora a reggersi in piedi» conclude il dottor Junès mentre scrive una lettera al mio medico di Montréal riguardo alla prosecuzione degli esami.
Il mese di aprile del 2007 porta con sé la catastrofe. Il dottor Michel Boivin, da vent’anni il mio gastroenterologo all’ospedale Saint-Luc di Montréal, scopre di settimana in settimana una condizione sempre più grave. Per prima cosa si accorge con stupore che a sanguinare è lo stomaco. In effetti ci si sarebbe potuti aspettare che fosse l’intestino, dal momento che soffro da trent’anni di una colite ulcerosa, una malattia infiammatoria che colpisce quest’organo. Poi si rende conto che è canceroso.
Purtroppo lo vengo a sapere in un modo decisamente poco opportuno. Svegliandomi dopo un esame che aveva richiesto il mio addormentamento, l’infermiera mi rimanda a casa con un foglio che devo imperativamente leggere: i risultati. È il tardo pomeriggio di un venerdì. Poche ore dopo, sono solo in casa, alle prese con un resoconto di cui non capisco quasi nulla. Mi metto a cercare il significato dei termini su internet e realizzo con stupore che ho il cancro. Non credo ai miei occhi. Scendo più volte nel mio studio per verificare la diagnosi, quasi che avessi potuto leggere male, quasi che potesse cancellarsi tra una lettura e l’altra come un brutto sogno al risveglio. Lo shock mi colpisce a poco a poco. A piccole scosse successive, mi tira via la terra da sotto i piedi. Ben presto mi ritrovo con le gambe sospese nel vuoto, come sull’orlo di un precipizio, sgomento.
Mi rifugio su un divano del salotto come un animale ferito. Mi metto semisdraiato, emergo appena dai cuscini, come qualcuno che sta per annegare e di cui spunta solo la bocca dall’acqua. Mi ritrovo sospeso in una specie di tempo morto, anchilosato, e non oso muovermi per paura di farmi male. Il minimo movimento risveglia sofferenza e angoscia. Trovo molto bizzarro restarmene lì così a contemplare la possibilità della morte, della mia dipartita divenuta improvvisamente tangibile, improvvisamente reale.
Dormo solo qualche ora, con quelle strane parole che mi turbinano in testa, parole come adenopatia, linfoma, costruendomi una mitologia personale a partire da quei termini a me sconosciuti.
Non mi muovo da lì fino a sabato pomeriggio. Non mangio. Non bevo. Sono immerso in uno stato completamente irreale. Non so come comunicare la notizia ai miei famigliari. Non ho più parole. Sono spaventosamente triste e, in modo oscuro, mi vergogno di ciò che mi sta succedendo. Verso le quattro il telefono mi strappa alla mia letargia. Ridendo, incredulo, riesco a balbettare che ho il cancro.
Poi mi costringo a darmi un po’ da fare. Anche se non ho per niente fame, vado a mangiare al ristorante con Yanna, la mia migliore amica, anche lei colpita dalla malattia. È più facile trovare conforto accanto a qualcuno che ne è già colpito. Ci si sente capiti senza bisogno di inoltrarsi in grandi spiegazioni sugli stati d’animo che si stanno attraversando. Arrivo a domenica sera come un naufrago, sempre indebolito dallo shock. Riesco comunque a ritrovare una parvenza di contegno, sufficiente a parlare alla maggior parte dei miei amici intimi, uno per uno. Ogni volta li avverto che ho qualcosa di spiacevole da comunicare. Raccolgo stupore, compassione e sostegno morale in abbondanza.
E poi ci sono i membri della mia famiglia, che si preoccuperanno. Informo di ciò che mi sta succedendo le mie sorelle Line e Joanne, chiedendo loro di non parlarne subito a nostra madre perché preferisco farlo personalmente. Mi sono sempre sentito vicino alle mie sorelle minori. Bisogna dire che tra noi non c’è molta differenza d’età. Una ha due anni meno di me e l’altra tre, quindi siamo cresciuti insieme. Le ammiro sinceramente. Joanne è diventata una pittrice conosciuta con il nome di Corno. Line si è fatta onore nel mondo dell’istruzione. L’annuncio le sconvolge. Joanne insiste perché vada a farmi curare in un rinomato ospedale di New York, per poter beneficiare dei trattamenti più all’avanguardia. Vuole che le stia vicino per potersi occupare di me. Quanto a mia sorella Line, è reduce da un’aspra lotta ai confini della morte contro il batterio Clostridium difficile. Ha avuto sei ricadute, un record negli annali del Québec relativi a questa malattia. Ciò l’ha sfinita e sta recuperando le forze poco a poco. Tuttavia quell’esperienza le permette di essere un’ottima consigliera per il fratello maggiore. Mi ripeterà incessantemente di essere paziente e di non perdere la speranza, che «ci hanno fatti robusti» e che «la semenza dei Corneau non si sradica così facilmente!».
Tramite le reazioni dei miei cari, avverto tutto il beneficio rappresentato da una solida rete di aiuto reciproco. Mi dico anche che non dev’essere facile affrontare una diagnosi analoga se si è isolati e il telefono non suona mai per dissipare la letargia. In quel caso, la tentazione di lasciarsi andare e di non lottare dev’essere grande. Perciò vorrei dire a chi si trova appartato di non esitare a mobilitare la propria rete famigliare e sociale per farsi sostenere nella prova. Bisogna cominciare da lì. In più, se lo si desidera o se ci si sente incompresi dai propri cari, non bisogna esitare a unirsi ai gruppi di sostegno, ai laboratori creativi o alle sedute di yoga organizzati dalla maggior parte degli ospedali per venire in aiuto ai malati. In genere si può anche accedere a qualche ora di psicoterapia gratuita. Sono strumenti preziosi che possono fare la differenza. Vale la pena di scuotersi per beneficiare del lavoro di uno psicologo professionista o delle attività di un’associazione di volontariato. Quasi senza eccezione vi si incontrano persone che sono passate attraverso la malattia. Sanno quello che i loro assistiti stanno passando. Quando ci si trova in una difficoltà estrema, la parola d’ordine è evitare l’isolamento, perché esso conduce a trascurare l’alimentazione, l’esercizio e le buone abitudini di vita in generale. Le statistiche sulla salute, in particolare quelle eseguite in ambito cardiologico, dimostrano inequivocabilmente che i gruppi di aiuto reciproco prolungano in maniera significativa l’aspettativa di vita degli individui e accelerano i processi di guarigione.
Dean Ornish, direttore dell’Istituto di ricerca in medicina preventiva e professore di medicina all’Università della California a San Francisco, conduce da più di trent’anni studi clinici che hanno chiaramente dimostrato come l’assenza d’amore e di amicizia sia la sorgente stessa di ciò che ci rende malati. L’amore è un bisogno biologico, alla stessa stregua del bere e del mangiare, dice. Niente ha più influsso sulla qualità della vita, sulla malattia e sulla morte prematura del fatto di vivere isolati. Per questo raccomanda alle persone sole di partecipare a incontri di gruppo allo scopo di creare legami e intrattenere relazioni che possono portare gioia nelle loro vite.
Rivedo il mio medico martedì a mezzogiorno. Mi aspetta nel suo studio con l’aria preoccupata, cercando probabilmente di raccogliere le forze per quello che deve annunciarmi. La scena evoca un ricordo della pubertà, quando, prendendo il coraggio a due mani, mio padre mi ha portato nella mia stanza per parlarmi di ciò che si è soliti chiamare “i misteri della vita”. Io però sapevo tutto già da un bel pezzo, grazie ai miei compagni di gioco. Eppure l’ho ascoltato pazientemente, come se niente fosse, per non imbarazzarlo ancora di più.
Stavolta, tuttavia, non appena constato il turbamento di Michel all’idea di annunciare a uno dei suoi pazienti di vecchia data che il suo caso è diventato più che allarmante, lo aiuto dicendogli che sono già informato. Il suo sollievo lascia rapidamente il posto alla rabbia quando viene a sapere in che modo l’ho saputo. Non riesce a credere che mi sia ritrovato quel resoconto tra le mani e che abbia passato il week-end da solo con quei risultati. Nel corso di quello stesso incontro, mi comunica che sfortunatamente gli esami hanno rivelato anche che sono stati colpiti i gangli attorno allo stomaco e che bisogna proseguire l’indagine.
La tournée europea
La notizia mi annichilisce. Di visita in visita, il bilancio si aggrava. Quando finirà tutto questo? È la metà di aprile e ormai in testa ho un’unica domanda: dovrò annullare il giro di conferenze e incontri in Europa che avrebbe dovuto incominciare di lì a qualche giorno? Una simile tournée è lunga da preparare e necessita della collaborazione dell’editore, degli addetti alle relazioni con la stampa e degli organizzatori di conferenze. Per non parlare di Marie, la mia preziosa assistente, che coordina tutte queste persone e gestisce i contratti. Indubbiamente ci rimetteranno tutti.
La settimana seguente, ciò che doveva accadere accade. L’incontro col mio medico inizia con parole che non voglio sentire. Le ascolto con il cuore che mi batte all’impazzata.
«Non puoi fare la tua tournée, è troppo grave!»
«E se decido di farla lo stesso?»
«Non rispondo più di niente. Può essere che tra due mesi il cancro non si sia molto evoluto. Oppure può darsi che si sia aggravato, e allora avremo perso del tempo prezioso. Anche la milza è stata colpita, e chissà cos’altro ancora. Devo cercarti un oncologo in un altro ospedale, perché la gravità del tuo caso ormai esula dalla mia competenza.»
Resto a bocca aperta. Non riesco a decidermi a rimandare la tournée. Io, che in tutta la mia carriera non ho mai annullato una conferenza, di colpo sto mettendo nei guai tutti i miei partner. Qualche giorno dopo, decido di registrare nel mio salotto un DVD della conferenza. Lo mando agli organizzatori perché possano presentarlo al pubblico. Almeno non perderanno tutto. Faccio anche pervenire una lettera in cui li informo della mia malattia, specificando che non ho dubbi circa l’esito positivo di questa lotta. Sebbene tutti reagiscano con una generosa comprensione e un’evidente compassione, mi sento veramente infelice per la piega che hanno preso gli avvenimenti. È come se perdessi la faccia. Ma non c’è solo questo. C’è di peggio.
Come ho già detto, il cancro si è manifestato nel momento in cui avevo appena finito il libro che considero il mio testamento sul piano psicospirituale. Le meilleur de soi (“Il meglio di sé”) raccoglie davvero il meglio di me, della mia conoscenza e della mia esperienza sul terreno pratico della vita e della psicoterapia. Nel libro parlo di ciò che ostacola in noi l’espressione della nostra creatività profonda a livello psicologico e di ciò che la agevola dal punto di vista spirituale.
Ho voluto scrivere un libro che fosse capace di guidare una vita nel caso in cui si potesse leggere solo quel libro. Impresa ambiziosa, ma condotta senza grandi ambasce. Per farlo ho usato parecchio il lavoro che ho sviluppato all’interno delle Productions Coeur.com insieme al mio amico Pierre Lessard, un maestro spirituale che è stato e continua a essere per me un compagno di strada e una guida. Per noi è stato un piacere straordinario sviluppare e insegnare ciò che costituisce la base del mio ultimo libro. Ma ecco che, nonostante tutte quelle conoscenze che donano la vita, il cancro esplode comunque. Ora mi trovo di fronte a me stesso come mai in tutta la mia esistenza. Non riesco a credere che tutto questo mi stia succedendo davvero. Il mio umore è cupo. Mi chiedo proprio come riuscirò a fare di questo avvenimento un ponte verso una qualche luce.
Grado 4
26 aprile 2007, ospedale di Notre-Dame di Montréal, le otto del mattino. Mi trovo nella sala d’attesa al quarto piano del reparto Deschamps. Il locale è pieno da scoppiare. La cosa mi impressiona. Il calore umido che si sprigiona dai corpi impregna l’aria. Constato che il cancro colpisce tutti senza fare distinzioni. La distribuzione delle persone ammalate sembra perfino democratica: ricchi, poveri, uomini, donne, giovani, vecchi, grassi, magri, signore col velo, uomini di colore, gente ben vestita o in tenuta sportiva. Si direbbe quasi “politicamente corretto”.
Anche se ho la testa piena di stupidaggini come queste, sono molto teso. Ho appuntamento con la dottoressa Louise Yelle. Insieme dobbiamo fare il punto complessivo sugli esami che ho fatto. Mi dirà che mi resta da vivere solo qualche settimana? Mi aspetto il peggio, perché da un mese a questa parte la situazione non ha fatto che aggravarsi. Mi stringe la mano non appena entro nel suo studio. Mi sento ben accolto, e questo me la rende immediatamente simpatica. Ma non rende più simpatico ciò che deve annunciarmi: un cancro di grado 4, per precisione un linfoma non Hodgkin a grandi cellule, extranodale, che coinvolge la milza e lo stomaco, sede del tumore principale. E come se non bastasse, sono state rilevate una cinquantina di lesioni metastatiche su entrambi i polmoni. Nel comunicarmi tutto questo, la dottoressa fa il seguente commento: «In genere i linfomi reagiscono bene alla chemioterapia, signor Corneau».
«Grazie per l’ottimismo.»
«Non sono ottimista, sono realista.»
Non voglio sapere nient’altro. Tutto ciò di cui ho bisogno al momento risiede in quelle parole di speranza. La dottoressa ha l’eleganza di non parlare di statistiche. Solo alla fine dei trattamenti di chemio, più o meno nove mesi dopo, ho avuto il coraggio di chiederle quanti gradi di cancro esistono. Mi ha detto: «Quattro! Uno, due, tre, quattro. Adesso è più chiaro?».
«È chiarissimo e sono contento di non averlo chiesto prima! Sarei morto di paura.»
Vedete, il rifiuto è una cosa che ha la sua importanza, nella vita. Ha un aspetto negativo, ma ne ha anche uno positivo. È un meccanismo di difesa inconscio, vale a dire che opera a nostra insaputa. Questa strategia naturale permette di bloccare delle emozioni che potrebbero turbare eccessivamente il nostro stato interiore. In qualità di psicoanalisti, si passa il tempo a puntare il dito contro questi meccanismi di difesa, perché paradossalmente finiscono per soffocare l’individuo. La saggezza terapeutica invita tuttavia a non dimenticare mai la loro funzione principale: permettere alla persona di sopravvivere. Per rimetterli in discussione è bene trovarsi in un contesto terapeutico. Un tale contesto favorisce l’incontro con le emozioni intense che si manifestano in una persona nel momento in cui cerca di uscire dal rifiuto.
In quella mattina di fine aprile, non voglio sapere quanti stadi ha il cancro. Eppure la domanda mi scotta le labbra. Preferisco immaginare che ne esistano cinque o sei. È una cosa che mi permette di vincere l’angoscia mortale che provo. Così mi concedo un margine per respirare. So che il mio caso è molto grave. So che il cancro è aggressivo, che coinvolge tre organi vitali e che, per citare la mia oncologa, «progredisce velocemente». Ciononostante, non posso tollerare di saperne di più. Ho già le vertigini. Mi manca l’aria.
È giovedì e la dottoressa mi propone di cominciare i trattamenti di chemioterapia l’indomani mattina, tanto la mia situazione le sembra critica. Le chiedo due settimane di tregua, il tempo di abituarmi all’idea, di cercare delle alternative e di annunciarlo a mia madre con ancora i miei capelli in testa, visto che perderò tutti i peli del corpo. La data della prima seduta di chemio viene dunque fissata a martedì 15 maggio, ossia tre settimane dopo.
Una volta uscito dallo studio faccio questa considerazione: «Non sarà la medicina a decidere l’esito di questa malattia. Sarò io».
Sarà forse un tantino pretenzioso, ma vuol dire soprattutto che sono pronto a mobilita...