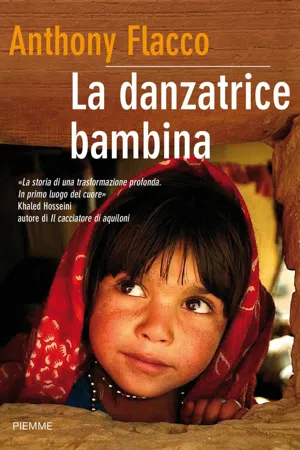![]()
1
Nel luglio del 2001, Zubaida aveva solo nove anni e mezzo, ma già sapeva che il suo sperduto villaggio del deserto nel Sud-Ovest dell’Afghanistan era un luogo antico. Centinaia di anni prima Farah era stato uno dei principali centri di scambio della regione. Ora la vita del villaggio scorreva tra alte rovine di mattoni di fango che non avevano più recuperato la loro forma originaria da quando, nel XIII secolo, Gengis Khan aveva scorrazzato nel territorio con le sue orde mongole.
A Zubaida non interessava. La sua esistenza era scandita dalla musica e dalle danze popolari che da sempre l’accompagnavano. E come accade a certe persone, le melodie e i ritmi le erano entrati nelle ossa, e trascorreva gran parte del tempo canticchiando o danzando, senza nemmeno rendersene conto. Nell’amore per la musica e per la danza aveva trovato un rimedio per scacciare la noia e per proteggersi dalla tristezza.
Ma la sua vita di danze spensierate stava per finire. Secondo le leggi delle forze talebane, a partire dal suo decimo compleanno non avrebbe mai più potuto correre e giocare all’aperto con le altre bambine e men che mai avere un amico maschio. Lo sapeva e percepiva l’incedere del tempo.
Nonostante la cappa di calore opprimente, anche in quel pomeriggio di luglio il suo esile corpo vibrava al suono delle melodie che rallegravano gli ultimi giorni della sua infanzia. Cantava: “Sono una ragazza di Herat, riesco a sentire la musica al di là delle montagne”. Era la strofa di una canzone popolare di molti decenni prima, che ancora veniva cantata dalle donne afgane.
Era mattina presto ed era sola in casa, mentre i suoi familiari erano al villaggio, ognuno preso dalle proprie occupazioni. La madre e la sorella maggiore si trovavano in visita dai vicini. La situazione ideale per cantare e ballare senza timore. Era meraviglioso sentirsi così libera e potersi abbandonare alla musica, senza fratelli e sorelle su cui incespicare, genitori che si lamentavano per il rumore, senza nessun chierico talebano pronto ad esprimere il suo sdegnato disappunto davanti a una bambina che osava apertamente essere felice.
Ora doveva soltanto seguire la musica e farsi trasportare dalle sue vibrazioni. Era qualcosa che la animava tutta, dalla testa ai piedi. La faceva avanzare per la casa con giravolte sinuose e volteggi. Quando iniziava, non c’era modo di fermarla. Sapeva della crudeltà dei talebani. Sapeva che se l’avessero vista avrebbero disapprovato con vigore. Ma sapeva anche che i talebani tendevano a trascurare quella regione desertica e a concentrarsi sulle città più grandi, dove riuscivano a recuperare un maggior numero di proseliti. Fintantoché rimaneva nascosta dietro le spesse pareti di fango della sua casa, era al sicuro.
Sì, quel momento di solitudine era davvero una grande occasione. Ora poteva anche prepararsi un bagno, tutto per sé. Canticchiava, danzava e volteggiava, mentre si approntava a riempire la piccola tinozza. Chinandosi per accendere la fiammella pilota dello scaldabagno, aveva notato che il piccolo serbatoio di kerosene era quasi vuoto. Si era alzata e si era allontanata, senza smettere di ballare, cantando a più riprese una delle sue strofe preferite mentre recuperava la latta di kerosene.
È facile per una ragazzina che non ha ancora dieci anni dimenticare piccoli dettagli, come accertarsi che la spia sia spenta prima di riempire di combustibile uno scaldabagno. Invece, improvvisa persino alcuni passi complicati mentre tiene la latta ben stretta e si dirige verso lo scaldabagno.
Nel momento in cui le dita del primo piede sfiorano una scarpa, rimasta in mezzo al pavimento, sposta istintivamente il peso sull’altro piede per non perdere l’equilibrio. Avrebbe funzionato, se non ci fosse stata di mezzo la seconda scarpa. Inciampa. D’istinto apre le braccia e lascia cadere il kerosene in modo da potersi concentrare solo sul proprio corpo. Così, in effetti, non finisce con la testa diritta nello scaldabagno, ma cade semplicemente in avanti su mani e ginocchia.
Se il piccolo riflusso di kerosene non fosse andato direttamente sulla spia dello scaldabagno, probabilmente sarebbe subito balzata in piedi, senza nemmeno un graffio. Invece, una lingua di fuoco parte dalla spia e, attraversando l’aria, va a infiammare il kerosene che le è schizzato addosso.
E la piccola danzatrice di nove anni e mezzo si trasforma in una torcia umana.
La sua reazione fu puramente emotiva: urlò di paura nella casa vuota, mentre cercava di spegnere le fiamme che già stavano avviluppando la parte superiore del corpo. E quando inspirò, l’aria rovente le arse immediatamente la gola e i polmoni, tramutando le sue grida in guaiti di terrore.
Soltanto allora percepì la prima vera ondata di dolore fisico. Giunse con l’intensità di una bestia feroce. Denti di fuoco arancioni la azzannarono, fin dentro i capelli. Le strapparono via pelle e carne, scavando in profondità, fino alle ossa. Perse completamente il controllo e fu invasa dal panico, mentre cercava di strapparsi i vestiti e si muoveva barcollando nella stanza, sbattendo ripetutamente contro le spesse pareti di fango.
Nella casa accanto, sua madre, Bador, e la secondogenita, Nacima, udirono le prime urla di Zubaida. Pur non riconoscendo quella voce distorta, il tono era così straziante che accorsero immediatamente. Arrivarono giusto in tempo per vederla crollare a terra. Le due donne erano un perfetto esempio di quel tempo e di quel luogo: fondamentalmente prive di istruzione, assai di rado avevano potuto uscire dal circondario, tenute volutamente, e il più possibile, all’oscuro del mondo. Ma fra le pareti domestiche erano estremamente indipendenti e non c’era situazione che non affrontassero con prontezza, da sole. «Dell’acqua, subito» gridò la madre. Ebbero la presenza di spirito di sollevare la tinozza e di rovesciare l’acqua del bagno sulla bambina in fiamme, che a quel punto era stata in balia del fuoco abbastanza a lungo da far sì che le fameliche fiamme non si alimentassero più soltanto del kerosene che le era schizzato addosso, ma anche degli oli della sua carne.
La bambina era consumata dal terrore e dal dolore. Non aveva mai perso conoscenza, ma panico e agonia avevano assorbito completamente la sua attenzione, al punto che non si rendeva quasi conto di quello che le stava succedendo. L’unica cosa che sapeva era che l’ondata iniziale di paura era stata sostituita da un dolore implacabile, feroce, e che la sola reazione possibile era inspirare con i polmoni bruciati, e poi, urlando, gettar fuori tutta l’aria dal proprio corpo. Inspirare e urlare. Non importava se l’aria rovente le bruciava dentro. Il corpo seguiva un istinto che imponeva di scacciare via il dolore urlando, di mandarlo nei polmoni e poi di nuovo fuori.
Non serviva a nulla, ma non poteva smettere.
Le fiamme erano state estinte da un’ora. Zubaida si contorceva sul pavimento mentre Daud, il fratello sedicenne, era alla disperata ricerca del padre nel villaggio. Non esistevano telefoni a Farah: l’unico modo per trovare qualcuno era correre, chiamare, chiedere in giro. A casa, ai suoni agonizzanti di Zubaida ben presto si unirono le grida della madre e della sorella e poi di alcune vicine. Prestavano le loro gole alla sua sofferenza e cercavano di aiutarla a buttar fuori il dolore, come per secoli avevano fatto le donne delle loro famiglie.
In un luogo così sperduto non esisteva altro rimedio se non quello di spruzzare costantemente la zona ustionata con dell’acqua, nel tentativo di raffreddare la pelle. Non c’erano farmaci potenti. Non c’era niente. In quella terra di devoti musulmani sciiti non c’era neppure dell’alcol per alleviare il dolore della piccola. Sebbene fosse in un profondo stato di shock, Zubaida non svenne mai e rimase sempre lucida.
Dopo quella prima ora, cadde in uno stato di letargia postraumatica. Senza una flebo per mantenere alto il livello dei liquidi, la piccola venne colta da un tremore incontrollabile. La sua famiglia era annichilita di fronte ai deboli gemiti che provenivano da un corpo ormai troppo esausto per protestare con maggior vigore.
Ma la voce di Zubaida, dentro di lei, continuava a gridare con tutta la forza che aveva. Urlava come un animale del deserto che viene mangiato vivo. Urlava il suo orrore, il suo spavento, il suo dolore. Urlava la sua rabbia arroventata per quello che le stava capitando. Perché proprio a lei? Allo stremo delle forze, le urla che ne uscivano erano lunghi, flebili gemiti, che rimanevano sospesi nell’aria come domande a cui nessuno poteva dare risposta.
Arrivò ansimante il padre di Zubaida. Mohammed Hasan guardò con orrore la sua bambina, il cervello si rifiutava di credere a ciò che gli occhi vedevano. Teneva fisso lo sguardo su quel tizzone bruciato che era sua figlia, praticamente irriconoscibile. Lanciò un urlo disperato. Poi pianse, senza vergogna, insieme alle donne. Invocò l’aiuto di Allah, del profeta Maometto e di Alì, il prescelto da Maometto, il profeta dei musulmani sciiti.
Sembrava che il cielo avesse acconsentito a mantenere sua figlia in vita, ma soltanto affinché non morisse lì, in quel momento. Tutto il resto, era lasciato alle loro umili mani terrene.
Per Hasan, marito e padre afgano, questo voleva dire che ogni cosa dipendeva da lui. La moglie Bador non poteva portare Zubaida a cercare il soccorso di cui aveva disperato bisogno: secondo le leggi talebane una donna sposata poteva offrire il proprio aiuto soltanto all’interno della casa, protetta dalle pareti domestiche; senza un padre o un fratello che la scortasse non poteva neppure portare una figlia sofferente all’ospedale.
Nelle province governate dai talebani, una donna che veniva sorpresa a fare una cosa del genere, poteva essere giudicata una “avventuriera”. E poiché un’avventuriera è una tentatrice, e una tentatrice è una puttana, era facile che quella donna venisse condannata a morte per lapidazione, o forse, come alternativa più rapida, semplicemente decapitata, se il crimine commesso era meno grave.
Un cugino di Hasan, giovane e forte, aveva già portato Zubaida all’ambulatorio locale, in fondo alla strada, senza però trovare né le cure necessarie né gli antidolorifici. Era chiaro che tutti si aspettavano che morisse nel giro di qualche ora. E in ogni caso, il modesto ambulatorio non aveva rimedi efficaci da offrire.
Mohammed Hasan cominciò a radunare i suoi pochi, scarni beni per recarsi a Herat, la città più vicina. «Devo portare Zubaida da dei buoni dottori» disse alla moglie e alla famiglia. A quel punto tutta la comunità si era riunita fuori dalla casa. Anche se nessuno era in grado di offrire un qualunque tipo di aiuto medico, la tradizione tribale li aveva chiamati a raccolta.
Nella città e nella provincia di Farah, la popolazione si definiva afghan, come la famiglia di Hasan, oppure pashtun, come la maggioranza. Entrambi i gruppi erano riusciti a sopravvivere rimanendo ancorati alle proprie strutture tribali nel corso dei secoli: lo avevano fatto senza soluzione di continuità, mentre altre civiltà conquistatrici sorgevano e cadevano attorno a loro. Quella stessa unità tribale si veniva a creare ora per soccorrere la famiglia di Hasan.
Si sparse la voce che Zubaida doveva essere trasportata all’ambulatorio più vicino, a Herat, a poco meno di duecento chilometri di distanza. Era un viaggio che una persona così sofferente non poteva certo affrontare a piedi o a dorso di cammello. Una delle famiglie imparentate con gli Hasan era così fortunata da possedere una vecchia automobile che di tanto in tanto funzionava. Accettarono di fare un tentativo. Avrebbero portato Zubaida e Mohammed a Herat, se lui provvedeva a riempire il serbatoio e a pagare il viaggio.
Il vicino si mise alla guida, la madre si sedette davanti, mentre Hasan teneva sdraiata sul sedile posteriore la dolorante sagoma di Zubaida. Ci vollero quasi sette ore. Ogni volta che l’auto sobbalzava sulla strada sterrata e dissestata, la piccola ustionata lanciava urla di dolore. Il sollievo che avrebbe potuto derivarle dallo svenimento non giungeva. La madre continuava a singhiozzare e a implorare Allah di intervenire, di far sì che la sua bambina perdesse almeno i sensi.
Ma la capacità di Zubaida di tenersi strenuamente attaccata alla vita, anche quando gli altri la davano ormai per morta, non prevedeva la possibilità di ottenere sollievo perdendo conoscenza. Una parte di lei, più antica delle rovine del villaggio dalle mura di fango, si ripeteva che per riuscire a sopravvivere doveva rimanere vigile. Si trovava in quello stato di disperazione animale in cui l’istinto trasmette al sistema nervoso la paura che allontanandosi dal mondo, permettendo al sonno di sopraggiungere, non ci sia ritorno. Così, con quel briciolo di vita che le era rimasto, percepiva ogni sobbalzo mentre avanzavano nel deserto sconfinato e infuocato, finché il giorno non si trasformò in una nottata clemente.
Quando finalmente arrivarono a Herat, Hasan tirò fuori il piccolo rotolo di banconote che rappresentava tutta la ricchezza dalla famiglia e lo mise in mano al dottore. «La prego, salvi la mia bambina» lo scongiurò. È probabile che l’intensità di quella richiesta abbia colto di sorpresa il personale medico, dal momento che il fondamentalismo culminato nella presa di potere da parte dei talebani si era accompagnato con un proporzionale crollo nella scala sociale delle donne, e delle bambine in particolare.
La preoccupazione che Hasan mostrava per la sua piccola era in genere riservata ai figli maschi. Era prassi comune che i genitori abbandonassero una figlia morente nel deserto o, se il patriarca aveva un animo più generoso, mettessero fine alla sua vita in modo più rapido e indolore, sparandole un colpo alla testa per poi sotterrare il corpo in segno di rispetto.
Dopo tutto, una figlia femmina non poteva far molto per proteggere i genitori anziani dall’indigenza, visto che al momento del matrimonio veniva portata via e rinchiusa dietro altre mura.
Tuttavia, i medici compresero il suo dolore. «Faremo ciò che possiamo.» Ma era impossibile non leggere nei loro occhi che le speranze erano davvero minime.
Sapevano che la pelle carbonizzata doveva essere raschiata e lavata, se si voleva che Zubaida avesse una chance di sopravvivere all’infezione che sarebbe inevitabilmente sopraggiunta di lì a poco. Così, pur non avendo anestetici da offrirle, non poterono fare a meno di tirarle via la pelle coperta di vesciche purulente.
L’operazione iniziò a meno di otto ore dall’incidente, e Zubaida scoprì di avere ancora moltissime energie per urlare con tutte le cellule del suo corpo mentre la scuoiavano. I medici dovettero tenerla ferma, come fosse stata una vittima da torturare. Dal punto di vista della piccola non c’era differenza. «No, no, vi prego, fermatevi, no, no» urlava disperata.
Il dolore iniziale non era diminuito per nulla, anzi, per quanto le sembrasse impossibile, peggiorava man mano che le levavano la pelle bruciata. Nelle zone in cui le ustioni erano più profonde, sul petto, dove la carne praticamente non esisteva più, anche le terminazioni nervose si erano fatte inesistenti. In quei punti il dolore non era terribile come sul collo, sulla gola e sulle braccia. Lì, i nervi messi a nudo inviavano al cervello messaggi terribili. L’agonia la dilaniava. Ogni grido era come un getto di vapore che soffiava da una valvola. «Per favore, basta... voglio morire.»
Le torture finalmente cessarono, ma a quel punto l’arsenale della piccola clinica non aveva nulla da offrirle, se non un unguento per cercare di proteggere la carne viva. La riaffidarono alle cure del padre. «Non riuscirà a sopravvivere a quanto le è successo. La morte potrebbe sopraggiungere stanotte o domani, o forse tra una o due settimane» disse il medico ad Hasan. L’unica questione a cui non si poteva dare una risposta era quanto sarebbe durato l’incubo della piccola.
«Porti la sua bambina a casa e preghi affinché la fine arrivi presto.»
Hasan riportò indietro Zubaida dopo aver condiviso con la moglie quella prognosi disperante. Ma anche di fronte a una tale agonia non sapeva arrendersi. Lui e Bador non riuscirono a invocare la morte consolatrice. Dissero invece alla famiglia: «Pregate che venga risparmiata... pregate per un miracolo».
E se un miracolo era chiedere troppo, allora Hasan implorava: «Ti supplico Allah, al posto della mia bimba innocente prendi me». Ripeteva all’infinito la richiesta, mentre, impotente, si prendeva cura di Zubaida.
Ventiquattro ore dopo l’incidente, Hasan si rivolse ai vicini, chiedendo loro un piccolo prestito per pagare il carburante, in modo che un altro rottame potesse trasportare Zubaida a cercare aiuto altrove. Barattò alcuni beni della famiglia per raggranellare qualche soldo e andare verso il confine con l’Iran, nella vana speranza di raggiungere un ospedale più grande. “Là i dottori sanno sicuramente che cosa fare” pensava. Mohammed Hasan aveva servito il suo paese nella lunga guerra contro gli invasori sovietici. Sapeva che soltanto per alcuni esistevano cure mediche adeguate. Uno di quei posti avrebbe sicuramente avuto il tipo di medicina che poteva salvare sua figlia.
Ma ora Zubaida era avvolta da una fitta nebbia, stremata, dopo aver passato tutto un giorno e tutta una notte a urlare il suo dolore, una sofferenza così intensa che non sarebbe mai riuscita a esprimere a parole. I genitori continuavano a spruzzarle acqua fredda sulla pelle martirizzata. Il sollievo le proveniva essenzialmente dall’amore che le dimostravano. Ma qualunque cosa facessero per lei, il dolore non allentava la sua morsa. Se smetteva di urlare per brevi intervalli di tempo, era soltanto perché la spossatezza aveva avuto la meglio.
Questa volta viaggiarono di notte per evitare il caldo torrido del deserto. Percorsero aride strisce di terra sotto un cielo nero come la pece. Arrivarono a Herat e proseguirono verso nord, attraversando il confine con l’Iran, verso la cittadina di Moshad.
Per fortuna, gli sporadici posti di blocco talebani sembravano capire il dramma della piccola, e non la considerarono una minaccia. Lasciarono passare una bambina che gemeva e un padre mezzo isterico. Probabilmente disapprovavano che un padre si opponesse al destino scelto da Allah per la propria figlia, ma erano talmente colpiti dallo stato in cui versava la bambina che lasciarono che il povero uomo proseguisse nel suo viaggio senza speranza.
I dottori di Moshad diedero un’occhiata a Zubaida, le spalmarono un nuovo strato di unguento e poi dissero che avrebbe dovuto andare a Teheran, ad altri settecentocinquanta chilometri di distanza. Voleva dire guidare per altre dodici ore, e per Zubaida fu una nuova odissea.
Venne ricoverata all’ospedale di Teheran, anche se non si poteva fare molto per lei se non trattarla con altre pomate in modo da scongiurare il peggio dell’infezione ed evitare che le ferite si asciugassero.
Ben presto perse la cognizione del tempo: i giorni e le notti divennero un tutt’uno. L’unica cosa di cui era costantemente consapevole era l’agonia che giungeva dalle terminazioni nervose carbonizzate. Per quanto cercasse con tutte le sue forze di liberarsene con urla violente o deboli gemiti, continuava a bruciare dentro di lei.
La famiglia di Zubaida e tutto i...