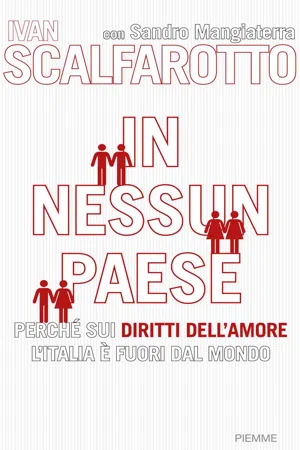![]()
Capitolo 1
DIRE
Gay: basta la parola. La Madonna con bambino, affresco del Quattrocento che si trova in un’edicola esterna, all’ingresso del duomo di Bolzano, è stata sfregiata. Beh, proprio sfregiata no. Nella notte dell’Epifania 2010 è comparsa una scritta con la vernice rossa. La parolaparolaccia: gay. Se ne sono accorte le vecchiette che andavano alla prima messa del mattino. Silvia Spada, responsabile dei servizi museali e dei beni artistici della città, è stata letteralmente svegliata dai giornalisti: «Ci risiamo» ha pensato mentre si vestiva. L’opera, infatti, era già stata danneggiata, con alcuni scarabocchi, una dozzina di anni prima. La dottoressa Spada è corsa in piazza e ha tirato un sospiro di sollievo: poteva andare peggio. Stavolta erano tre lettere in tutto, e nemmeno tanto grandi. «Francamente» dice «non ho capito il can-can mediatico che si è scatenato intorno a questo episodio.» Il matto che si credeva Gesù Cristo e che nel 1972 ha preso a martellate la Pietà di Michelangelo nella basilica di San Pietro: lui sì che ha rischiato di rovinare un capolavoro. Oppure, per non andare troppo lontano, chi ha imbrattato la Danza macabra di Pinzolo, in provincia di Trento. Ma via, non esageriamo: la Plappermutter di Bolzano (tradotto, potrebbe significare qualcosa come la “Madonna del bla-bla” e non a caso la devozione popolare la considera protettrice dei bambini balbuzienti) è “semplicemente” di Friedrich Pacher, un artista pressoché sconosciuto al di fuori del Tirolo. E poi l’affresco era già molto rovinato. Per farla breve, che sarà mai quella specie di epigrafe, gay...
Anche i vandali non sono più quelli di una volta. Oggi hanno il braccio corto: non hanno nemmeno il coraggio di fare un bel danno irreparabile. Quanto agli insulti, viene persino da sorridere. Una grande scritta, sempre in vernice rossa, era comparsa nel 1994 su un’altra Madonna con bambino, quella della Fuga in Egitto dipinta da Renato Guttuso alla terza cappella del Sacro Monte di Varese, un luogo dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. POGGIOLINI LADRO, campeggiava sul murale. Un riferimento alle straordinarie gesta di Duilio Poggiolini, l’ex direttore del servizio farmaceutico nazionale, colto con le mani nel sacco, pardon, nel pouf del salotto, dove nascondeva i soldi delle mazzette. Un insulto vero, non come “gay”. I giornalisti hanno esagerato, come al solito. Forse quel giorno non avevano niente di più importante da raccontare. A Bolzano, in fondo, è stata una ragazzata.
Facile pensarla così. Anzi, comodo. Invece, se si va un po’ in profondità, se si vogliono davvero vedere le cose, si scopre che le tre lettere buttate lì, quello sprezzante “gay”, non sono il risultato di una notte di birra piena. Tutt’altro. Sono il più evidente segnale di un’Italia che non riesce a crescere, ferma agli anni Cinquanta, mentre il resto del mondo va avanti. Un’Italia chiusa in se stessa, che trasforma il diverso in nemico. Dove i pregiudizi rappresentano la regola, i diritti (civili) l’eccezione. E dove i sacri principi di libertà e uguaglianza, nella migliore delle ipotesi, sono un ricordo degli anni scolastici. Un paese incapace di essere normale.
Alla faccia del can-can mediatico. Gli italiani sanno bene che dare del ladro a qualcuno, ormai, è un complimento. Se lo si vuole insultare gli si dà dell’omosessuale. O in generale del diverso. Basta guardare il “volgarometro” stilato da «Focus». “Vaffanculo”, “puttana”, “cornuto” sono reperti archeologici. Secondo un’indagine condotta dal mensile, la peggiore offesa che circola nel Belpaese è proprio “gay”, declinata in tutte le sue forme regionali più o meno triviali: “culattone” in Lombardia, “frocio” nel Lazio, “ricchione” in Puglia, “puppu” in Sicilia, e via di questo passo. Al secondo posto si colloca “handicappato”. Seguono “mafioso” e “terrorista”. “Comunista” è più tollerabile di “nazista”.
La conferma, uguale e contraria, viene niente meno che dalla Corte di Cassazione. Che nel marzo 2010 ha emesso una sentenza destinata a scatenare polemiche e nel contempo a segnare un punto fermo nella giurisprudenza: dare del gay è effettivamente un insulto. Il signor Dante, vigile urbano di Ancona, lo aveva addirittura messo nero su bianco in una lettera inviata al suo collega Luciano. Si faceva riferimento a una vacanza con un marinaio e altre cosette del genere. Non allusioni, roba pesante. Gettato il sasso, in giudizio la difesa provava a ritirare la mano: «Il termine gay di per sé non è offensivo». Giusto, giustissimo. Peccato che viviamo in Italia e che la Cassazione, in questo caso, sia scesa con i piedi per terra: usare il termine gay per denigrare una persona non si può. Di più: sconfina nel reato. Risultato: una multa di 400 euro per ingiuria.
Benvenuti in Italia. La patria del diritto, all’ultimo posto nella tutela del primo diritto: il diritto all’amore. Il paese dove si parla di Pacs, Dico, Cus, Didorè e che alla fine si divide puntualmente in rigidi schieramenti ideologici. Cosicché non si riesce a varare uno straccio di legge per eliminare le discriminazioni delle coppie di fatto, anzi delle “coppie non coniugali”, come sarebbe più giusto chiamarle, visto che non è certo per colpa loro se restano “di fatto” e non diventano “di diritto”. Figurarsi poi riguardo agli omosessuali. La vicenda della Plappermutter di Bolzano, il “volgarometro” di «Focus», la disquisizione giuridica della Corte suprema sono niente. Ben più grave è quando dalla parola gay si passa alla violenza sui gay. Ma non c’è da stupirsi: se questo è il clima, l’omofobia va a nozze. A volte sotto forma di botte vere e proprie. Non per nulla le aggressioni, le rapine, le semplici intimidazioni a base di insulti si moltiplicano da Nord a Sud. Due ragazzi picchiati in corso Lodi, a Milano. Un professore accerchiato da tre skinhead a Napoli («E in questura mi hanno pure irriso...»). Un giovane preso a pugni a Firenze, al termine di una manifestazione proprio contro l’omofobia. Due ragazzi aggrediti a Padova perché giravano abbracciati. Senza contare il crescendo di episodi di brutalità che, a partire dal 2005, anno dell’uccisione del trentacinquenne Paolo Seganti, si ripetono a Roma e dintorni. Si mena e si scappa, senza andare tanto per il sottile. A Ostia un gruppo di ventenni ha massacrato un coetaneo al grido di “frocio comunista” solo perché era vestito in modo un po’ eccentrico: il poveretto tornava da un concerto e a casa lo aspettava la fidanzata.
La violenza non è l’eccezione. Non è, purtroppo, il caso limite, isolato. Ma per un attimo lasciamola da parte. A marchiare una persona, a renderle la vita invivibile, è sufficiente essere gay, dichiararsi tale. Nell’Italia del pregiudizio, provare ad accettarsi e a condurre un’esistenza normale è una durissima corsa a ostacoli. E c’è chi non ce la fa. Alfredo Ormando, 40 anni, originario di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e abitante a Palermo, appena giunto a Roma, da un amico, ha raggiunto piazza San Pietro e si è dato fuoco: si è inginocchiato all’ingresso della basilica e a capo chino si è cosparso di benzina. Quasi a scusarsi. A chiedere perdono per chissà quali colpe, come dimostrato dai biglietti che ha lasciato: «Mi tolgo la vita perché, a causa della mia condizione di omosessuale, non sono accettato dalla mia famiglia». I numerosi fratelli non hanno ancora capito le ragioni di quel gesto: « È vero, non andavamo d’accordo, ma non avremmo mai pensato che Alfredo arrivasse a tanto».
Invece... Per arrivare a tanto può bastare anche solo il sospetto, il venticello della calunnia che si insinua piano piano, terra terra, sottovoce, sibilando... «Sei come Jonathan del Grande fratello, un gay, un frocio» gridavano i compagni a Matteo, 16 anni, origini filippine, studente modello della 2a B dell’Istituto per ragionieri Germano Sommeiller di Torino. Poi, dopo che Matteo si è buttato di sotto, professori, genitori, studenti, tutti a chiedersi come mai: «Non ti avevamo capito. Chi ti ha ferito pagherà».
Matteo, Matteo, ma perché non l’hai detto mai? Verrebbe da ricordare una canzone di trent’anni fa del Banco del mutuo soccorso. Poco importa se eri omosessuale davvero. Se lo eri, ti sei tenuto tutto dentro. Ma vivevi in Italia, c’è da capirti.
Negli Stati Uniti, Barack Obama dà il via libera ai gay nell’esercito. Basta con l’ipocrisia del don’t ask, don’t tell, “non chiedere, non dire”, la regola introdotta da Bill Clinton che ammetteva omosessuali e lesbiche nei ranghi a condizione che tacessero sulle loro inclinazioni sessuali. D’ora in avanti, ha assicurato Obama, nell’esercito dovranno esserci pari diritti e pari opportunità per tutti. Non basta. A sancire il nuovo corso, il presidente usa ha nominato un transessuale, Amanda Simpson, consigliere del dipartimento del Commercio. La Simpson, 50 anni, era stata assunta, quando era un uomo, alla Raytheon, colosso che fornisce armamenti e tecnologia alla Difesa, come pilota di prototipi aerei. Diventata donna negli anni Novanta, ha fatto carriera fino a diventare vicedirettore per lo sviluppo hi-tech. Ora, l’incarico governativo.
Si potrebbe andare avanti a lungo. Le catene della discriminazione si stanno spezzando un po’ ovunque: dall’Europa al Sudamerica, al Sudafrica. È lontana l’epoca dell’irruzione della polizia allo Stonewall Inn, un bar gay situato a New York, nel Greenwich Village, cuore di Manhattan. Era la notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 e il sindaco John Lindsay voleva “ripulire” la città. Si ritrovò contro, in un’autentica guerriglia urbana, migliaia di cittadini che rivendicavano parità di diritti per tutti. Il Gay liberation front, nato in quella drammatica occasione, ne ha fatta di strada. Persino a Shangai e Pechino, e nella sterminata provincia della Cina, dove l’omosessualità era considerata una malattia mentale e fino al 1997 un crimine, si stanno diffondendo i locali per omosessuali. Spesso, con il pretesto di prevenire l’aids, a finanziarli sono lo stato o le autorità locali. Nel frattempo, uno dopo l’altro, crollano pregiudizi, schemi mentali, verità consolidate. «Cade l’ultimo tabù del codice d’onore della mafia» ha commentato il «New York Times», dopo che Robert Mormando, 44 anni, uno dei gangster più fidati del potente clan Gambino, davanti al Tribunale distrettuale di Brooklyn, insieme con una sfilza di sparatorie e delitti da farlo finire sulla sedia elettrica ha ammesso: «Sono gay».
In Italia no. Niente di tutto questo. Certo, le Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, con Riccardo Scamarcio, il più amato dalle italiane che gigioneggia nel ruolo di un tenebroso giovane gay, sbancano al botteghino dei cinema. Oppure si assiste a quella che Aldo Grasso, critico del «Corriere della Sera», ha definito «la gayzzazione della televisione»: nei gusti, nei personaggi, nelle tendenze. Volete mettere le presenze all’Isola dei famosi di una Vladimir Luxuria o di un Aldo Busi? Solo che tutto si ferma sulla superficie dello schermo. Segue le ferree logiche dell’Auditel. Basti pensare che Lando Buzzanca, mitico Merlo maschio e Homo eroticus degli anni Settanta, oggi, nella serie Mio figlio di Luciano Odorisio, veste i panni di un padre poliziotto alle prese con i problemi del rampollo omosessuale. Fiction, appunto. Ben diversa è la vita vera. La realtà quotidiana. Quella che ha schiacciato Alfredo e Matteo. E con la quale, nel nostro paese, devono fare i conti migliaia e migliaia di gay, lesbiche, transessuali.
Già il primo passo, dirlo, è difficilissimo. Di fronte a se stessi, ai genitori, agli amici. Figurarsi ai colleghi di lavoro, ai compagni di squadra, magari al marito o alla moglie. Perché è ancora tanto difficile dichiararsi gay titolava Natalia Aspesi la risposta a una lettera in una puntata delle sue Questioni di cuore, la rubrica settimanale sul «Venerdì di Repubblica». Le ragioni sono molte. E note. Ma è per questo che bisogna partire da lì, dal coming out, dall’uscita allo scoperto. Il coming out è il momento chiave, di passaggio. L’ora della verità. Il gesto di libertà necessario per riprendersi la vita. Perché no, quella felicità che secondo lo scrittore Guido Morselli, a suo modo un diverso (e non a caso morto suicida), non è un lusso. Ma nello stesso tempo il momento da cui partono l’emarginazione, la ghettizzazione, le discriminazioni.
Meglio tacere, dunque? Fare finta di niente e sperare che nessuno se ne accorga? O al contrario, pregare perché qualcuno, finalmente, se ne accorga? E poi, alla base di tutto, perché dirlo? Non sarebbe bello che fosse una cosa semplice, naturale, al punto da non doverla nemmeno dire? In fondo, se uno è mancino, mica lo dichiara: «Guardate, vi avverto subito, io sono mancino».
Sono domande che mi pongo tutti i giorni. Fin da quando ero ragazzo e cominciavo a capire che in me c’era “qualcosa che non andava”. Chiaro, ognuno ha la sua esperienza, il suo vissuto. I suoi slanci e le sue paure. Magari esistessero regole. Meglio, magari fosse tutto così “normale” da non dovere nemmeno pensare a delle regole per quel passo decisivo: “dirlo”. Per quanto mi riguarda, posso semplicemente raccontare la mia storia. Partendo da una serie di riflessioni e di insegnamenti che ho messo a fuoco quasi per caso, passando da un aereo a un altro.
Il mio lavorare in giro per il mondo ha fatto sì che assistessi, forse per migliaia di volte e in molte lingue, a quella specie di cerimonia rituale che gli assistenti di volo devono compiere all’inizio di ogni viaggio: l’illustrazione delle misure d’emergenza a bordo. Ecco, se qualcuno mi chiedesse per quale motivo è stato così importante per me fare coming out, poter “dire” della mia omosessualità, risponderei con uno dei passaggi chiave delle procedure di sicurezza in volo: «In caso di depressurizzazione della cabina, le maschere per l’ossigeno saranno rilasciate automaticamente. Prendete una maschera e tiratela verso di voi, coprite naso e bocca e respirate normalmente. Assicuratevi di avere indossato la vostra maschera prima di aiutare altri passeggeri». Il messaggio è chiaro: per potere compiere qualsiasi gesto, incluso dare una mano al prossimo, la prima cosa da fare, anche nella peggiore delle situazioni, anche nel malaugurato caso che si depressurizzasse la cabina dell’aereo sul quale state viaggiando, è assicurarsi di essere vivi e di stare bene. Se non si hanno energie sufficienti per aiutare se stessi non si può pensare di essere di qualche utilità agli altri.
La Costituzione degli Stati Uniti prevede il diritto alla felicità come diritto a perseguire il progetto di vita di ogni individuo. Bene, l’importanza di fare coming out consiste, credo, nel manifestarsi al mondo nella propria completezza e nella possibilità di vivere pubblicamente e socialmente l’aspirazione alla propria felicità. È una sensazione di pienezza, una rotonda solidità difficilissima da raggiungere, difficilissima anche solo da descrivere. L’immagine più vicina è quella di una riparazione, del riempimento di una fessura, della cucitura di uno strappo, del riaggiustamento di qualcosa che si è rotto o spezzato, del ritorno pieno e sereno alla perfetta e levigata rotondità di una sfera.
Occorre cominciare da questo, dal senso di profonda inadeguatezza che prova una persona omosessuale sin dall’infanzia più tenera. Non c’è modo di spiegare. Ma io ho memoria del fatto di avere avuto “un problema” da sempre, dal tempo dei primi ricordi. È una cosa che sta lì con te, che non sai verbalizzare, che non hai la possibilità nemmeno di definire. Io, però, anche da bambino, ho sempre saputo di non essere come gli altri bambini. Non capivo cos’era che mi rendeva diverso da loro e da quello che avrei dovuto essere. Ma avevo la consapevolezza che per qualche ragione non ero adeguato a quello che era stato predisposto e previsto per me nella società. Era una sensazione incombente, sgradevole, pesante, come il sentire un macigno nella pancia, una roba che prima o poi avrebbe dovuto essere gestita, una specie di cambiale che sarebbe venuta a scadenza. Una sensazione di malessere costante, come un sibilo in un orecchio, una di quelle cose con le quali ti abitui a convivere ma che temi non andranno mai via. Come una carovana che parte per una traversata nel deserto sapendo che presto o tardi sarà attaccata dai predoni e fa mesi e mesi di viaggio con le vedette che scrutano l’orizzonte, sempre con l’ansia di essere assalita. Il forte che vive nell’attesa dei Tartari. Certus an, incertus quando, dicevano i giuristi romani. Certo nel se, incerto nel quando: il verificarsi dell’evento temuto è sicuro, ineluttabile, si deve solo aspettare che accada.
È una sensazione di angoscia dolorosa e tagliente, una specie di senso di limitazione, qualcosa che ti costringe a trattenere il fiato, a rimanere costretto, con la testa un po’ incassata tra le spalle. Lo starter della pistola al via di una corsa: tu sei come l’atleta, aspetti il colpo che sta per arrivare e resti con i muscoli e i nervi tesi, perché non sai se sarà in questo secondo, in quello dopo o in quello dopo ancora. L’unica certezza è che questa brutta faccenda prima o poi dovrai affrontarla, anche se non hai ancora capito bene che cos’è e non hai la più pallida idea degli effetti che si scateneranno quando bisognerà parlarne, quando nasconderla non sarà più possibile. La certezza è che si tratterà di un evento traumatico. Infatti, non sarai mai tu così pazzo da tirarla fuori, questa roba così tremenda e vergognosa. Verrà fuori contro la tua volontà e tu sarai probabilmente finito, non ci sarà altra strada che sparire, perché nessuno ti vorrà più, nessuno ti amerà più, i tuoi genitori si vergogneranno di te e si pentiranno di averti messo al mondo.
Immagino che ad Alfredo, in rotta con la famiglia al punto di darsi fuoco in piazza San Pietro, e a Matteo, preso in giro dai compagni di scuola fino a buttarsi nel vuoto, siano passati in testa esattamente questi pensieri. Il dramma è che in loro, come in molti altri nella stessa situazione, il senso di colpa, di inadeguatezza, addirittura la vergogna, hanno avuto il sopravvento sulla voglia di vivere.
Per dare un’idea di quanto teatrali e paradossali diventino le fantasie sul momento dello svelamento, ricordo che per anni nell’adolescenza ho vissuto nel terrore della visita militare. Mi era stato detto che in quella circostanza ci sarebbe stato l’esame ai genitali e che tutti i coscritti sarebbero rimasti nudi come vermi per potere essere ispezionati dal medico. Nei miei incubi di ragazzino, io che avevo accuratamente evitato ogni situazione che potesse creare imbarazzi (palestre, piscine, spogliatoi) immaginavo di essere vittima di un’enorme, incontrollabile erezione, una cosa equina, una roba alla Tinto Brass, che mi avrebbe scoperto e svergognato davanti a tutti. Può apparire eccessivamente drammatico, ma è proprio quello che pensavo. E capisco bene, ora che di anni ne ho quarantacinque, che queste ansie terribili avevano dentro di sé un penetrante odore di morte.
Alla fine, questo è il senso profondo del coming out, se e quando risulta dall’approdo alla piena accettazione di sé: è la rottura del ricatto, la fine di una minaccia, il ritorno a riveder le stelle, il decidere che nessuno potrà farti più del male. Né farti sentire inferiore, per riprendere la famosa frase di Eleanor Roosevelt. Mettere la mascherina, coprire naso e bocca, e finalmente respirare.
C’è una cosa che rende i gay nella loro infanzia completamente diversi da qualsiasi altra minoranza. La nascita di un bambino nero, di un bambino rom, di un bambino ebreo o semplicemente di una bambina (perché, non va dimenticato, essere “diversi” non è un fatto puramente numerico: le donne, in una società maschilista, rimangono una minoranza pur essendo numericamente in maggioranza) rappresenta sempre un evento di grande festa per le famiglie e per le comunità di appartenenza. Il fatto stesso che una nuova vita e un nuovo membro della comunità sia arrivato viene celebrato come una benedizione: per quanto si sia “diversi” nel mondo di fuori, almeno in famiglia si è uguali ai genitori, ai fratelli, ai nonni. Un bambino gay ha invece la particolarità di non potere condividere la propria diversità con la famiglia di origine. Non potrà quindi appoggiarsi su nessuno per superare le frustrazioni, le difficoltà, i pericoli legati all’appartenenza a una cultura che non è quella dominante. Risultato: la vita in famiglia, che in genere è l’oasi di protezione e di ricarica, diventa un ulteriore luogo di difficoltà e di rifiuto.
Un bambino, pure nella peggiore situazione, come nel S...