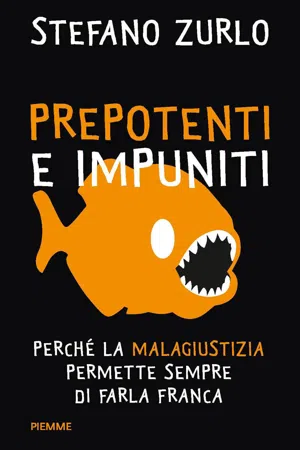![]()
Grande lavoratore, grandi ritardi
Il magistrato è un gran lavoratore, ma grandi sono anche i ritardi dei suoi provvedimenti. È un paradosso tutto italiano quello del giudice Antonio T., in servizio al tribunale di una città della Sicilia. Pure lui, come Gino G., sembra il protagonista di una trama schizofrenica, double face: un impegno straordinario e nello stesso tempo amnesie spaventose. Non è un’esagerazione. Fra il 20 aprile ’94 e il 9 novembre 98 Antonio T. deposita i suoi verdetti decine di volte oltre i tempi canonici. Per essere precisi, arriva in affanno 91 volte su un totale di 312. Il ritardo oscilla fra i 120 e gli oltre 700 giorni: 700 giorni sono quasi due anni. Si potrebbe pensare che Antonio T. abbia impostato male all’origine il suo lavoro, che non si sappia organizzare oppure, peggio, che sia un fannullone. Strano, perché a distanza di qualche riga, lo stesso Csm parla di una «diuturna e incessante attività di udienza e di camera di consiglio». Dove quel diuturna, aggettivo da chiesa, dà quasi un’impronta di abnegazione religiosa alla sua attività. Che è paradossalmente fittissima. Il Csm annota che «i provvedimenti depositati tardivamente (numero 91 sentenze civili) costituivano una piccola porzione rispetto alla grande mole del lavoro svolto nell’ ambito della sezione fallimentare del tribunale, pari a 312 sentenze civili, 7.322 provvedimenti fallimentari, comprese 249 sentenze dichiarative di fallimento».
Insomma, l’imboscato è tale solo per le tabelle e i carichi di lavoro dei tribunali italiani, perché in realtà è un mezzo stakanovista. Addirittura, quasi un eroe sul lavoro se si legge il breve ritratto del magistrato che va in ufficio, anche se flagellato da fastidiosissimi disturbi: «Prestava il suo impegno lavorativo, nonostante le infermità, consistenti in una gravissima dermatite di accertata componente psicosomatica, esplosa proprio qualche mese dopo l’immissione in servizio presso la sezione fallimentare, con quotidiana insorgenza di ulcerazioni alle palpebre e alle mani, continue fitte dolorose al semplice movimento delle dita, conseguente penosità nella redazione di scritti». Siamo dalle parti di De Amicis e di Cuore, quasi ci si commuove a leggere queste righe.
Che dire? Antonio T. ha fatto tutto quello che poteva, ma il suo impegno non è sufficiente. E i dati, dati negativi, tornano ancora una volta in primo piano: «Il totale dei giorni di ritardo cumulati… è pari a 19.681 con una media di 206 giorni a provvedimento». Siamo ancora una volta al paradosso del magistrato superimpegnato che però finisce, come Gino G., sotto procedimento disciplinare.
Com’è possibile? Una spiegazione, quasi ovvia, la dà lui ricordando la drammatica situazione «in cui versava la sezione fallimentare con un organico inferiore rispetto alle esigenze e pari a soli sette magistrati, costantemente gravati, ciascuno, mediamente di 600 procedure fallimentari, 400 procedure esecutive immobiliari, 500 ricorsi per la dichiarazione di fallimento, 700 controversie fallimentari, nonché di una miriade di istanze dei curatori».
Insomma, Antonio T. deve svuotare il mare dei processi con la paletta e il secchiello della sua fatica quotidiana. Un’impresa disperata. E dunque il magistrato si può collocare idealmente al fianco di Gino G. Ricordate? In un’altra città siciliana, Gino G. viaggiava anche con 469 giorni di ritardo. Un’umiliazione per la giustizia italiana, ma alla fine il Csm l’aveva riabilitato elencando la sua quasi incredibile attività “multidisciplinare”: la normale destinazione come componente della prima sezione della corte d’appello civile della città, il maxi processo con i pernottamenti in camera di consiglio e tante altre attività fra cui, persino, la partecipazione alle sedute della Commissione per la manutenzione dei locali e dei beni mobili degli uffici giudiziari. Di tutto e di più.
Con il risultato di costringerlo a estenuanti tour de force e a inseguire migliaia di pratiche in perenne affanno. Così alla fine il Csm aveva “processato” chi aveva promosso il suo processo bacchettando le «improvvide iniziative disciplinari», avviate dalla procura generale presso la Cassazione. E assolvendolo. Come il collega. L’assoluzione, a questo punto scontata, arriva il 22 settembre 2000 anche per Antonio T. Tutto fuorché uno scansafatiche. I ritardi, tanto per cambiare, resteranno senza colpevole. Lui, invece, può mettere in bacheca l’elogio del presidente della sezione che gli tributa una sorta di standing ovation: «La sua produzione lavorativa è stata notevole per numero e qualità, lo stile dei suoi provvedimenti è stato sobrio ed elegante, le argomentazioni giuridiche appropriate, il suo attaccamento all’ufficio veramente encomiabile». E ancora il presidente esprime gratitudine a Antonio T. «per non aver mai fatto mancare la sua quotidiana presenza in ufficio, anche nei periodi in cui il suo stato di salute (eritema diffuso alle mani e al viso) avrebbe richiesto maggior cura di se stesso e, prudenzialmente, un distacco dalle carte». Le carte. Le sudate carte. Siamo sempre fra De Amicis e Leopardi. O forse Alfieri. Chissà perché il povero Antonio T., dopo essersi fatto stoicamente in quattro, è finito addirittura davanti alla Disciplinare.
Il bambino viene prima delle sentenze
Il giudice fa ritardo. Come i treni dei pendolari. Non una ma 212 volte: 212, come le ordinanze che non hanno rispettato i tempi. Il giudice fa ancora ritardo, 15 volte: 15, come le sentenze, sentenze civili al pari delle ordinanze, che i suoi “clienti” hanno atteso per mesi, con punte di 328 giorni. Il giudice è una donna. Il giudice ha un alibi – ci si passi il termine – formidabile: ha adottato una bambina. Una neonata di soli 8 giorni. Di più. L’affidamento preadottivo le è stato comunicato con un preavviso di sole 24 ore. Ore che cambiano la vita, la riempiono, danno nuove emozioni e responsabilità. Ma sono anche una tegola in testa alle persone che aspettano un provvedimento: ordinanza o sentenza, poco cambia. Quella bambina, attesa e inaspettata, deve avere la precedenza e infatti l’ha avuta, relegando per mesi le carte del tribunale in un angolo. O, come si dice, in un cassetto.
È una storia che fa riflettere quella che arriva dalla Toscana. La solita storia, noiosa, da sbadiglio, delle cause che si accumulano sulle cause. Sorpresa: il motivo non è strutturale. Non è il sistema che fa acqua, come spesso denunciano le toghe, non è il famoso sovraccarico di lavoro, i troppi fascicoli sulle spalle del singolo magistrato. E neppure si deve puntare il dito, ipotesi alternativa, contro l’inefficienza di un giudice svogliato, demotivato, con poca voglia di lavorare. No, l’ingranaggio si è bloccato per la più nobile delle ragioni. L’adozione. Un’adozione che ha sconvolto l’esistenza del giudice nel giro di 24 ore.
In verità la giudice ha un secondo alibi. Questo sì più legato all’andamento del sistema. La dottoressa Monica V. si ritiene infatti giustificata non una ma due volte: la prima perché le è arrivata la figlia, la seconda perché l’hanno trasferita da una città all’altra della Toscana e qui la sua carriera ha incrociato una delle tante riforme varate per migliorare la sempre malfunzionante macchina della giustizia: quella del giudice unico. Così, di botto, si è ritrovata con un ruolo pesantissimo, pari a circa 2.500 cause. Tante. Troppe. Sappiamo come vanno le cose in Italia: il giudice unico è stato pensato per razionalizzare gli uffici. Si è detto che l’abolizione della pretura e l’incorporazione dei pretori negli organici del tribunale avrebbe favorito la moltiplicazione delle energie e delle forze in campo. Può essere, ma alla fine i cambiamenti devono fare i conti con le realtà locali. Nella città in cui Monica V. è stata trasferita c’è stato, in seguito alla riorganizzazione, «l’esodo di alcuni magistrati», per usare l’espressione poco fantasiosa coniata dal Csm. E con l’esodo la «scopertura di organico». Risultato: MonicaV. si è trovata addosso 2.500 cause. Insomma, la riforma ha funzionato alla lettera. Giudice unico, perché c’era solo lei. Anzi, giudice dimezzato. In astensione obbligatoria per maternità dal 24 dicembre ’98 all’11 maggio ’99. L’11 maggio rientra in ufficio. Nel giro di pochi giorni, gli ultimi in quella città, deposita molte sentenze. Poi dal 22 maggio e fino al 31 luglio torna a casa per un periodo di astensione facoltativa per maternità. Siamo in piena estate e scattano le ferie che, come si sa, per i magistrati sono molto lunghe.
Il 1° settembre Monica V. inizia la sua attività nella nuova sede. E si trova a dover gestire tutti quegli incartamenti e addirittura l’intero carico civile della ex pretura. Un compito pesante, da svolgere in solitudine, anche perché la sua collega che dovrebbe affiancarla è a casa, combinazione, per una maternità a rischio. Maternità a rischio. Adozione. Traslochi in coda alla riforma. Risultato: non uno, ma due tribunali vanno in affanno. E il giudice Monica V. si trova a dover fronteggiare ben due azioni disciplinari davanti al Csm.
La prima: l’ispezione, che si è svolta fra il 4 aprile e il 10 giugno 2000, mette in rilievo i «gravi ritardi, non inferiori ai 122 né superiori ai 328 giorni», nel deposito di quindici sentenze; la seconda: promossa il 25 gennaio 2001, ha nel mirino il periodo iniziale nella nuova realtà e deve fare i conti con 212 ordinanze, depositate in parte ben oltre i 30 giorni canonici, e per il resto ancora in alto mare al momento dell’ispezione.
I due procedimenti vengono riuniti. Lei si difende, cominciando dal capitolo numero uno. Spiega: «Dal 24 dicembre ’98 era stata in astensione per maternità a seguito di affidamento preadottivo e quindi di adozione di una bambina di soli 8 giorni. Poiché il provvedimento di affidamento preadottivo le era stato comunicato con un preavviso di sole 24 ore, non aveva avuto il tempo di organizzare preventivamente il proprio lavoro prima dell’inizio del periodo di astensione». Più chiaro di così.
Il Csm studia e le dà ragione: «Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalla lavoratrice che abbia adottato o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore ai sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento. Il congedo dev’essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. Durante tale periodo, in tutto parificato al congedo post partum, la lavoratrice non è tenuta alla prestazione lavorativa e al datore di lavoro è fatto divieto di esigerla». Il Csm si schiera dunque con il magistrato che è sotto accusa. Possono esserci dei dubbi? No: «Il Csm, con la risoluzione dell’11 novembre ’98, ha inteso precisare che nel periodo pre e post partum e nelle altre ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, venendo meno l’obbligo della prestazione lavorativa, il magistrato non è neppure tenuto a redigere le motivazioni delle sentenze». Che poi è qual che è accaduto. Il giudice ha smesso di lavorare. E senza preavviso. L’ufficio si è fermato. I cittadini sono rimasti parcheggiati in stand by. Pazienza.
La contestazione evapora: «Nel caso che ci occupa non vi è dubbio che la dottoressa Monica V. avesse diritto di fruire del congedo di maternità dal 23 dicembre ’98, giorno in cui ha avuto in affidamento, provvisorio prima e preadottivo poi, una bambina di soli 8 giorni di vita, per un periodo di tre mesi e cioè fino al giorno corrispondente del terzo mese successivo, vale a dire fino al 23 marzo ’99. Tale lasso di tempo va quindi scorporato dal computo dei termini di deposito delle 15 sentenze indicate nella prima parte del capo di incolpazione».
Dunque la coperta del Csm copre buona parte del periodo di blocco. Non fino all’11 maggio, ma almeno fino alla data del 23 marzo. Il capo d’incolpazione frana: «Ne viene di conseguenza che la maggior parte dei ritardi contestati sono insussistenti e che solo 3 delle 15 sentenze di cui all’addebito sono state effettivamente depositate fuori termine, con ritardi che, per le considerazioni sopra esposte, risultano notevolmente inferiori a quelli contestati».
Certo, l’adozione, improvvisa, ha scombussolato i ritmi del tribunale ma questo pare essere un problema secondario. E che comunque non ha rilevanza ai fini del processo. La prima accusa cade nel niente.
Capitolo numero due. Il Csm mette le mani avanti: «La sezione deve valutare se la causa dei non contestati ritardi nel deposito di 212 ordinanze civili riservate sia da rintracciarsi nella negligenza e nella mancanza di laboriosità della dottoressa Monica V., configurandosi una condotta da parte del magistrato disciplinarmente rilevante e sanzionabile, oppure se sussistano quelle circostanze che, per consolidata giurisprudenza della sezione confermata dalle sezioni unite della Cassazione, possono giustificare il fatto obiettivo contestato, togliendo alla condotta dell’incolpata la connotazione di illecito disciplinare».
La risposta è lampante, le testimonianze schiaccianti «per quanto riguarda la situazione dell’organico della pretura le cui gravissime carenze hanno determinato al momento dell’unificazione degli uffici, il sommarsi di più ruoli sulle spalle dell’incolpata, fino alle conseguenze insostenibili che sono state sopra evidenziate».
Del resto la radiografia di quei mesi di passaggio dal vecchio sistema al nuovo, annunciato sui giornali fra squilli di tromba, mostra i guasti, anzi i vuoti aperti dai trasferimenti di diversi magistrati: «Il ruolo inizialmente assegnato alla dottoressa Monica V. fu di circa 2.500 cause civili provenienti da magistrati diversi, fra cui alcune centinaia, quelle del dottor B., trasferito il 15 dicembre ’98, congelate da circa un anno, tanto che nel periodo settembre-dicembre ’99 si resero necessarie, per la riorganizzazione del lavoro, ben 24 udienze di smistamento, oltre alle normali udienze istruttorie. In tali udienze, con un ruolo per ciascuna udienza di oltre 100 cause, l’incolpata si trovò nella necessità di trattenere in riserva un numero elevatissimo di cause, dovendo decidere su istanze urgenti, come le richieste di esecuzione provvisoria di decreti ingiuntivi opposti, da tempo giacenti, il cui esame non poteva essere ulteriormente rinviato”.
Dunque, in quei mesi di passione e di inevitabile confusione, Monica V. ha fatto quel che ha potuto. Ha scritto ordinanze al volo, le più urgenti, ha preso tempo dove poteva. Ha cercato di mandare avanti l’ufficio, in pratica tutta l’ex pretura civile, facendo i salti mortali. Perché la pretura era scomparsa, ma le cause, naturalmente, erano rimaste, solo erano passate al tribunale. E non basta una verniciatura alla terminologia antiquata per smaltire l’arretrato e trovare d’incanto un ritmo veloce.
Il Csm corre verso l’assoluzione notando che nel trimestre ottobre-dicembre ’99 la dottoressa Monica V «è stata oberata da un carico di lavoro davvero eccezionale». Altro che condanna. Monica V. «si è meritata generale riconoscimento e considerazione, proprio in ragione del carico di lavoro che si è sobbarcata per evitare il congelamento ulteriore dei ruoli ereditati dai colleghi trasferiti».
Il 19 aprile 2002 arriva l’assoluzione. Per tutti e due i capi d’accusa. Le 212 ordinanze e le 15 sentenze con ritardi di mesi e mesi sono ancora una volta orfane. Nessuno ha sbagliato. I cittadini, alle prese con i problemi, le ansie e le aspettative di una causa, se ne faranno una ragione.
Il giudice? Sospetti sul suo equilibrio mentale
La prosa è oltre ogni aggettivo. Due righe due del ricorso scritto dagli avvocati e regolarmente presentato alla corte d’appello di Milano tolgono ogni dubbio anche ai più scettici: «Qualche cosa vi è ancora da aggiungere – scrivono i due legali – ed è il nostro sbigottimento di fronte alla glaciale indifferenza con la quale il giudice di primo grado non ha neppure voluto prendere in considerazione la morte di un uomo e la distruzione della sua famiglia ricollegabili, presumibilmente, all’operato di un datore di lavoro senza scrupoli». Si possono lanciare parole così taglienti in faccia al giudice? A quanto pare sì, succede, è successo. In atti ufficiali. Atti che finiscono in mano ad altri giudici. Atti che lasciano sgomenti. Perché i processi sembrano trasformarsi in regolamenti di conti. In requisitorie ululate che solo con uno straordinario sforzo di compostezza si possono definire sopra le righe. Altro che sopra le righe.
Ecco un altro brano ad alzo zero, sempre farina della coppia di legali: «Con tale, incredibile motivazione, senza entrare nel merito, il giudice di primo grado rigettava la domanda della povera vedova che avventatamente era ricorsa a lui credendo nella giustizia». E poi il passaggio più incredibile. Affilatissimo: «Il giudice di primo grado è un tipo particolare, ma non tutti i giudici sono come lui. Alcuni colleghi sono ricorsi contro di lui al Consiglio superiore della magistratura: il Consiglio dell’ordine [degli avvocati, N.d.A.] ha chiesto che fosse spostato altrove. Ma – come dice sempre Francesco Saverio Borrelli – alcuni giudici hanno i santi in paradiso. Non sono nostre giustificazioni a posteriori, legga bene la sentenza. L’avvocato che si è scelto, perché esperto in diritto del lavoro, viene ridicolizzato in modo così insistito da far sorgere qualche sospetto sull’equilibrio mentale del giudice».
Sospetti sulla personalità del giudice. Accuse gravissime. Insulti. Così una causa di lavoro, partita dal tribunale di una citta lombarda, si trasforma in una fitta sassaiola. Il giudice ha strapazzato gli avvocati, in primo grado, e loro gli restituiscono il favore, in appello. Da mettersi le mani nei capelli. Uno spettacolo avvilente.
Il giudice del lavoro si è sadicamente divertito nel fare a pezzi i ragionamenti dei due legali che peroravano la causa di una giovane vedova, licenziata da un datore di lavoro senza scrupoli. Il magistrato non si è risparmiato nulla: «La difesa ha usato equivocamente termini atecnici»; «Il ricorso è indecifrabile»; «La sua impostazione è un elemento di sconcerto per la difesa»; «Le frasi del ricorso appaiono ermetiche e di scarso significato per il giurista»; «La richiesta del danno è sconcertante». Infine, il complimento più alto: «Il ricorso appare giuridicamente incompleto e processualmente confuso».
Loro gli rispondono riga per riga, in una Stalingrado giudiziaria. «La signora Emma B. si era rivolta, disperata, a lui. Lui non l’ha degnata neppure di uno sguardo, povera, giovane vedova ancora fiduciosa nelle sue ultime speranze processuali. Il giudice si è fermato, tutto sussiegoso, alle parole che possono scappare di bocca a una vedova affranta e, snobbando il suo dolore, si è messo a farle una lezioncina (quanto mai irriverente, dato l’oggetto del processo; irritante per la sua ostentata fatuità; offensiva per un giurista, per l’uso perverso del potere giudiziario) sui commi 2, 3 e 4 dell’articolo 414 del codice di procedura». Procedura civile, naturalmente.
L’articolo 414 indica alcune regole elementari da seguire per costruire la domanda da girare al giudice. Regolette basiche sulla «forma della domanda». Il comma 2, per esempio, specifica che il ricorso «deve contenere il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto: se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto». Pedante. E noioso. Ma necessario. Siamo dalle parti dell’abc, come si vede. E i commi 3 e 4 non vanno molto più lontano. Il 3 dice che «il ricorso deve contenere la determinazione dell’oggetto della domanda»; il 4 che «il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni». Siamo davvero ai fondamentali. Come dire, che al calcio si gioca in undici per squadra, con un pallone e senza poter toccare la sfera con il braccio o la mano. Niente di più.
Il giudice ha dichiarato nullo il ricorso, fra l’altro, per la vaghezza dell’oggetto della domanda e per l’equivocità delle conclusioni processuali, saccheggiando il comma 3. Gli avvocati non ci stanno e reagiscono cannoneggiando la sua sentenza: «Il giudice, rilevato che il ricorso era indecifrabile relativamente alle domande di risarcimento per mobbing da delitto, si dedica subito dopo – su suggerimento di controparte – a rilevare la nullità per confusione…».
La nullità per confusione è un unicum, un pezzo da museo nel variegatissimo panorama del diritto italiano. I due legali proprio non accettano l’idea di finire in vetrina, come esemplari di una specie rarissima, anzi mai vista prima e il cui tratto distintivo è l’ignoranza assoluta. «Viene solo da ridere – rispondono – e non sprechiamo alcuna parola per dimostrare l’inconsistenza dell’assunto della difesa delle convenute fatto irrefrenabilmente proprio dal giudice astioso e vendicativo. Il fastidio è quello – mentre scriviamo – di trovarci di fronte a finti tonti (sì, a finti tonti: quello che ci vuole ci vuole)». Perché finti tonti?
Perché, secondo il giudice, le conclusioni sub D e sub E «sarebbero duplicate». Un doppione. E invece no: «La conclusione sub D riguarda l’illegittimità del licenziamento a causa di matrimonio, quella sub E l’illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa».
Si può anche entrare nel tecnico, ma non ci interessa. Quel che ci preme mostrare è il livello, assolutamente fuori da ogni regola minima di educazione, che si svolge fra i legali e il giudice. «Il dottor Duilio D. fa il giudice del lavoro da trent’anni – prosegue implacabile la coppia – che non sappia ancora la differenza fra le due ipotesi legislative umilia persino noi, stanchissimi collaboratori di giustizia».
La requisitoria non si ferma. I due saranno stanchissimi nel collaborare con la giustizia, ma nel fronteggiare il magistrato devono avere una riserva di energie inesauribile. E non gli lasciano passare nemmeno mezza parola. Dopo aver toccato il comma 3 del solito articolo 414, il giudice è passato al successivo, il numero 4. Insomma, dalla determinazione dell’oggetto della domanda, che gli avvocati non sarebbero riusciti a mettere a fuoco, Duilio D. è transitato all’esposizione dei fatti. E ancora una volta ha bacchetto i legali per la loro vaghezza. Nuovo scontro, anzi ulteriore mischia da rugby più che da calcio: «La nostra fatica professionale – cinquanta pagine di minuziosa esposizione in fatto e in diritto – viene graziosamente definita vaghezza dal dottor Duilio D. Non ci ha consentito di discutere nel merito, non ha sentito un solo teste. Si fissa maniacalmente su un particolare irrilevante […]. Una stupidaggine, un’ulteriore stupidaggine».
Siamo al tiro al bersaglio. «Poi c’è la trovata dell’erede: l’unica domanda che ha fatto il giudice alla ricorrente in apertura dell’udienza è stata infatti questa: “Suo marito aveva altri parenti?”. Voleva già pregiudizialmente incastrare la povera giovane vedova e l’ha bacchettata, come al solito, a sproposito. Perché questa intromissione di un giudice del lavoro in un rapporto familiare estraneo al processo? Persino la difesa di controparte non aveva sollevato questa antipatica eccezione. Potremmo rispondere che i rapporti fra il ricorrente e il fratello del defunto marito sono cavoli loro (per il vero non...