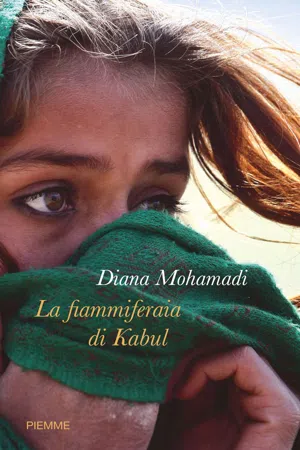![]()
33
“Give me five”
Questa settimana ho provato sentimenti confusi. Non voglio cadere nel patetico, non mi va di farmi compatire. Io vorrei continuare a essere la Diana vivace e ribelle di sempre. Ma a volte la realtà mi raggiunge e allora avverto tutta l’angoscia e l’incertezza del mio futuro. Mio padre è ripartito questa mattina presto e questo mi ha reso subito malinconica. Ho sentito aprirsi una frattura. Nei pochi giorni in cui papà è rimasto a casa, mi ha fatto piacere ritrovare l’autorità paterna. Tutti erano disciplinati, tutti obbedivano agli ordini. Nessuno di noi ha cercato di sottrarsi ai propri compiti come facevamo con la mamma. Questo pensiero mi ha riempito di tristezza, perché la sua partenza significa il ritorno all’anarchia, alle urla e al disordine. I miei fratelli più piccoli, Djamal e Bilal, sono quelli che patiscono di più. Alla loro età, nove e otto anni, hanno bisogno di una presenza protettrice e autoritaria che la mamma non sa dare.
La vita ha ripreso il suo corso normale. Il blu del cielo inondava la città. Il ramadan sarebbe iniziato presto. Le preoccupazioni di tutti sono tornate a essere molto prosaiche: mettere da parte i soldi per preparare la festa dell’Eid1, sperare che faccia meno caldo durante il periodo di digiuno. Senz’acqua, in questa stagione, il ramadan può essere molto impegnativo.
Abbiamo ricominciato a lavorare sodo per strada per portare a casa più soldi. Di nascosto dalla mamma, ho smesso di andare a scuola tutti i giorni. Mi inventavo delle scuse: capitava sempre più spesso che la professoressa fosse malata o assente. Questo mi consentiva di passare più tempo fuori. La scuola non mi mancava per niente.
Poi un giorno, la rappresentante di classe, Sadjida, è venuta da me. Ha sedici anni, è stata eletta a inizio anno perché è bella e determinata. Tutte in classe l’ammirano e la temono. Sadjida è una spanna sopra a tutte noi. Il suo ruolo consiste nel sorvegliarci e nel riprenderci se facciamo qualcosa di male o di contrario alla morale. Un volta ha fatto mandar via una ragazza che si era tinta i capelli di biondo. Eppure li teneva sotto il velo, e non davano fastidio a nessuno. Io mi rendo conto di essere molto più tollerante delle mie compagne. Io non mi sarei tinta i capelli perché li considero un dono di Dio, ma non mi disturba affatto che altre lo facciano. Sadjida mi fa paura. A me non piace dipendere dagli altri, soprattutto da una ragazza che ha solo qualche anno più di me.
Sadjida è venuta da me durante la ricreazione. Stavo giocando con altre mie compagne a talab-e-khan, una specie di palla-prigioniera in cui i membri di una squadra vengono eliminati quando sono colpiti dal pallone lanciato da uno della squadra avversa. Non mi è piaciuta per niente l’espressione che aveva quando mi ha chiesto di lasciare il gioco. Ha fatto segno anche a Bibi Hawa, un’altra ragazza, di seguirla. Ci ha condotte in po’ in disparte.
«Ho chiesto a Bibi Hawa di ascoltare quello che devo dirti, Diana Jaan, perché è una ragazza responsabile e intelligente. Non come te. Questa settimana sei già stata assente due volte. Troppo. Fa’ in modo che non accada più, altrimenti chiederò che tu venga espulsa. Bibi Hawa è testimone che ti ho avvisato. Ancora un’assenza e ti denuncio.»
Mi sentivo quasi mancare di fronte alla brutalità della minaccia e all’imminenza della sua attuazione. Ho ceduto e ho promesso che non sarei più mancata. Si può dire quel che si vuole, io lo trovo molto ingiusto. Che ne sa Sadjida, al riparo del suo status di rappresentate di classe, della mia vita? Cosa pensa che me ne faccia delle ore che rubo alla scuola?
Questa sera, dopo aver visto il notiziario, non sono per niente contenta. Pensavo che il peggio fosse passato, per noi che abbiamo vissuto l’infanzia recluse sotto il regime talebano. Pensavo che noi, privilegiati della capitale, in cui si prospettano libertà inedite, potessimo infine rallegrarci della nostra condizione di donne. E invece ecco che questa sera alla televisione hanno detto che è stata appena sottoposta al voto del Parlamento una proposta di legge che vieta gli incontri pubblici aperti a uomini e donne, la musica ad alto volume, e le t-shirt ai ragazzi. Le parlamentari donne, simbolo dell’emancipazione delle donne afgane, si sono pronunciate a favore di questa legge. Che disillusione!
Ho il vago presentimento che queste nuove proposte di legge siano un richiamo alla realtà per l’Afghanistan oggi. Noi camminiamo come equilibristi sul filo teso della ricostruzione. Quella legge farà piacere alla frangia più conservatrice del Parlamento. Sono a dir poco furiosa per questa evidente concessione. Voglio credere con tutte le mie forze che la mia inquietudine sia irrazionale. Questa legge è del tutto inapplicabile perché è illegale. È opera di una mente contorta che non avrà neppure pensato che le forze di polizia, già così poco numerose, hanno altro da fare che sorvegliare se i ragazzi indossano una t-shirt. Se adesso siamo arrivati al punto che l’anatomia maschile crea imbarazzo e i nostri politici non trovano niente di meglio che legiferare su quello, il futuro non può che apparire allarmante. Dobbiamo sempre destreggiarci tra il desiderio di aprirci a una cultura più occidentale e un islam intriso di rigore. Questo richiede una saggezza che non abbiamo ancora.
Ogni tanto mi prende la voglia di mollare tutto. Non ho intenzione di fare la lista dei drammi grandi e piccoli che hanno infestato i miei tredici anni. Cerco di rimanere il più fedele possibile ai fatti.
Farhad ha finalmente trovato un pulmino “super custom” da comprare. Abbiamo messo insieme tutti i nostri risparmi e preso in prestito quasi duemila euro da un prestatore a pegno non lontano dalla piazza Pashtunistan. Ero così fiera quando Farhad è arrivato nel quartiere con il minibus e l’ha parcheggiato nella piazza vicino al cimitero. Siamo usciti tutti per vederlo, anche la mamma. È marrone e ogni volta che inserisce la retromarcia parte una musichetta. Se i calcoli di Farhad sono giusti, il minibus ci farà guadagnare abbastanza da consentirci di smettere di lavorare per strada e da comprare infine una casa. Questo minibus ha il colore della mia libertà! Non ho voluto salirci, ho preferito guardarlo da lontano, come una reliquia sacra che non si vuole profanare. Farhad ci ha raccontato di averlo comprato da un ragazzo sulla trentina che, dopo gli studi negli Stati Uniti, è tornato a Kabul e ha messo in piedi una piccola attività di vendita di auto d’importazione. Al momento di pagare, ha detto a Farhad: «Give me five». Il patto era firmato. Con la sua mano intrecciata a quella del venditore, Farhad ipotecava senza rendersene conto una pagina del nostro futuro.
Ospedale Ali Abad, questa mattina. Questa mattina Bilal si è fatto investire da una macchina. Era con due delle mie sorelle più piccole. Io glielo ripeto sempre di guardare prima di attraversare e di non correre dall’altra parte come un pazzo, però non posso sempre stargli dietro. A volte non è capace di dosare le energie.
Così, Bilal si è trovato sul muso di una Toyota Corolla bianca. Per fortuna cadendo è riuscito a proteggersi con il braccio. L’autista si è fermato ed è sceso dalla macchina, imprecando perché era in ritardo. Ha verificato che Bilal e la carrozzeria dell’auto non avessero niente e poi ha ripreso la sua strada. Intanto i clacson in coda si scatenavano.
Shoukria e Samira hanno avuto la prontezza di portare Bilal nel retrobottega di un droghiere e di farlo sedere. La più grande, Shoukria, è ritornata di corsa a casa ad avvisarmi. Quando c’è un problema vengono sempre a chiamare me. Forse perché sono la più pratica, quella che sa tirarsi fuori da ogni situazione. Quando sono arrivata da lui, era bianco come un lenzuolo e, seduto sulla sedia rossa, lo sembrava ancora di più. Il droghiere, un ragazzo malato di poliomielite, mi ha suggerito di portare Bilal all’ospedale per verificare che non avesse nulla di grave. Non me la sono sentita però di farlo salire su un autobus fino a Ali Abad, l’ospedale più vicino e ho chiamato un taxi. Come al solito, ho dovuto contrattare con il taxista che cercava di racimolare qualche soldo supplementare: il prezzo della benzina, il traffico caotico, ogni pretesto era buono. E come al solito, ho dovuto far finta di non vedere i suoi sguardi accusatori: una ragazza che prende un taxi, anche se accompagnata dal fratellino, non può che essere una di facili costumi. Certi pregiudizi sono molto tenaci.
Il taxista ci ha scaricati davanti all’ospedale per settanta afghani. Un capitale.
Ci ha ricevuti il dottor Mutawakil; il nome ce l’aveva ricamato sul camice mentre al collo lo stetoscopio sottolineava il suo ruolo. Ha esaminato il braccio di Bilal. Ci sarebbe voluta una radiografia, ma noi non potevamo permettercela. Il dottore ha capito la situazione. Ha detto che non crede che il braccio sia rotto, ma per sicurezza gliel’ha fasciato ben stretto e ha consigliato una settimana di riposo. Questa non ci voleva: Farhad voleva portare Bilal e Jamshed con sé per vendere i biglietti del minibus e per raccattare clienti tra i passanti. Dovrà cavarsela da solo.
L’incidente di mio fratello mi ha fatto venire un brutto presentimento. Lo dico facendomi mille scrupoli, ma penso che l’acquisto del minibus sia stato un errore. Prima il braccio di Bilal, che doveva fare da controllore. Poi, quando siamo tornati a casa e ho visto Farhad con il naso nel motore che non voleva più saperne di partire, ho avvertito l’imminenza della catastrofe. Io sono meno emotiva dei miei fratelli e sorelle, mantengo un occhio critico sulle cose, come se le guardassi dall’esterno. Questa lucidità mi rende la vita impossibile, perché tendo a vedere sempre nero, e sono in continua lotta con me stessa e il mio pessimismo. A volte mi chiedo se sono io che, temendola, provoco la catastrofe, o se la catastrofe era inevitabile e io ero la sola a vederla.
Ho i miei princìpi. Non infierisco mai sugli sconfitti, non scaccio i molesti e non accuso senza prove. Per lo meno in teoria. Perché in pratica, oggi, avevo una voglia matta di sfogarmi e scaricare la mia rabbia. Mi trattengo perché si tratta di mio fratello. E quando si tratta di un fratello, in Afghanistan, è fortemente raccomandabile sapersi contenere, meglio ancora tacere del tutto. Però quando vedo che l’assurdità si accompagna alla stoltezza, mi vien voglia di prendere i princìpi e buttarli all’aria.
Farhad non è riuscito a fare di meglio che vendere il minibus perché il motore era capriccioso. Aveva trovato un acquirente disposto a ricomprarlo a prezzo d’acquisto. Mio fratello pensava di aver fatto un buon affare. Solo che l’acquirente si è volatilizzato con il minibus dopo averci versato un terzo della somma. Non riesco a capire come abbia fatto mio fratello, che si considera così intelligente e previdente, a lasciarsi fregare così. Come ha potuto fidarsi? Non ci devo pensare. Mi vengono perfino le lacrime agli occhi. Lacrime di rabbia contro mio fratello. Lacrime da bambina contro una tale ingiustizia.
La famiglia è ripiombata in una situazione di estrema povertà. Siamo tornati tutti per la strada, rassegnati a condurre una vita da straccioni. Avevo tanto sperato che le mie sorelline avessero un destino diverso. Ora però non ci credo più. Presto dovranno prendere il mio posto. Il mio corpo è diventato troppo ingombrante. Le mie mani sono cresciute troppo presto, il seno comincia a spuntare timidamente. Non mi dispiace il mio aspetto, non sono né bella né brutta, e trovo che la mia sia una faccia di carattere. Sì, di carattere è una definizione che mi si adatta bene. Mi piace che mi si noti. Le donne afgane non sognano altro che di passare inosservate, di confondersi con le cose e con la gente, fino a diventare insignificanti. Quando ci riescono, si sentono realizzate.
page_no="161"
Penso che non si possa davvero apparire insignificanti quando si ha avuto la vita che ho avuto io.
Io sono una bambina di strada, sono cresciuta sulla strada come un’erba selvatica e a lei appartengo. Non mi va di rivangare il mio passato per concludere che non ho avuto un’infanzia. Non ho mai avuto la possibilità di essere una bambina. A cinque anni ero già sulla strada sotto la protezione di mia sorella Fatana. Mi rivolgevo già ai passanti in inglese: «Do you need matches?», lo parlavo ancora meglio di oggi. Non ho mai avuto il tempo di essere timida e riservata.
Se oggi mi concedo di ripensare a tutto quello, è perché ho l’impressione che siamo tornati indietro di sei anni. Sono invasa da sentimenti contraddittori. La riconoscenza per aver potuto frequentare la scuola in questi anni. La tristezza per aver lavorato tanto duramente per poi tornare al punto di partenza. L’affetto per i miei fratelli e sorelle, una banda litigiosa e tumultuosa, ma solidale, che ha saputo tirarsi su le maniche e darsi una mano quando tutto andava male. Quell’affetto vince tutto il resto. Perfino la disperazione di non aver più niente da mangiare e dover mendicare un po’ di frutta e verdura ai parenti di Ghul Dara per sopravvivere.
Per le strade del quartiere Taimani, oggi ho avuto l’impressione che la realtà si scontrasse con l’attualità. Un’orda di uomini, tutti vestiti di arancione, svuotavano i rifiuti da cui si levava un fetore pestilenziale. Non c’è una fogna a Kabul, e tanto meno un sistema di raccolta dei rifiuti. Le pattumiere sono le strade, che servono da mensa ai cani randagi e ai montoni. Una volta alla settimana vengono bruciate, in un fu-mo biancastro che pizzica gli occhi e la gola... D’estate, con il calore, le acque di scolo stagnano e attirano i topi. Gli uomini arancioni raccolgono con le pale i residui nerastri dei rifiuti e li gettano su un camion.
L’anacronismo della situazione mi ha colpito. Dentro di me, a questa scena hanno fatto eco le immagini dei prigionieri di Guantanamo, che in tv si vedono sempre con una divisa identica. E mi è venuta un’idea stramba che mi ha fatto sorridere: ho immaginato quei prigionieri in fuga nella discarica a cielo aperto di Kabul. Solo a me possono venire pensieri del genere.
page_no="163"
1L’Aid (in arabo) o Eid (in hurdu e in persiano) è la festività che segna l’interruzione del digiuno e la fine del ramadan.
![]()
34
Il nerbo della guerra
Mi annoio. Così ne approfitto per uccidere le mosche con la paletta. È l’animale più imbecille che esista, la mosca. Non sa far altro che dare fastidio ronzandovi nelle orecchie per poi andarsi a posare nei punti più sensibili del corpo. Ho fatto una carneficina. Le ho uccise coscienziosamente, con un colpo secco per non farle soffrire. Questo gesto, che ho ripetuto meccanicamente per tutta la sera, concentrando tutta la mia attenzione sul braccio sinistro, mi ha evitato di riflettere.
Sono talmente in ansia per ciò che ci succederà che ho deciso di essere economa. Di parole, azioni e movimenti. Per ogni gesto, calcolo costi e benefici. Se il beneficio è nullo, mi astengo, salvo pressioni dall’esterno. Anche per respirare, cerco di evitare i grandi sospiri inutili. È una cosa idiota, ma farlo mi procura un tale stato di trance che diventa difficile smettere. Tutto il mio corpo è proteso nell’attesa. Ma attesa di cosa, alla fine?
Il mese scorso abbiamo lavorato duro. Farhad è riuscito a ottenere da Doktor Nessar, il proprietario della casa, una piccola proroga dell’aumento dell’affitto. Questo non ci salva dalla catastrofe, cioè lo sfratto, ma ci lascia almeno il tempo di prepararci. I miei timori si sono rivelati fondati. La mamma sta prendendo seriamente in considerazione di mandare le ultime due sorelle, Shoukria e Samira, per strada per arrotondare le entrate. Mi sono opposta furiosamente. È la prima volta che alzo così la voce. Tutti sono rimasti sorpresi dalla mia reazione. «Non se ne parla nemmeno! Finché riusciamo a sopravvivere con quello che guadagniamo noi non voglio che le bambine stiano per strada.» Tutti i frammenti in cui è scomposta la mia vita si sono risvegliati. La scuola da una parte, la strada dall’altra, il mercato, la fatica. Frammenti che difficilmente, e dolorosamente, si incastrano. «Non voglio che le mie sorelle abbiano un’infanzia come la mia.» Non posso abituarmi a questa idea. Mi ossessiona.
Non so bene come prendere la notizia. Come dicono gli americani, è sweet and sour, dolceamara. Farzana, la mia sorella maggiore, quella che è stata venduta a tredici anni, verrà ad abitare a Kabul. È una bella notizia, e tragica allo stesso tempo, come se qualcosa impedisse di provare una gioia piena e totalmente pura. La situazione a Gardez, dove ha abitato finora, è peggiorata. I talebani ormai controllano le vie di accesso e governano con la paura. Mia sorella si è spaventata. Suo marito è stato uno di loro, un talebano. Non credo abbia commesso delle atrocità. Il suo compito si limitava a qualche giro di ronda e a richiamare quelli che non rispettavano la sharia. Per dare un’idea di quanto si è pentito, oggi lavora per una ditta di sminamento. Insomma, toglie le mine antiuomo che i suoi hanno piazzato. Ironia della sorte.
Farzana oggi ha ventitré anni e ha già quattro figli. Il più grande ha quasi l’età di Bilal, suo zio. Mi ingarbuglio sempre su queste cose. I matrimoni precoci complicano molto i rapporti di parentela. Ci sono sempre salti di generazione che sconvolgono le gerarchie.
Farzana ha avuto paura per i suoi figli e per suo marito. Pare che nei villaggi del Sud non ci sia bisogno di perdersi sulle montagne per imbattersi nei combattenti talebani. Ormai sono come pesci nell’acqua. Hanno l’aiuto degli abitanti, che in questa fascia di territorio pashtun li considerano “figli del paese” e li sostengono in base al pashtunwali, un vecchio codice d’onore1. Mia sorella ci ha detto che intorno a Gardez ha visto guerriglieri in moto armati di kalashnikov e con lanciarazzi sulla schiena. A seconda dei distretti, i territori sono più o meno sotto il controllo dei talebani, che si mettono in mostra sotto il naso delle forze governative.
Al Sud, fanno una propaganda capillare: mandano lettere di minaccia agli insegnanti e alle donne che lavorano nelle ONG. I mullah sono gentilmente invitati ad adeguare le preghiere del venerdì alle loro idee. Nei bazar, i DVD con le loro prodezze sono in vendita libera. Il più celebre mostra le nuove reclute prendere il “biglietto per il paradiso” prima di andare a farsi esplodere contro le forze alleate, i militari dell’Armata nazionale afgana o le forze governative. Tutto ciò che rappresenta, da vicino o da lontano, una forma di ingerenza.
Distribuiscono volantini che inneggiano alla jihad e che riportano il Codex, il loro codice di condotta. L’articolo 25 mi fa venire i brividi: «Chiunque lavori come insegnante per l’attuale regime fantoccio deve ricevere un avvertimento. Se, nonostante questo, rifiuta di lasciare il suo lavoro, deve essere picchiato; se l’insegnante persevera nell’insegnare princìpi contrari all’islam, il comandante del distretto o il capo di un gruppo locale devono ucciderlo».
Insomma, i talebani avvertono sempre tre volte. Come papà. Solo che il terzo colpo di intimidazione è per l’eternità.
Farzana non è fuggita per il ritorno dei talebani. È il clima di insicurezza generale che l’ha spinta a tornare a Kabul. Lei dice che gli afgani al Sud hanno una vita difficile, stretti tra i bombardamenti della coalizione e la pressione sempre più forte dei talebani nei villaggi che chiedono di essere aiutati, nascosti, finanziati.
«Ti costringono a bere la zuppa con il coltello» dice Farzana. È un modo delicato di dirlo. Per essere chiari, i talebani fanno opera di costrizione. Gli abitanti dei villaggi non hanno più la libertà di opinione. Sono le vittime collaterali delle battute aeree della coalizione. Si renderanno conto di venire usati come scudi umani da coloro che proteggono? In tempo di guerra, la strategia è l’arma dei poveri. Può avere tutti i vizi, giustifica il regime di terrore e la violenza. In tempo di guerra non si fa caso all’aspetto umano. E tuttavia è quello il nerbo della guerra.
Gli afgani al Sud non hanno scelta. Quando una bomba decima la vostra famiglia o quella del vicino, voi vi schierate per forza contro gli stranieri che vengono a colonizzare militarmente il vostro paese. E quando i talebani vi promettono un ordine giusto, voi c...