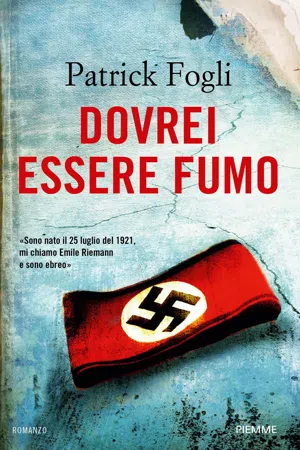![]()
Vivo con la consapevolezza del baratro.
La frase è spuntata fra i pensieri all’improvviso, un’epifania che non sa collocare nel tempo e il cui solo motivo plausibile è il tentativo di mantenere un contatto con la realtà.
Da quando è tornato, quasi un miracolo.
Alza il volume, la musica occupa la scatola cranica, pare in grado di tracimare oltre, le tempie e la corsa seguono il ritmo del suono. Alza ancora, i piedi aumentano la cadenza, l’udito reclama una tregua, fa scendere le note al confine del dolore e il passo di conseguenza. Scherza col proprio corpo, restituisce il fastidio che riceve da mesi. Un’altra guerra persa che si ostina a combattere.
Controlla sullo smartphone il ritmo del percorso, ritrova l’andatura, la mente impone ai gesti obbedienza e disciplina. In spiaggia, il cielo prosegue nel mare, una lastra di ardesia increspata di schiuma, la spiaggia è grigia, verde, densa, costellata di rifiuti, tronchi, qualche bottiglia di plastica. Vicino alla riva l’odore del mare è pungente, la risacca si mescola alla musica, un ragazzo corre nella direzione opposta, lo vede tutti i giorni, non si salutano, si guardano in silenzio, l’altro indossa sempre un paio di occhiali avvolgenti, di plastica scura, pantaloncini sintetici e attillati, ha le gambe glabre, forse depilate, sembrano viaggiare alla stessa velocità. Oggi però è stanco, avanza più lento, la bocca aperta a cercare aria e non lo nota, la fatica è l’unica compagnia che merita attenzione, così anche lui non lo guarda e non ne ha bisogno, ha imparato da molti anni a notare particolari minimi con la vista periferica.
Alla fine della spiaggia sale i gradini che conducono al molo, continua a correre verso l’orizzonte, in fondo al pontile il mare è dappertutto, le vertigini arrivano all’improvviso, sbanda, l’adrenalina lo tiene in piedi, deve rallentare, poco prima della strada si ferma. Resta immobile, le braccia lungo i fianchi, la testa alta, la musica che esplode nelle orecchie, la strada deserta battuta da una pioggia impalpabile, le finestre sigillate di un albergo di lusso, un randagio che attraversa la strada, la musica che finisce di colpo rivela il frastuono del sangue che resiste alla fatica. La vertigine impiega qualche minuto a svanire, ma non ha fretta. È già successo, sa attendere, sa come affrontarla.
Prima di muoversi dedica qualche minuto agli esercizi di allungamento, le articolazioni scricchiolano, muove il collo a occhi chiusi, aspetta che il rachide risponda. Poi ricomincia a correre, una sgambata leggera, per allontanare la fatica.
Il tempo che serve per arrivare all’unico bar aperto.
Dietro al bancone c’è un ragazzo, è sempre lì a ogni ora del giorno, in attesa dell’estate o che passi il tempo. Aspetta l’ordinazione, ma potrebbe farne a meno, è sempre uguale, un succo di arancia in un bicchiere da birra. Beve in silenzio, a un lato del bancone.
«Alberto Corini?»
Si volta appena, l’attenzione distratta che dedicherebbe a un passatempo momentaneo. L’uomo ha un vestito di sartoria, più di quarant’anni e la postura di chi sa proteggere il proprio spazio vitale. È entrato, si è sistemato in fondo al bancone, ha ordinato un caffè e atteso il momento giusto per attaccare discorso. Alberto non risponde, beve un sorso di spremuta, l’altro si avvicina. Il caffè è finito.
«Sono qui per offrirle un lavoro.»
Alberto si appoggia al bancone.
«Chi le ha dato il mio nome?»
«Se lo sapessi, le risponderei volentieri. Agisco per conto di qualcun altro, sono un semplice esecutore.»
«Ho già un lavoro, grazie lo stesso.»
L’altro non si scompone.
«Si tratta di un incarico di sorveglianza, un compito facile per un uomo esperto come lei. L’incarico comporta rischi molto inferiori a quelli che è abituato a correre e avrà una durata limitata nel tempo, purtroppo.»
«Purtroppo?»
«Le interessa?»
Alberto tace. L’uomo che ha di fronte parla senza accento, con calma eccessiva, e saprebbe raccogliere al volo la tazzina senza distogliere lo sguardo dai suoi occhi. I simili si riconoscono, pensa. È una legge di natura.
«Ho già un lavoro» ripete e vuota il bicchiere.
«Lei non lavora da quattro mesi e noi non richiediamo i servizi di chiunque.»
«Non mi piace essere spiato. E non mi ha detto come si chiama.»
L’uomo estrae un bigliettino dalla tasca della giacca.
«Prendere informazioni è normale, lo sa. Il compenso è a cinque cifre, un regolare contratto. I soldi non sono un problema, per questo possiamo permetterci di assumere il migliore. Il colloquio preliminare è fra due giorni, alle sedici.» Appoggia il bigliettino sul bancone. «Quello è l’indirizzo» dice. «Un solo minuto di ritardo sarà considerato risposta negativa.»
Alberto lo accompagna con lo sguardo mentre esce, sale dal lato del passeggero su una Mercedes nera, appena fuori dal locale. Quando la macchina scompare, raccoglie il bigliettino.
È un cartoncino da visita bianco, pronto per essere stampato.
L’indirizzo è scritto a mano.
Lo studio affaccia su un piccolo giardino. Alberto è sul divano in legno, la seduta coperta da un materasso, avvolto in un lenzuolo viola. Accanto a un bracciolo due cuscini in tinta pastello e dallo stesso lato una poltrona bianca, un uomo che lo guarda, appoggiato allo schienale, le dita incrociate. Si conoscono da ragazzi, compagni di scuola alle medie e al liceo. Qualche tempo fa Alberto è riapparso dopo oltre vent’anni.
«Ho bisogno di aiuto» ha detto, come se riprendesse una frase abbandonata un istante prima. L’altro gli ha fatto cenno di entrare, ha chiuso la porta, ha avvisato la moglie di un probabile ritardo e atteso che l’amico cominciasse a parlare. Un’ora dopo l’accordo era chiuso. Incontri regolari, fuori dall’orario visite, niente di ufficiale, solo il vecchio legame fra due uomini che si rivedono dopo tanto tempo.
«Non posso permettermi che si sappia» aveva detto Alberto. «Sono già abbastanza nei guai.»
Tre giorni dopo erano cominciate le chiacchiere.
Alberto arriva in perfetto orario, transita per la sala d’aspetto deserta e se ne va prima che arrivi il paziente successivo. Nel mezzo, racconta. La cosa più difficile che abbia fatto in tutta la sua vita. Ogni volta, per farsi coraggio, comincia senza preavviso.
«Da qualche giorno faccio una cosa strana» dice. «Verso la fine dell’allenamento comincio ad alzare la musica e più il volume cresce, più accelero, fino a un istante prima della soglia del dolore. Continuo finché le gambe reggono, poi abbasso, spengo, mi fermo.»
«Quando hai cominciato?»
«Qualche settimana fa. La prima volta non so neppure perché.»
«E come ti senti quando lo fai?»
«Bene e male allo stesso tempo. È come sapere che posso avere il controllo sul mio corpo. Ogni giorno resisto un secondo di più, la soglia del dolore si sposta in avanti, la capacità di sopportare cresce.»
«Per cosa ti stai allenando? Per fare un buon tempo? Più chilometri che puoi? Resistere al dolore? Diventare sordo?»
«Non dovrei sdraiarmi?»
«Soltanto se ne hai voglia. Qualcuno si sente a suo agio. È steso, non mi deve guardare in faccia, aiuta.»
«La voce fuori campo.»
«Una cosa del genere. C’è chi la odia. Non mi hai risposto.»
«Sei il mio psichiatra, dovresti avere le risposte giuste.»
«Non ci sono risposte giuste o sbagliate.»
«Mi alleno a sopportare, senza complemento oggetto.»
«L’emicrania come va?»
«Ha il buon gusto di scoppiare quando sono a casa.»
«Le pillole ti aiutano?»
«Vuoi la verità o una bugia credibile?»
«Sono il tuo medico.»
«Le ho prese, qualche volta. Non fanno niente. Basterebbe dormire.»
«Dovresti...»
Lo interrompe subito.
«Dovrei, lo so. Ma non voglio farmaci, non voglio alcol, non voglio droghe, non voglio dipendenze. Sono in grado di farcela senza qualche pillola del cazzo, chiaro?»
L’altro lo guarda senza espressione, solo una paziente attesa. Alberto prende un lungo respiro, scuote la testa.
«Oggi mi ha telefonato un funzionario della banca. È la terza volta in sei mesi. Dicono che dovrei prendere in considerazione un investimento, parlano di percentuali senza smettere mai. Dopo un po’ riattacco. Alla fine dell’allenamento vado sempre nello stesso bar. Dietro al bancone c’è un ragazzo molto giovane, forse è il figlio del proprietario, ma non ho mai visto nessun altro. Mi serve l’ordinazione e non dice nulla, solo la domanda necessaria a scoprire cosa voglio. Le prime volte si aspettava che facessi conversazione, restava lì, a un metro da me, fingeva di sistemare tazzine e bicchieri, era quasi sollevato quando capiva che non avevo intenzione di dire niente, solo bere, pensare, riposarmi un attimo, lasciare che il tempo passasse. Ora non aspetta nemmeno, al mare non c’è molta gente, mi riempie il bicchiere e si mette in un angolo, sullo sgabello dietro la cassa, a leggere un libro. Vorrei che il mondo facesse come lui e capisse quando è il momento di lasciarmi stare.»
«Forse lo sta facendo, solo che parla con il suo linguaggio. O forse non vuole o non può. A ognuno le sue imperfezioni. Quello che ti è accaduto non è normale, Alberto, la vita che hai fatto per anni non lo era e neppure il modo in cui hai tentato di affrontare il dopo. Dentro questa stanza non c’è un giudice o un tribunale e nemmeno un nemico. Se preferisci smettiamo di vederci qui e andiamo a bere una birra insieme. Due volte alla settimana, per quanto mi riguarda sarebbe un diversivo.»
«C’è una cosa a cui penso, da qualche giorno.»
«Racconta.»
Alberto tace, di colpo non è sicuro di voler continuare. Poi, con un analogo gesto d’istinto, ricomincia.
«È come parlare la lingua sbagliata,» dice «un dialetto sconosciuto. In Pakistan ce ne sono centinaia, alcuni simili, alcuni del tutto diversi. E ci sono luoghi in cui ricordare quello sbagliato rischia di essere mortale. Qui è la stessa cosa. Appena tornato non ci facevo caso, era stata una mia scelta, nessuno mi ha costretto, hanno cercato per mesi di farmi cambiare idea. Non dovevo più preoccuparmi di restare vivo, non rischiavo di fare la cosa sbagliata e finire con la testa staccata dal collo. Ma ero ancora quello con il dialetto sbagliato. C’erano strade e autobus e negozi dove comprare il pane, ristoranti, bambini, famiglie, donne che mi guardavano e che avrei potuto avere e mi sembrava tutto straordinario, fantastico, pieno di colori. Per settimane ho vissuto alterato, in uno stato di euforia che non sapevo gestire, perché ogni scelta che potevo fare implicava rinunciare, seppure brevemente, a qualcosa che desideravo altrettanto. Non possedevo un’auto da dieci anni e ho vagato per concessionari, senza riuscire a decidermi, ne ho comprata una a caso. Ho comprato i vestiti che avevo sempre sognato, una casa. E poi l’euforia è finita e sono caduto e oggi mi sento di nuovo come la prima volta in cui mi sono rialzato, con la certezza assoluta che qui, con i cuscini imbottiti, il cibo, il vino, un letto comodo, tutto sia molto più pericoloso di come dovrebbe essere, più pericoloso di quando rischiavo la vita.»
«Forse è cambiato il nemico.»
Alberto lo guarda.
«Stai dicendo che sono io, il nemico? Potrei risponderti che con quello che ho fatto le unità di misura cambiano. L’unica cosa che dura per sempre non è l’amore, ma il senso di colpa.» Appoggia i gomiti alle ginocchia. «A volte penso che mi manchi uno scopo, un nemico da combattere, una missione, qualcuno da salvare, una redenzione. Tragica, solitaria, conclusiva, banale. Una maledetta vita da supereroe.»
«Quella da cui ti sei ritirato.»
«No, non c’era niente di eroico» risponde. «Niente.»
Alberto lo fissa a lungo, le palpebre non sbattono mai.
«È difficile essere invisibili e scoprire di colpo che non lo sei. Fare di tutto per passare inosservato, imparare a nascondere il tuo nome, credere che siano vere identità fittizie, crederci veramente e poi, dalla mattina alla sera, ritrovarti con te stesso. Per un po’ non ricordi nemmeno la tua vita. Hai costruito nuovi ricordi, lo hai fatto sul serio, così bene che il cervello li ha impiantati nella realtà. È un trucco bastardo, ma funziona. La regola è chiara, cambia poco rispetto alla verità, m...