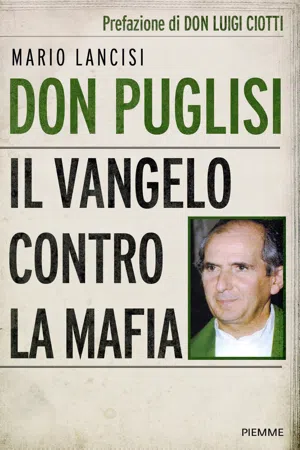![]()
Per comprendere il contesto in cui fu ucciso don Puglisi, si affronta in questa parte del libro, seppure per rapidi cenni, il rapporto tra Chiesa e mafia. A partire dall’espressione chiave e ambivalente di «In nome di Dio», usata – come un grido di battaglia o una benedizione – dai mafiosi devoti prima di compiere i loro omicidi, gesta efferate e criminali, ma anche implorazione con cui, nel famoso discorso di Agrigento del 9 maggio 1993, papa Wojtyla invita gli uomini di Cosa Nostra a convertirsi.
Gian Carlo Caselli, ex procuratore della Repubblica di Palermo dal 1993 al 1999, racconta la congiuntura storica in cui si collocò l’omicidio di don Puglisi, dopo la riscossa dello Stato in seguito all’uccisione di Falcone e Borsellino e le stragi dell’estate del 1993.
Estate calda, quella del 1993, anche a Brancaccio. I Graviano terrorizzano l’Italia con le bombe a Roma, Firenze e Milano, mentre a Palermo scatta l’intimidazione nei confronti di don Puglisi: attentati alle porte dei responsabili del Comitato Intercondominiale, telefonate minacciose, schiaffi.
Il parrinu è avvisato. Intorno a lui si stringe il cerchio criminale della mafia. Fino alla sua uccisione, il 15 settembre.
L’ultimo giorno di vita di don Puglisi è la via crucis di un prete e di un uomo che non arretra di un passo dinanzi alla croce.
Fino all’ultimo fa il suo dovere di pastore di anime e di punto di riferimento anche sociale di un quartiere che vuole sottrarsi alla tirannide sanguinaria della mafia. Ma una pallottola nella nuca mette fine, alle 20.40 del 15 settembre, alla vita di un santo e alle speranze di un quartiere degradato.
Muore don Puglisi con il sorriso sulle labbra, almeno così ha raccontato il suo killer Salvatore Grigoli.
Il “macellaio” della mafia: quarantasei omicidi.
Grigoli si pente e si converte.
Miracolo di don Puglisi, per molti. Opportunismo, per altri.
Il funerale del parroco di Brancaccio chiama a raccolta la Palermo che non ci sta all’oppressione della mafia, ma tra le migliaia di persone, nella stessa omelia del cardinale Pappalardo, sembra di ravvisare i segni di un’altra città, di un’altra Sicilia. Che ha paura, che vuole stare lontano dalla lotta antimafia. Che è contro Cosa Nostra. A parole.
Don Puglisi lo è stato con la vita.
![]()
Scena numero uno. Il mafioso è pronto per andare ad ammazzare. Pistola, indicazioni sulla vittima, auto. Prima di partire per la missione di morte, a suggello dell’armamentario predisposto, il mafioso si fa il segno della croce ed esclama: «In nome di Dio».
Grigoli racconta: «Il novanta per cento dei mafiosi dice di credere in Dio. Uno dei miei coimputati diceva sempre: “In nome di Dio”, prima che ci muovessimo per andare ad ammazzare qualcuno. A me questa cosa mi dava fastidio: “Ma che aiuto ti può dare Dio?” gli dicevo io. Ho sentito dire che Giuseppe Graviano qualche volta andava a messa. È gente che legge la Bibbia. La Bibbia la leggevo anch’io, da latitante. Mi piaceva leggerla»1.
Grigoli visionario? Millantatore? No, ecco altri piccoli e grandi episodi della “religiosità” dei boss mafiosi.
Quando le forze dell’ordine arrestano Totò Riina nel portafoglio gli trovano un santino. E, messo a confronto con il pentito Buscetta, si rifiuta di parlare con un’argomentazione tipica del bigottismo religioso: aveva avuto molte mogli.
Nitto Santapaola, autore di innumerevoli delitti – compreso quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie e del poliziotto di scorta – era un assiduo frequentatore dell’oratorio. Nel suo cascinale trasformato in bunker si preoccupò di costruire una cappella. Per la messa e le preghiere quotidiane. Magari prima o dopo un omicidio, una strage.
Un altro famosissimo boss, Michele Greco, fu ribattezzato il “Papa” anche per le sue continue citazioni della Bibbia.
Per non dire infine dell’iniziazione mafiosa fatta bruciando le immagini sacre di sant’Antonio e della Madonna Assunta. «La mafia si serve della religione, in particolare della sua ritualità (funerali in pompa magna, processioni, devozioni popolari) per dare ai suoi uomini d’onore un volto buono. Al contrario essa è stata ed è solo una organizzazione criminale, tutto l’opposto della religiosità, anche la più semplice», osserva Giovanni Marchesi su «Civiltà Cattolica»2.
La canzone di don Calò
Scena numero due.
«Don Calò, con te non ci sto:
macina al collo, sprofonda nel mare;
la mia terra amurusa
non ha più nome, né danza, né musa»3.
Sono i versi di una canzone, scritta da don Cosimo Scordato contro il boss mafioso don Calò, che migliaia di giovani, radunati nello stadio di Agrigento, cantano a squarciagola, il 9 maggio del 1993, giorno in cui Giovanni Paolo II, in visita in Sicilia, approda nella città dei templi.
È in questo contesto che si inquadrano l’opera di don Puglisi e la sua morte.
Il contesto del rapporto tra Chiesa e mafia.
Due le facce. I mafiosi che, novelli crociati, invocano Dio a protezione, giustificazione e identità della loro attività criminosa, e i giovani cristiani che inveiscono contro don Calò e i suoi picciotti.
E, in mezzo, la Chiesa. Ondivaga. Tra connivenza e condanna. «Per Cosa Nostra la Chiesa era quella che, se c’era un latitante, lo nascondeva. Non perché era collusa, ma perché aiutava chi aveva bisogno. Un territorio neutro. Cosa che è venuta a mancare negli ultimi anni», racconta Grigoli4.
Con l’invettiva pronunciata da papa Wojtyla nella Valle dei Templi, la Chiesa sceglie.
Non più neutra, ma schierata.
Schierata contro la mafia (non in maniera univoca, né per sempre, come vedremo più avanti).
E i mafiosi lo avvertono.
«Si vociferava che la Chiesa cominciava a essere diversa», risponde Grigoli ad Anfossi che gli chiede l’effetto su Cosa Nostra delle parole del papa ad Agrigento.
«E la Chiesa di Puglisi?», insiste il giornalista.
«La Chiesa di Puglisi era una Chiesa diversa», risponde il pluriomicida5.
Quando anche i preti erano capimafia
Sulle collusioni tra Chiesa e mafia sono stati scritti libri e saggi. Quintali di carta. Persino nel sito della diocesi di Palermo si possono leggere frasi chiare anche se prudenti, come queste: «La mafia e il Vangelo sono incompatibili. Oggi può sembrare un’affermazione ovvia, ma così non era negli anni Cinquanta e Sessanta. In Sicilia non tutti i sacerdoti, non tutti i vescovi avvertirono per tempo come il male si stesse annidando nei gangli vitali della società. Molti storici, anche di parte ecclesiale, parlano di una “sottovalutazione”, se non di una “coabitazione”, andata avanti per decenni, con i boss impegnati in una funzione di pacificazione sociale delle campagne e di controllo del voto in chiave anti-comunista che non dispiacque a molti esponenti della comunità cattolica».
Qualche flash.
Nel 1838 il procuratore del re a Trapani, Pietro Ulloa, riferiva che fra i capimafia della zona molti erano gli arcipreti.
C’è poi la vicenda negli anni Cinquanta dei frati di Mazzarino condannati per estorsione.
Il cardinale Ruffini, ad esempio, preferiva non parlare di mafia. Dopo la strage di Ciaculli, avvenuta il 30 giugno 1963, nella quale morirono sette vittime innocenti, Paolo VI, attraverso Angelo Dell’Acqua segretario di Stato, il 5 agosto, gli inviava una lettera in cui, prendendo spunto da un manifesto affisso a Palermo dalla comunità valdese, gli chiedeva di promuovere iniziative «per dissociare la mentalità della cosiddetta “mafia” da quella religiosa». Ruffini rispondeva in maniera risentita. Definiva il manifesto dei valdesi «un ridicolo tentativo di speculazione protestante». E accusava la propaganda social-comunista «di supporre che la mentalità della cosiddetta mafia sia associata a quella religiosa». Insomma: l’accusa di contiguità tra Chiesa e mafia è propaganda del Pci.
Ma più che la connivenza è il silenzio che viene rimproverato alla Chiesa: il peccato di omissione, gli occhi che non si fermano a guardare le vittime e i loro aguzzini mafiosi.
Gian Carlo Caselli che, dopo l’uccisione di Falcone, divenne capo della procura di Palermo, coniò – a proposito della mafia – la fortunata definizione di “atea sacralità” e accusò la Chiesa di connivenza o quanto meno di benevola tolleranza della mafia.
L’invettiva del cardinale Pappalardo
Il discorso del papa ad Agrigento nel maggio 1993 cambia il quadro. Lo rovescia. Opera una cesura.
Era la terza volta che Giovanni Paolo II si recava in Sicilia. C’era già stato nel 1982 e nel 1988.
La visita del 20 e 21 novembre 1982 suscitò molte polemiche perché il papa non pronunciò mai la parola “mafia”. Si parlò allora di occasione perduta, in un clima teso per l’uccisione del generale Dalla Chiesa, il 3 settembre del 1982, e l’invettiva del cardinale Salvatore Pappalardo ai suoi funerali: «Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici».
Lo Stato è assente e Palermo è assediata dalla mafia, denunciava il cardinale, ma il papa – eletto da soli quattro anni al soglio pontificio – non dava forza universale all’invettiva del cardinale palermitano.
Forse anche per questi precedenti, la visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento nel 1993 fu accompagnata da un carico di polemiche e di attese.
Maria Falcone, la sorella di Giovanni, espresse l’auspicio di una Chiesa più legata a fra Cristoforo e meno a don Abbondio.
Un gruppo di intellettuali cattolici accusarono gli ecclesiastici di troppa tiepidezza contro la mafia, se non di vera e propria collusione, e denunciarono «lo scandaloso intreccio tra rappresentanti della Chiesa cattolica ed esponenti del potere mafioso attraverso l’inquietante mediazione di politici, imprenditori, professionisti, banchieri, sindacalisti, giornalisti e altri membri del ceto dirigente siciliano».
Infine Agnese Borsellino, vedova del giudice ucciso un anno prima dalla mafia, intravide nella visita papale (lettera all’«Osservatore Romano», pubblicata il 5 maggio 1993) la “speranza” di un gesto, di un’indicazione «di nuovi impegni perché questa nostra Chiesa che è in Sicilia sia più e meglio segno di speranza, specchio di giustizia, amore per chi soffre». La Borsellino concludeva con un appello perché la Chiesa fosse fedele agli ideali del Vangelo e i cristiani disposti a essere «testimoni scomodi, disponibili anche a rischiare, per non compromettere con qualunque tipo di collusione la genuinità dell’insegnamento di Cristo»6.
Il fatto che «L’Osservatore Romano» decise di pubblicare un saluto al papa da parte della vedova di Borsellino era indicativo di un mutamento di clima nel rapporto tra Chiesa e mafia.
«In nome di Dio, convertitevi...»
E siamo al giorno della grande svolta.
Valle dei Templi, domenica 9 maggio 1993. Il sole cala sulle colonne greche della Concordia, dei Dioscuri, di Zeus Olimpico e di Giunone quando a Giovanni Paolo II – terminata la concelebrazione de...