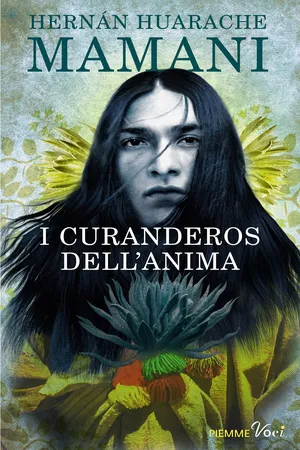Nel 2008, quando tornai in Perú, decisi di trascorrere alcune settimane di vacanza a Lima. Fino a quel momento tutto sembrava andare bene, non mi preoccupavo affatto degli effetti che la ruota della fortuna poteva avere sulla mia vita. Ero felice anche soltanto di andare al mare tutti i giorni con gli amici che, dopo tanto tempo, avevano voglia di stare un po’ in mia compagnia.
Per non disturbare i miei parenti, avevo deciso di affittare una casa vicino alla spiaggia e in quell’angolo di mondo, riservato a una minoranza privilegiata, vivevo come in un’isola incantata, un paradiso artificiale dotato di comfort e sicurezza. Mi sentivo protetto, perfettamente isolato dal mondo circostante.
In quei giorni non avevo nessuna preoccupazione e non immaginavo che di lì a poco la mia vita avrebbe preso una nuova direzione. Non sapevo nemmeno se quello che stavo facendo fosse utile per il mio futuro o se invece non stessi buttando via la mia vita. Quando siamo giovani, forti e sani, crediamo di poter conquistare il mondo perché non conosciamo ancora la realtà. L’inesperienza e l’entusiasmo spesso ci trasportano in un vortice di illusioni e fantasie, finché non arriva il momento in cui dobbiamo scontrarci con ostacoli insormontabili. Questi, inevitabilmente, finiranno per mettere a dura prova le nostre certezze.
E uno di quei momenti capitò anche a me, proprio quando meno me l’aspettavo.
Mi trovavo sulla spiaggia del Leon Dormido e mi divertivo a giocare con gli amici sfidando le potenti onde dell’oceano che si alzavano fino a due metri. Non avevo paura, perché confidavo nella mia esperienza di nuotatore in mare aperto e cercavo di fare sempre attenzione. Mi spostavo lateralmente, con l’acqua che mi arrivava alla vita, e mi stavo preparando a un nuovo scontro con un’altra onda, quando sentii lo strillo dei gabbiani e alzai gli occhi verso il cielo turchese per guardarli. Rimasi sorpreso vedendo la grande quantità di uccelli che si spostavano da un lato all’altro del cielo in una massa compatta, disegnando strane figure: centinaia di gabbiani volavano formando onde gigantesche e si muovevano come se volessero avvertire la gente sulla spiaggia che stava per succedere qualcosa. Ero talmente concentrato nell’osservare il loro volo che non sentii le grida degli amici che cercavano di chiamarmi, mentre si allontanavano correndo. Ero così preso da ciò che accadeva sulla mia testa, che non mi resi neppure conto che il mare si era ritirato al punto che l’acqua, ormai, mi bagnava soltanto i piedi. Quando riabbassai lo sguardo verso l’oceano, mi accorsi che l’acqua stava tornando verso riva trasformata in un’onda gigantesca, alta quattro o cinque metri, che si trovava già quasi sopra di me.
Nonostante non provassi paura, sapevo perfettamente che se quella enorme massa mi fosse piombata addosso l’impatto sarebbe stato così forte da farmi perdere conoscenza. In pochi attimi, seguendo solo l’istinto, mi lanciai con tutta la mia energia contro l’onda, tagliandola con le mani unite. Poi nuotai con forza verso l’interno del mare più che potei, finché risalii in superficie dietro l’onda stessa. Continuai ad allontanarmi, cercando di rimanere a galla fino a quando non fosse tornata la calma. Osservando il movimento sulla superficie, però, mi resi conto che il mare era ancora molto agitato e questo poteva essere un pericolo. Dovevo riuscire a raggiungere la riva a ogni costo, anche perché da un momento all’altro poteva scatenarsi un forte temporale.
Guardai i flutti che s’ingrossavano sempre più e notai che quelli alla mia sinistra erano un po’ più piccoli. Convinto di riuscire ad affrontarli, cominciai a dare bracciate veloci in quella direzione. Recuperando la calma aspettai il momento propizio, poi mi misi a nuotare sopra un’onda che si muoveva verso la spiaggia e, scivolando su di essa, riuscii ad avvicinarmi al bagnasciuga. A quel punto presi a nuotare velocemente finché toccai il fondo e mi rialzai con fatica, cercando di uscire rapidamente dal mare per evitare che le onde, che continuavano a schiantarsi sulla sabbia, mi trascinassero con loro quando ritornavano con incredibile forza verso l’oceano.
A quel punto i miei amici mi corsero incontro per aiutarmi, anche se ormai non ce n’era più bisogno. Ero sorpreso vedendo tutto quello che era successo: l’acqua era arrivata fino agli ombrelloni e aveva rovesciato sedie e sgabelli; i vestiti e gli asciugamani abbandonati dai bagnanti in fuga erano tutti ammucchiati sulla spiaggia. Mi sembrava di aver appena vissuto un sogno.
Mia cugina Judith mi abbracciò piangendo: «Ci hai fatto spaventare. Pensavamo tutti che le onde ti avrebbero sommerso e che saresti annegato!».
«Ma non hai sentito che ti chiamavo?» chiese Manuel, seccato.
«Il rumore era troppo forte e poi ero distratto dai gabbiani che oscuravano il cielo» cercai di spiegargli.
«Per fortuna stai bene» disse mio nipote Alfredo. «È questo l’importante.» Poi aggiunse, tutto contento: «Andiamo a mangiare, tanto con il mare così mosso non possiamo più nuotare e poi sembra che si stia avvicinando un grosso temporale».
Così ci spostammo tutti verso il mio appartamento, mentre le onde continuavano ad avanzare sempre di più verso terra. Per fortuna la casa era stata costruita in alto, su un promontorio.
A tavola, mentre ci servivamo, tornai a pensare all’incidente che mi era quasi costato la vita: mi ero salvato solo grazie all’automatismo che avevo acquisito allenandomi a nuotare in mare. Intanto la radio informava che altri villeggianti erano stati trascinati via dalla potenza delle onde; i loro corpi risultavano dispersi e probabilmente erano morti. Io avrei potuto fare la stessa fine. In quel preciso momento un forte brivido percorse tutto il mio corpo.
Il giorno seguente, dopo aver passato una notte agitata, mi svegliai con un intenso mal di schiena e una forte raucedine. Ero rimasto senza voce e quando parlavo le persone intorno a me non riuscivano a sentirmi; così decisi di interrompere le vacanze e mi diressi verso Arequipa per curarmi.
Mio padre era morto nel 1989 e quindi non potevo più contare su di lui, che sicuramente sarebbe riuscito a guarirmi come aveva fatto molte volte in passato.
I miei parenti, allarmati, mi portarono in ospedale. Qui l’otorinolaringoiatra riscontrò una bronchite e una grave afonia e mi prescrisse antibiotici e sciroppi per la gola. Le medicine, però, non riuscirono a farmi tornare la voce. Provai allora con vari rimedi popolari, ma nemmeno questi funzionarono.
Casualmente, un giorno venne a trovarmi mia nipote Isabella, che aveva imparato i metodi curativi di mio padre; vedendomi malato preparò subito una tisana a base di erbe. Mi fece bere l’infuso e poi mi massaggiò la schiena con un olio speciale in cui aveva fatto macerare altre erbe. Infine mi mise sulla schiena uno speciale panno di lana nera che aveva fatto riscaldare al sole e, con voce perentoria, mi ordinò: «Zio, dovrai rimanere a letto per tre giorni senza toccare acqua né prendere freddo. Ti consiglio di mangiare zuppa di verdure o di cipolla bollita con miele».
«Grazie nipotina. Spero di guarire, e soprattutto di recuperare la voce.»
«Se fai quello che ti ho detto, ti ristabilirai. Ci vediamo presto» mi salutò andandosene.
Le notti seguenti furono terribili: respiravo con difficoltà, sognavo sempre la spiaggia del Leon Dormido, mi agitavo, a volte gridavo addirittura di dolore. Poi cominciai a stare meglio e a dormire più tranquillo. Sognai di trovarmi con Anta Willki in una stanza piena di simboli: alcuni mi erano noti, mentre altri non li avevo mai visti, ma lui me li indicava con insistenza. Il fatto di non capire quello che mi mostrava il maestro mi metteva in gran confusione e mi vergognavo della mia ignoranza.
Quella mattina, quando mi svegliai, cominciai a riflettere sul significato del sogno: che cosa cercava di dirmi il saggio? E perché era ricomparso dopo tanto tempo? In passato lo sognavo spesso, ma negli ultimi anni quelle visioni si erano interrotte e adesso non avevo una risposta da darmi, né riuscivo a comprendere il suo messaggio.
Mi alzai per prendere un quaderno e fare una lista di tutti i punti su cui avrei dovuto riflettere. Fin da subito mi sentii più leggero: il malessere era scomparso e quando provai a chiamare mio fratello mi resi conto, con grande sorpresa, di aver finalmente recuperato la voce.
Anche mia nipote Isabella venne a salutarmi; vedendomi in piedi disse: «Zio, sei guarito! Resta a letto almeno finché il sole avrà riscaldato un po’ l’aria. Più tardi verrò a metterti nuovamente sulla schiena il panno di lana, così starai ancora meglio».
Avevo ancora sonno e quindi tornai a letto. Quando Isabella arrivò per l’impacco, mi addormentai subito profondamente e sognai di nuovo Anta Willki. Stavolta si trovava nella grotta dell’Ampato in cui ci eravamo conosciuti; era sereno ma deciso, il suo volto era serio, come quello di un padre amoroso che riprende suo figlio per aver dimenticato qualcosa. Io mi sentivo inquieto, come se avessi commesso un errore e, per difendermi, gli chiesi: «Padre, che cosa devo fare adesso?».
Comprendendo che non avevo recepito il suo messaggio, il maestro abbandonò l’atteggiamento severo di un attimo prima e tornò a essere il mistico che avevo conosciuto tanti anni prima. Sorridendo, mi disse: «Comincia a diffondere gli insegnamenti segreti. Ora il momento è propizio e puoi parlare di quello che in passato ti avevo chiesto di non rivelare».
Dopo aver pronunciato queste parole chiuse gli occhi ed entrò in una profonda meditazione. Poi la sua immagine sembrò svanire e sfumare nel nulla.
Quando mi risvegliai trovai sul tavolo un’infusione di erbe ancora calda; la bevvi con gusto e continuai a riflettere su Anta Willki. Più pensavo al secondo sogno e più mi convincevo che avrei dovuto rivelare alcuni dei segreti della spiritualità andina. Effettivamente i tempi mi sembravano maturi e questo poteva essere il momento ideale per cominciare a spargere il seme della conoscenza. Inoltre il saggio era stato categorico.
Mentre arrivavo a queste conclusioni, ripensai alla mia esperienza sull’Ampato. Ormai erano passati trentatré anni da quell’avventura che aveva cambiato la mia vita; in quel periodo avevo rinunciato a fare l’economista ed ero diventato professore universitario di lingua e cultura andina. Poi, nel 1995, avevo lasciato definitivamente l’insegnamento e il mio paese per emigrare all’estero.
In quegli anni le conferenze sulla spiritualità e la medicina dell’antico Perú, i seminari che tenevo e i libri che scrivevo avevano impegnato tutto il mio tempo. Alcune volte mi ero anche chiesto perché non sognassi più questo grande mistico, come facevo invece in passato. Anta Willki era stato il grande maestro che avevo cercato per tanti anni e io tenevo sempre presenti i suoi insegnamenti, gli stessi che mi avevano permesso di scoprire la mia vera strada.
Ricordai anche le cose che mi aveva detto di mantenere segrete finché non avessi ricevuto il suo permesso; mi sentivo sollevato all’idea di poterle finalmente condividere con gli amanti della verità e con quelli che avevano bisogno di una guida. Ero cosciente che molte persone in realtà erano alla ricerca di se stesse e comprendevo le difficoltà nel trovare qualcuno che potesse condurle attraverso la notte oscura dell’ignoranza. Lo stesso era successo a me, che cercavo con ansia un maestro. Non lo conoscevo ancora, ma intuivo che esistesse, nascosto da qualche parte.
Mi tornò alla mente il periodo in cui, dopo essere guarito da una gravissima malattia grazie a mio padre, caddi in una profonda crisi di valori. Fu allora che cominciò la mia ricerca spirituale. In quel momento sentii come se si sgretolassero tutti i pensieri e le idee che avevano guidato la mia vita fino ad allora. Ormai mi ero convertito in un occidentale senza radici, e per questo avevo cercato a lungo, ma senza nessun risultato, quelle conoscenze che mi avrebbero permesso di scoprire il vero senso della mia vita.
In quegli anni mio padre viveva ancora e, vedendo i miei tentativi affannosi, un giorno mi disse: «Noi esseri umani siamo come piante che si mantengono in forza grazie alle radici, ma se queste non sono abbastanza forti la pianta dovrà necessariamente sostenersi appoggiandosi a qualcos’altro».
«Non capisco, puoi spiegarmi meglio?» gli chiesi. In quel tempo ero ancora alla ricerca del mio equilibrio.
«È semplice: tu sei nato da genitori indigeni, hai vissuto la tua infanzia insieme a noi, con le nostre idee e i nostri valori. Poi, quando sei emigrato in città, sei entrato in contatto con una cultura diversa: per questo le tue radici si sono indebolite. Ti sei appoggiato a un albero che non ti sta fornendo il giusto nutrimento.»
Le sue parole mi colpirono così profondamente che in quegli anni divenne la mia guida. Da lui imparai molto, ma avevo appena cominciato a comprendere i suoi insegnamenti quando purtroppo morì. Più che il dolore per la sua scomparsa, mi faceva soffrire l’idea di non aver avuto modo di ascoltarlo più a lungo.
Avevo capito troppo tardi che era un uomo molto saggio e che avrebbe potuto condividere con me tutta la sua grande esperienza. Infatti, nonostante fossi intellettualmente civilizzato e avessi assimilato la cultura occidentale, nel più profondo del mio essere ero andino. I miei primi anni li avevo vissuti in quell’ambiente e, anche se avevo voluto dimenticare le mie radici, il mio albero continuava a reclamare la loro presenza: per questo mi ero ammalato.
A partire da quella prima crisi “culturale”, cominciai a dubitare di tutto ciò che avevo appreso e che si basava soltanto sulle questioni materiali. Nella cultura dei miei antenati, invece, si attribuiva molto valore all’aspetto spirituale, come d’altronde doveva essere anche per gli antichi europei, prima che i loro ideali venissero trasformati dal cristianesimo.
Ora lo scopo della mia vita era ritrovare quel rapporto con il sacro che avevo perso. Per questo andavo alla ricerca di ciò che era ignoto, dell’invisibile, dei va...