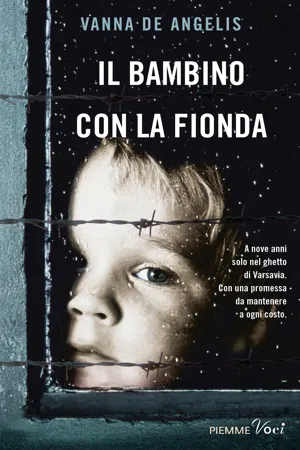![]()
Quello che mi è rimasto sullo stomaco, tra le tante cose, è quando hanno detto in giro che Marek ha ammaestrato un topo. Uno di quei topolini bianchi con il naso rosa. Hanno detto che si mette ritto sulle zampe di dietro appena lui schiocca le dita. Hanno detto che si butta pancia all’aria per avere del pane. Poi Marek impicca il topolino bianco e ne ammaestra un altro al volo, così tutto ricomincia.
Hanno detto questo.
Frottole. So quello che Marek fa e quello che Marek non fa.
Lo so perché Marek sono io.
Sarei incapace di fare una cosa simile. È stato Stephan a mettere in giro la voce. La storia del topolino ammaestrato l’ha presa da un racconto. Il racconto l’avevo letto anch’io e so che alla fine l’ammaestratore non impicca il topolino. Lo lascia libero. Questa dell’impiccare l’ha inventata lui, Stephan. Stephan ha una faccia da pupazzo. Al posto degli occhi ha due bottoni di vetro. Suo padre è un chirurgo famoso e farebbe bene a cambiarglieli quegli occhi. Però se lo facesse non si capirebbe più che Stephan è una carogna. Così se incontrerò ancora occhi come i suoi, capirò subito con chi ho a che fare. Occhi come bottoni di vetro? Ecco una carogna. Ne avrei incontrati di occhi da carogna.
Mi sembra ancora di vedere Stephan dalla finestra della mia stanza mentre faccio gli esercizi di violino. È lì che parla con il suo gruppetto di seguaci e indica la mia finestra, poi tutti insieme mi salutano e corrono intorno e si buttano nella neve pancia all’aria. Fanno i topi ammaestrati insomma. Poi fanno finta di impiccarsi con le cinture. Da dietro le tende li vedo ridere e correre via perché la mamma ha mandato il giardiniere all’ingresso. Ha in mano il rastrello e lo agita in aria come una spada, una spada che sprigiona scintille, è la spada dell’angelo vendicatore puntata contro Stephan e gli altri. Se la battono. L’angelo guarda su verso la mia finestra e mi dice che ritorneranno, non è che lo dica proprio ad alta voce, non muove quasi le labbra, ma io lo capisco. È una faccenda fantastica questa dell’angelo vendicatore che mi parla senza parlare. Però il padre di Stephan è venuto a dire alla mamma qualcosa come “guai a voi se minacciate ancora mio figlio con un rastrello”. Non ha capito che non era un rastrello ma la fiamma con cui l’angelo vendicatore, travestito da giardiniere, ti riduce il muso in cenere. Al padre di Stephan, comunque, la mamma ha chiuso la porta in faccia. E lui gliel’ha fatta poi pagare. Eccome se gliel’ha fatta pagare!
Non so perché, di tutto quello che mi è successo, racconto per prima cosa la faccenda del topolino. Non è che sia iniziato tutto da lì, naturalmente. Ma in un certo senso sì. È che quando in giro dicono di te una cosa, anche se è falsa, poi sembra vera e tutti ci credono. Quindi voglio mettere subito in chiaro che io con i topolini bianchi non c’entro per niente. Con l’ufficiale delle SS sì, con quello eccome. Ma questa dell’ufficiale è venuta dopo, quando avevo già imparato un sacco di cose, e non solo a tirare con la fionda che mi aveva fatto la mamma.
Ma per tornare alla storia dei topolini bianchi, la faccenda stava ormai circolando. Per esempio era arrivata anche alle pelose orecchie del mio maestro di violino.
«Ci vuole tanta di quella pazienza per ammaestrare un topo…» questo era appunto il mio maestro di violino «… tu non hai pazienza, Marek, e per avere già nove anni manchi talmente di tenacia… se no con quel violino saresti a far concerti in giro per l’Europa, come Mozart, e non qui sotto l’ala nera del nazismo» però ala nera lo disse sottovoce, molto sottovoce. «Tra l’altro per impiccare un topo ci vuole fegato, tu invece hai proprio una faccia da bosnek» che nel suo dialetto vuol dire qualcosa come vigliacco. Si era asciugato la saliva, è uno che sbava quando si agita. Puntò l’archetto sullo spartito: «Riprenderai da qui». Di nuovo mi aveva osservato da sopra gli occhialini: «Non ti fa schifo impiccare un topo? A me verrebbe da vomitare». Aveva preso a grattarsi la schiena infilandosi l’archetto nel colletto della camicia, poi: «Però non sono d’accordo con quelli che dicono che voi siete capaci di tutto».
Gli ho chiesto voi chi, ma lui ha fatto una smorfia come a dire lascia perdere e ha fatto una faccia triste. Ma ha scostato la sedia neanche avessi il tifo. Ce l’avevano in tanti, il tifo, qui a Varsavia. Non io, per fortuna. Dicevano che il tifo è colpa degli ebrei del ghetto. L’ho sentita in libreria, e quando ho chiesto alla mamma se era vero si è così arrabbiata che ho giurato a me stesso di tenere il becco chiuso sulle scemenze che sento in giro.
Comunque, per tornare al maestro di violino e alla sua faccia triste, a un certo punto aveva scostato la sedia come se potessi infettarlo. Ecco che cosa mi ha combinato Stephan con quelle sue panzane sui topolini bianchi.
In fondo, a Stephan e a suo padre dovrei pensare in modo diverso per via di quello che gli è successo. E di cose gliene sono successe a quei due dopo il giorno in cui il padre di Stephan si infilò nel portone di via Laszno, dove la gente entrava a far denunce alla Gestapo. Ci entrò anche lui, bello deciso, e denunciò la mamma. Mio padre certo non poteva denunciarlo. Avesse potuto avrebbe denunciato anche lui. Si odiavano. Avevo sentito mio padre dire alla mamma qualcosa come «quello lì è uno che disprezza tutti». Il fatto di disprezzare gli altri mandava in bestia mio padre, come accadde con il dottor Schlieme. Ma questa non la posso raccontare adesso. Forse non la posso raccontare per niente.
Comunque, dopo le chiacchiere di Stephan, anche il libraio all’angolo della strada che porta alla piazza che adesso si chiama piazza Hitler, è diventato strano. Non potevo sapere che era stata sua moglie a dirgli di buttarmi fuori dal negozio e che lui ce la stesse mettendo tutta per ubbidirle. Eppure gli ero simpatico… ma, come diceva mio padre, l’animo umano è fragile. Anche il libraio evidentemente aveva un animo umano. Mio padre mi fece scrivere dieci volte queste parole sul mio diario: l’animo umano è fragile. Quando gli mostrai la pagina con le dieci scritte mi disse che l’animo umano ce l’ho anch’io e che quindi era mio dovere sorvegliare la mia fragilità. Cioè di non fare come il libraio che, per ubbidire agli altri, andava contro la propria volontà.
Quando è successo tutto il gran disastro, il diario l’ho nascosto sotto le mattonelle nella cucina della casa dei Baumgartner. Loro, i Baumgartner, li avevano già portati via. Avevo nascosto lì il diario e anche l’album con le storie che mi raccontava la mamma e che illustravamo insieme. I disegni di mia mamma erano molto più belli dei miei, perché lei è una pittrice.
Era una pittrice.
In fondo devo proprio al padre di Stephan se le cose sono andate in modo da farmi finire in quella casa cadente e bruciacchiata del ghetto, popolata di fantasmi. E io lì tutto solo a tirar fuori dal nascondiglio il diario e l’album da disegno. Spiegherò dopo perché è stato così importante nasconderli.
Comunque, al tempo della faccenda dei topolini, tutto sommato ero ancora bello tranquillo nella nostra casa, una casa che con il ghetto non c’entrava un bel niente. Ogni lunedì pomeriggio andavo in libreria perché la mamma sapeva che ormai ero capace di scegliermi i libri da solo. Fatto sta che anche quel giorno scelsi un libro, ma: «Non credo che tu riesca a leggere per intero questo libro» mi disse il libraio. Il libro era L’isola del tesoro. «È troppo difficile per te.»
«Gli altri di Stevenson non erano troppo difficili.»
«Cioè?»
«Non ricorda che li ho comperati tutti da lei?»
«Non ricordo un accidenti di te.»
«Ho letto The Silverado Squatters» e questo lo dissi in inglese visto che lo avevo letto in inglese «poi Il trafugatore di salme e La Freccia nera e Il dottor Jekyll e… quell’altro di cui non ricordo il nome…»
«Mister Hyde?» il libraio fece un risolino come se trovasse comico che io non mi ricordassi proprio il nome di quello cattivo. In effetti me lo dimentico sempre quel nome. La verità è che non voglio ricordarlo. È Mister Hyde il Male? O è l’altro il Male? Li confondo. La mamma diceva che se una cosa ti fa paura non la ricordi. Secondo me non è vero. Ci sono un sacco di cose che ricordo benissimo anche se mi hanno fatto una paura terribile.
Come quando ho visto la mamma che se ne va e tiene per mano Nina. In fondo c’è il vagone.
Ma intanto, per tornare alla libreria, ero un po’ stupito della faccia strana del libraio. «Adesso compero questo di Stevenson» dissi e feci finta di non accorgermi che il libraio sembrava seccato «questo dell’isola, un mio amico mi ha giurato che è bellissimo, oggi è il mio compleanno e la mamma ha detto che posso comperarmi un libro, anzi, tutti i libri che voglio.» Misi il danaro sul banco, lui lo buttò in un cassetto e senza guardarmi mi disse che non voleva più vedermi.
«Per la faccenda dei topolini bianchi?» chiesi. Mi veniva da piangere ma per me erano ancora i tempi in cui piuttosto che piangere mi sarei fatto tagliare la testa. Solo dopo ho capito che si può piangere sempre e davanti a chiunque. E anche ridere, perché no. Comunque: «Per quella faccenda lì?» dissi, ma gentilmente.
«Ha importanza?» sussurrò e mi spinse fuori dal negozio. «Ma se non ce la fai a starmi alla larga…» fece ancora quella faccia strana, che non gli avevo mai visto. Ora che ci penso sembrava che stesse per piangere.
Un paio di settimane dopo, quando mi incontrò per strada mi disse che dovevo scordarmi la sua libreria. Non poteva più vendermi i libri. Ecco che cosa mi disse. Anche a lui adesso dovrei pensare in modo diverso visto che ho saputo quello che gli è successo dopo. Poveraccio. Il fatto è che anche lui avrebbe fatto meglio ad andarsene da Varsavia.
E a proposito di andarsene da Varsavia, la mamma un giorno l’avevo trovata seduta per terra in sala. Sul parquet aveva disteso tanti fogli di carta e li aveva appiccicati insieme. E su tutta la lunga striscia aveva scritto in caratteri neri, grandi grandi, che sembrava una cosa da lutto, aveva scritto mi fai il favore di accettare finalmente di andarcene da qui e subito?
«Adesso questa l’attacchiamo in corridoio così appena tuo padre rientra stasera la legge.»
Togliemmo dalle pareti i quadri dei paesaggi per far posto alla striscia.
«Dove vorresti andare?» io tenevo su la striscia, intanto le tendevo i chiodini e lei li conficcava nel muro e sembrava arrabbiatissima. «La guerra è dappertutto. Tutti dicono che è inutile andare via.» In effetti l’idea di lasciare Varsavia mi faceva star male, come avrei fatto senza i miei due amici? Senza Zygmunt e Lavinia? E poi la pista di pattinaggio vicino a casa era sempre lì e non avrei mai potuto lasciarla ed erano lì anche tanti altri posti di Varsavia, non solo d’inverno ma anche d’estate, pieni zeppi di cose interessanti. Per non parlare del museo. «Anche se andiamo a Parigi dai nonni è lo stesso, me lo hai detto proprio tu che ci sono anche lì i tedeschi.»
«Non a Parigi,» mi lanciò uno sguardo di fuoco, quando la mamma ti lanciava uno sguardo così, era meglio tenere il becco chiuso «figurati se ho voglia di andare a Parigi, anche i miei dovrebbero andarsene e subito.»
«Allora dove?»
«New York e di corsa. Ci affidiamo agli scout. Ci fanno passare per le montagne, arriviamo in Ungheria, poi da lì si può andare avanti e avanti. Si va a Tokyo e da Tokyo a New York. Ci sono un sacco di persone che sono scappate in questo modo. E ora se ne stanno belli al calduccio.»
«Vuoi che lasciamo i nostri amici?»
Non poté rispondermi. Un’esplosione ci fece fare un tale balzo che rotolammo per terra. Ancora esplosioni, bombe. I vetri della sala vennero giù, non tutti ma quasi, la mamma mi teneva stretto perché poi di esplosioni ce ne furono altre due e lei urlò «stai qui» mi spinse in un angolo e corse via gridando Nina Nina Nina, il nome di mia sorella. Nina aveva quasi tre anni. Tornò di corsa con Nina in braccio e si accucciò di nuovo sul pavimento nell’angolo e teneva stretto anche me. Vicino a noi c’era anche Lilly, tutta raggomitolata. Era corsa dalla cucina, in una mano stringeva una patata, come se le fosse rimasta appiccicata lì.
Quando non si sentirono più esplosioni andammo in cucina e guardammo dalla finestra. Lì i vetri non si erano rotti, chissà perché. Guardammo fuori e una colonna di fumo nero si alzava da dietro le case, la neve scendeva tutt’attorno bella quieta e non troppo fitta, solo minuscole farfalline. Sembrava una qualsiasi fantastica giornata invernale, ma per strada non c’era nessuno. La colonna di fumo nero, che si vedeva un po’ opaca dietro la neve, mi spaventò. Era come quella colonna di fumo nero che avevo visto nel mio libro di geografia, quella che viene fuori dal vulcano, il Popocatepetl. Un sacco di gente era morta ma non quelli chiusi in prigione, lì le prigioni le fanno sottoterra. O forse non era il Popocatepetl, forse mi sbaglio, forse quella delle prigioni era una faccenda che aveva a che fare con la lava. Ma la colonna di fumo nero dietro quelle case di Varsavia sembrava proprio salire dalle viscere della terra, come dice il mio maestro. O dall’inferno come dice Zygmunt, che è cattolico e ha paura dell’inferno. Mi dice spesso in un orecchio che tutte le SS finiranno all’inferno, me lo sussurra in un orecchio perché suo padre gli ha detto che se lo sentono gli sparano.
Anche Lilly parlava spesso sottovoce e adesso: «Lo so io che cosa è successo,» mormorava come se qualcuno potesse sentirla, ma c’eravamo solo io e la mamma e Nina, che oltretutto stava dormendo con la sua bambola di pezza sul petto «lo so io che cosa è successo, vedrai che hanno trovato quella tipografia clandestina».
«Ma chi?» anche la mamma parlava sottovoce, tutte e due stavano attaccate ai vetri e guardavano quel fumo nero, come se in quel fumo ci fossero chissà che risposte.
«Quel dentista, sai, e non voglio pensare che cosa accadrà adesso a lui e a tutta la famiglia fino all’ultimo dei parenti. E anche ai vicini di casa. I nazisti fanno così. Fanno piazza pulita nel giro di cento metri o più. E chi se ne importa se tu non c’entri.»
«Il dentista? Sei sicura?»
«Tengono in cantina la macchina per stampare» Lilly parlò a voce ancora più bassa, dovevo rizzare le orecchie per sentirla. «Giornali clandestini, sai. Però proprio tu dovresti saperlo.»
«Guarda che secondo me non è lui, ma…» la mamma abbassò ancora di più la voce e non sentivo più niente.
«Sì, forse hai ragione, anche perché l’altro giorno ho saputo da Anika che…» anche Lilly abbassò la voce, parlava ormai anche lei come un fantasma. Non volevano che io sapessi.
Come se non avessi capito già un sacco di cose, io. Li avevo letti anch’io un paio di quei giornalini clandestini, quelli che a Varsavia si stampano di nascosto. C’era scritto che bisogna ribellarsi all’occupazione tedesca e un sacco di notizie sulla guerra negli altri paesi perché i nazisti stavano vincendo ovunque. Ma c’era anche scritto che sarebbero arrivati gli inglesi e i francesi e gli americani e avrebbero fatto piazza pulita dei tedeschi. Per il momento posso assicurare che di inglesi e francesi e americani qui non ne ho visti. Comunque, a proposito di quei giornali clandestini, quando comperavi qualche cosa i negozianti lo avvolgevano in un foglio di giornale qualsiasi se nel negozio c’era un tedesco o delle spie, ma se non c’era nessuno usavano un giornale clandestino. Così a casa ti leggevi calmo calmo il giornale clandestino, e sapevi quello che stava succedendo davvero e come stavano davvero andando le cose, vist...