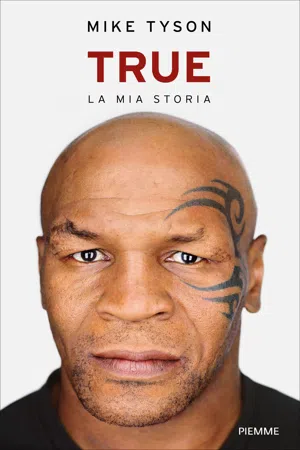Eravamo ai ferri corti con quelli che si facevano chiamare Puma Boys. Era il 1976, abitavo a Brownsville, Brooklyn, e loro erano del quartiere. In quel periodo facevo parte di una gang di Rutland Road, i Cats, una banda di caraibici della vicina Crown Heights. Facevamo furti in appartamento, e alcuni dei nostri avevano avuto una lite con i Puma Boys, quindi stavamo andando al parco per dar loro una lezione. Di norma non andavamo in giro armati, ma quella volta avevano voluto fare i gradassi con degli amici nostri, quindi avevamo rubato un fottuto arsenale: qualche pistola, una .357 Magnum e un fucile M1 a canna lunga con tanto di baionetta, un reperto della Prima guerra mondiale. Si trova di tutto, svuotando gli appartamenti.
Insomma, marciavamo per strada, con le armi in bella vista, e nessuno osava avvicinarsi, nemmeno uno sbirro che provasse a fermarci. Non avevamo una borsa dove nascondere il fucile, così lo portavamo a turno, passandocelo ogni tot isolati.
«Ehi, eccolo là!» gridò Ron, il mio amico di Haiti. «Quello con le Puma e il dolcevita rossi.» Era il ragazzo che stavamo cercando. Ci mettemmo a correre e la folla nel parco si aprì al nostro passaggio come il Mar Rosso davanti a Mosè. Saggia decisione, perché – boom – uno dei miei amici aprì il fuoco. La gente se la diede a gambe. Noi continuammo ad avanzare, e mi accorsi che alcuni dei Puma Boys si erano messi al riparo tra le auto parcheggiate lungo la strada. Imbracciavo il fucile e, girandomi di scatto, vidi un tizio grosso che mi puntava la pistola addosso.
«Che cazzo ci fai tu qui?» mi chiese. Era mio fratello maggiore, Rodney. «Levati dai coglioni, subito.»
Così pensai bene di filare dritto fuori dal parco e tornare a casa. Avevo dieci anni.
Spesso dico di essere stato la pecora nera della famiglia, ma a pensarci bene per gran parte della mia infanzia sono stato un bambino docile. Sono nato al Cumberland Hospital di Fort Greene, un quartiere di Brooklyn, New York, il 30 giugno del 1966. I miei primi ricordi si ambientano in ospedale: soffrivo di problemi polmonari. Per attirare l’attenzione, una volta avevo immerso il pollice in un flacone di idraulico liquido e me l’ero cacciato in bocca. Mi ricoverarono d’urgenza. La mia madrina mi regalò una pistola giocattolo mentre stavo lì, ma io la ruppi subito.
Non so molto della mia famiglia d’origine. Mia madre, Lorna Mae, viveva a New York ma era nata nel Sud, in Virginia. Una volta mio fratello andò a visitare la zona dov’era cresciuta e raccontò che laggiù non c’era nulla, a parte le roulotte. Quindi sono a tutti gli effetti un negro da accampamento. Mia nonna Bertha e la mia prozia lavoravano per questa signora bianca negli anni Trenta, quando la maggior parte dei bianchi non avrebbe mai assunto un nero. Per gratitudine, Bertha e la sorella diedero entrambe il suo nome, Lorna, alle proprie figlie. Grazie a quel lavoro, Bertha riuscì a mandare i figli al college.
È possibile che abbia ereditato il gene del ko da mia nonna. Lorna, la cugina di mia madre, mi raccontò che la signora per cui lavorava Bertha veniva picchiata dal marito, e questa cosa la mandava in bestia. Era una donna robusta.
«Toglile le mani di dosso» disse un bel giorno all’uomo.
Lui credeva che scherzasse, ma Bertha gli sferrò un pugno e lo mandò con le chiappe a terra. L’indomani, quando la rivide, lui la salutò tutto gentile: «Come sta, signorina Price?». Smise di maltrattare la moglie e diventò un agnellino.
Mia madre era benvoluta da tutti. Alla mia nascita, lavorava come guardia carceraria nella prigione femminile di Manhattan, ma studiava per fare l’insegnante. Aveva completato tre anni di college quando incontrò mio padre. Lui però si ammalò e lei dovette interrompere gli studi per accudirlo. Era una donna istruita, ma non sapeva proprio sceglierseli, gli uomini.
Della famiglia di mio padre non so granché. Anzi, lui non lo conosco affatto: sul mio certificato di nascita risulto figlio di Percel Tyson. In realtà non l’ho mai incontrato, e neanche mio fratello e mia sorella.
Scoprimmo in seguito che il nostro padre biologico era tale Jimmy “Curlee” Kirkpatrick Jr., ma vedevamo di rado pure lui. Crescendo, seppi che Curlee era un pappone, e campava sfruttando le donne. Poi, di punto in bianco, cominciò a spacciarsi per un diacono della chiesa. Per questo ogni volta che qualcuno mi si presenta come reverendo, io commento «reverendo-barra-pappone». A pensarci bene, i predicatori hanno il tipico carisma dei protettori: riescono ad attirare le persone nella loro chiesa e a far fare loro ciò che vogliono. Quindi per me non c’è mai stata grande differenza tra vescovi e papponi, tra padre Vattelapesca e un protettore.
Mio padre, Jimmy “Curlee” Kirkpatrick Jr. (Per gentile concessione di Mike e Kiki Tyson)
Mia madre, Lorna Mae. (Per gentile concessione di Mike e Kiki Tyson)
Di tanto in tanto, Curlee arrivava in macchina a casa nostra. Con mia madre non scambiava nemmeno una parola. Accostava al marciapiede, suonava il clacson, e noi scendevamo in strada. Salivamo tutti a bordo della sua Cadillac, convinti che ci avrebbe portati in gita a Coney Island o a Brighton Beach; invece lui faceva qualche giro dell’isolato e tornava davanti al nostro condominio. Arrivati a destinazione, ci allungava un po’ di soldi, dava un bacio a mia sorella, stringeva la mano a me e a mio fratello, e stop. Tutto lì. Magari l’avremmo rivisto l’anno successivo.
Io a nove anni. (© Steve Lott/Boxing Hall of Fame Las Vegas)
La prima casa in cui ho vissuto era a Bed-Stuy, Brooklyn, a quel tempo un dignitoso quartiere operaio. Ci conoscevamo tutti. Avevamo una nostra normalità, solo che era tutt’altro che “normale”. Il venerdì e il sabato, casa nostra si trasformava in una piccola Las Vegas. Mia madre organizzava tavoli da gioco e invitava tutte le sue amiche, molte delle quali facevano la vita. Eddie, il suo fidanzato, veniva spedito a comprare una cassa di liquori, che lui e mia madre rivendevano annacquati. Ogni quattro mani, il giocatore vincente doveva spartire con la casa. Mamma cucinava pollo fritto. Mio fratello ricorda che non c’erano soltanto prostitute, ma anche gangster e poliziotti. Il circo al gran completo.
Quando mia madre aveva soldi in tasca, faceva le cose in grande. Era un’abile intermediaria, e tirava nel giro le sue amiche e un mucchio di uomini. Tutti bevevano in continuazione. Lei li riforniva di marijuana, senza mai toccarla. Fumava solo sigarette, le Kool 100’s. Le sue amiche erano prostitute, o comunque offrivano prestazioni sessuali in cambio di soldi. Non erano né squillo d’alto bordo né battone di strada. Quando avevano appuntamento con un cliente, lasciavano i bambini a casa nostra, poi tornavano a riprenderseli. A volte, al rientro, avevano i vestiti macchiati di sangue e mia madre le aiutava a rimettersi in sesto. Un giorno arrivai a casa e ci trovai un neonato bianco. “E questo da dove cazzo è sbucato?” pensai. La nostra vita era così.
Mio fratello Rodney aveva cinque anni più di me, quindi non avevamo molto in comune. È un tipo strano. Venivamo da una famiglia di neri del ghetto, ma lui aveva più l’aria di uno scienziato, sempre indaffarato con le sue provette, a fare esperimenti. E collezionava monete. A me sembrava roba da bianchi. Una volta prese delle sostanze dal laboratorio di chimica del Pratt Institute, un college non lontano da casa nostra. Qualche giorno dopo, mentre lui era fuori, mi intrufolai in camera sua e cominciai a imitarlo, aggiungendo acqua alle provette, con il risultato di mandare in frantumi i vetri della finestra e di appiccare il fuoco alla stanza. Da quella volta, Rodney chiuse sempre la porta a chiave.
Litigavamo spesso, ma le nostre erano normali zuffe tra fratelli. Tranne la volta in cui lo tagliai con un rasoio. Per qualche motivo mi aveva pestato, poi se n’era andato a letto. Io e mia sorella Denise stavamo guardando una di quelle soap opera ambientate negli ospedali, con la scena di un intervento chirurgico. «Potremmo operare Rodney. Lui fa il paziente, io sono il chirurgo e tu la mia infermiera» proposi a Denise. Così gli rimboccammo una manica, quella del braccio sinistro. «Bisturi» dissi, e mia sorella mi passò il rasoio. Praticai una piccola incisione che cominciò a sanguinare. «Disinfettante.» Mia sorella mi diede l’alcol e io lo versai sulla ferita. Rodney si svegliò di soprassalto, urlando come un matto, e ci inseguì per tutta casa finché non mi nascosi dietro la mamma. Gli è rimasta la cicatrice.
Insieme, però, ci siamo anche divertiti. Ricordo che un giorno stavamo camminando lungo Atlantic Avenue e mio fratello disse: «Andiamo alla fabbrica di ciambelle». Aveva già rubato in quel posto, in passato, e forse voleva dimostrarmi di poterlo fare di nuovo. I cancelli della fabbrica erano aperti. Lui entrò e sgraffignò qualche confezione di ciambelle, ma proprio in quel momento i cancelli si richiusero e lui restò bloccato all’interno. Stavano arrivando le guardie della vigilanza, così Rodney mi consegnò le ciambelle attraverso le inferriate, e io scappai via con il bottino. A casa, io e Denise ci sedemmo sui gradini all’entrata a rimpinzarci, con le facce bianche di zucchero a velo. Nostra madre era in piedi accanto a noi, a parlare con una vicina. «Mio figlio ha passato a pieni voti il test d’ingresso per la Brooklyn Tech» si vantò. «È uno studente modello. Il primo della classe.» In quel preciso istante passò un’auto della polizia, con Rodney sul sedile posteriore. Stavano per scaricarlo a casa, ma lui sentì il commento di mia madre e chiese agli sbirri di tirare dritto. Così finì al riformatorio di Spofford, mentre io e mia sorella ci abbuffavamo allegramente di ciambelle.
Io e Denise stavamo quasi sempre insieme. Aveva due anni più di me e nel quartiere tutti le volevano bene. Se le andavi a genio era la migliore amica possibile. Ma se te la mettevi contro, meglio per te restarle alla larga. Facevamo torte di fango, guardavamo gli incontri di wrestling e i film di karate, e andavamo a fare compere con nostra madre. Ce la spassavamo, insomma. Poi, quando compii sette anni, il nostro mondo fu sconvolto.
C’era la recessione, mia madre perse il lavoro e fummo sfrattati dal nostro bell’appartamento di Bed-Stuy. Ci sbatterono fuori, tutti i nostri mobili buttati in strada. Noi tre bambini fummo costretti a restarci seduti sopra, di guardia, mentre mia madre cercava un altro posto dove stare. Ero ancora là quando si avvicinarono dei ragazzini del quartiere. «Ehi, Mike, perché i tuoi mobili stanno sul marciapiede?» Risposi che traslocavamo. Poi ci videro i vicini e ci portarono da mangiare.
Finimmo a Brownsville. L’ambiente era completamente diverso. La gente sbraitava, era aggressiva. Un posto davvero orribile: durissimo, raccapricciante. Mia madre non era abituata a quei neri bellicosi. Avevamo tutti paura. Per la strada c’era un continuo viavai di auto della polizia a sirene spiegate, ambulanze che arrivavano a caricare qualche ferito. La gente sparava, si accoltellava, spaccava le finestre. Un giorno io e mio fratello fummo derubati davanti alla porta di casa. C’erano spesso sparatorie. Noi restavamo a guardare: pareva di vedere un vecchio film di Edward G. Robinson. Invece era vita reale.
L’intero quartiere sembrava un covo di maniaci, erano tutti piuttosto disinibiti. Dal marciapiede si sentivano dire le peggio cose: «Succhiami il cazzo», «Leccami la fica». Scene impensabili a Bed-Stuy. Un giorno un tizio mi rimorchiò per la strada, mi portò in un edificio abbandonato e cercò di molestarmi. Non si era mai al sicuro per quelle strade e, dopo un po’, nemmeno in casa. A Brownsville mia madre smise di organizzare le sue feste. Si era fatta degli amici, ma non era inserita come a Bed-Stuy. Così cominciò a bere. Non riuscì più a trovare lavoro. Ricordo ancora le code interminabili all’ufficio di collocamento. Aspettavamo per ore e ore e, quando finalmente raggiungevamo lo sportello, ormai erano le cinque, e quelli te lo chiudevano sotto il naso, proprio come nei film.
Fummo sfrattati anche a Brownsville. Più di una volta. Di tanto in tanto ci capitava una sistemazione decente, ospiti per qualche tempo di amici o di un fidanzato di mia madre. Ma in genere la situazione peggiorava a ogni trasloco: dall’essere poveri all’essere “davvero” poveri e poi “fottutamente” poveri. Alla fine andavamo a stare negli edifici destinati alla demolizione, senza riscaldamento, senza acqua corrente, con l’elettricità quando andava bene. D’inverno, per scaldarci, dormivamo tutti e quattro nello stesso letto. Dopo un po’, arrivava qualcuno a buttarci fuori. Mia madre faceva il possibile per assicurarci un tetto sopra la testa, compreso andare con uomini che non le piacevano affatto. Non aveva altra scelta. Si rifiutava di portarci in un rifugio per senzatetto; così, quando ci sloggiavano da un palazzo abbandonato, passavamo al successivo. Era un trauma ogni volta, ma cos’altro poteva fare? La cosa che più odio di me stesso l’ho imparata da mia madre: non fermarsi davanti a niente. Mai.
Uno dei miei primi ricordi riguarda gli assistenti sociali che venivano a casa nostra e si mettevano a cercare gli uomini sotto il letto. D’estate, andavamo alla mensa per i poveri e prendevamo da mangiare gratis. Raccontavo di avere nove fratelli, così mi davano più pacchi. Quando tornavo, mi sentivo come un guerriero vittorioso. Ero orgoglioso di mettere il pane in tavola per la mia famiglia. Roba da matti. Aprivo il frigorifero, trovavo un panino con la mortadella, venti miniconfezioni di succo d’arancia e latte, e invitavo tutti a pranzo. «Vuoi mangiare qualcosa, fratello? Hai fame? Noi abbiamo la dispensa piena.» Mi comportavo come se quel cibo me lo fossi guadagnato con il sudore della fronte: invece avevo chiesto la carità.
Da piccolo ero il cocco di mamma. Dormivo sempre con lei. Mio fratello e mia sorella avevano la loro stanza, mentre io la divisi con mia madre fino ai quindici anni. Una volta, lei si portò a letto un uomo mentre io ero lì accanto. Forse credeva che dormissi. Ne sono rimasto traumatizzato, questo è certo, ma non posso farci niente. È andata così. Quando venne a stare da noi Eddie Gillison, il suo fidanzato, fui spedito sul divano. Il loro era un rapporto malato. Immagino sia per questo che anch’io ho avuto tanti guai con le donne. Bevevano, litigavano, scopavano, si lasciavano; poi bevevano di nuovo, litigavano e tornavano a scopare.
Eddie era un tizio basso e tarchiato del South Carolina, operaio in una fabbrica di lavatrici industriali. Non era molto istruito, e anche i compiti delle elementari di mio fratello e di mia sorella erano troppo complicati per lui. Aveva un carattere dominante, ma mia madre era uguale, quindi tra loro scoppiavano di continuo liti furibonde. Finiva sempre che arrivavano gli sbirri e mandavano Eddie a farsi un giro dell’isolato, per darsi una calmata. Capitava che ci andassimo di mezzo anche noi bambini. Una volta mia madre e Eddie stavano litigando pesantemente e passarono alle mani. Io mi misi fra loro per difendere mia madre: cercavo di trattenere Eddie, ma lui mi sferrò un pugno nello stomaco e mi stese. Non riuscivo a crederci, cazzo. Ero solo un bambino! Per questo non ho mai alzato le mani sui miei figli. Non voglio che da adulti mi ricordino come un mostro. A quel tempo, però, picchiare i figli era considerato normale. Nessuno batteva ciglio. Adesso gridano allo scandalo e ti sbattono in galera.
Eddie e mia madre si accapigliavano per qualsiasi cosa: per gelosia, per soldi, per chi dei due dovesse esercitare il controllo. Lui non era certo uno stinco di santo. Quando mia madre invitava le sue amiche, si sbronzavano tutti; poi lei collassava e lui si scopava le altre. Dopodiché succedeva il finimondo. Roba da barbari, con tanto di armi e coltelli. «Figlio di puttana, fottiti!» «Succhiami il cazzo, negra…» Noi urlavamo: «Mamma, no, fermati!». Una volta, quando avevo sette anni, Eddie le tirò un pugno e le fece saltare un dente d’oro. Mia madre andò in cucina e mise a bollire un pentolone d’acqua. Disse a mia sorella e a mio fratello di nascondersi sotto la trapunta, ma io stavo guardando il wrestling in tv e non la sentii. Lei fece tutto di soppiatto, senza che lui si accorgesse di niente. Quando tornò in camera, i miei fratelli erano pronti e al riparo. Eddie era seduto accanto a me; un attimo dopo, un fracasso tremendo: mia madre gli aveva rovesciato in testa l’acqua bollente. Ne arrivò un po’ anche addosso a me. Eddie uscì urlando sul pianerottolo, io gli corsi dietro. Lui si girò e mi afferrò. «Oh, piccolo, ha scottato anche te, quella puttana?» «Già, la puttana mi ha beccato, ha beccato anche me!» Lo riportammo in casa, e lui si sfilò la camicia. Aveva il collo, la schiena e un lato della faccia completamente coperti di bolle. Sembrava un rettile. Lo facemmo sdraiare sul pavimento sotto la finestra, davanti al piccolo condizionatore d’aria. Mia sorella sterilizzò un ago con la fiamma dell’accendino e le fece scoppiare una per una. Lei piangeva, e anch’io. Per consolare Eddie gli regalai un nichelino.
Ripensandoci oggi, nella gran parte dei casi vedevo mia madre come la vittima, ed è vero che Eddie la picchiava....