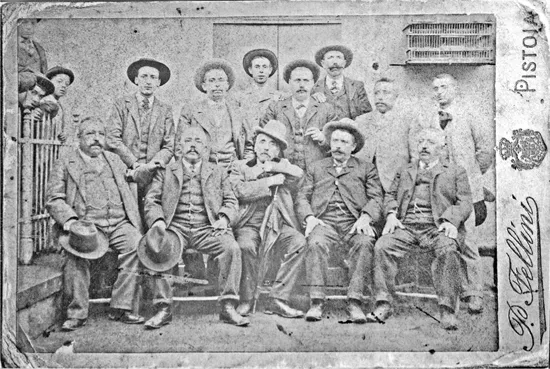![]()
Capitolo 1
Tutto cominciò con un tè danzante, una domenica di guerra del 1940.
Lei, Lucia, aveva vent’anni e le gambe più belle di Bologna. Almeno così raccontava, furente con i Biagi, colpevoli di essere portatori sani di caviglie grosse: nessuna delle sue tre creature avrebbe purtroppo ereditato quelle meraviglie.
Lui, Enzo, un anno di più, bruttino, occhiali da miope, era magro come un chiodo. Anche antipatico, leggermente supponente: si presentava come giornalista, era redattore al «Resto del Carlino» e dichiarava che mai si sarebbe sposato, tantomeno con quella maestrina appena rientrata da un incarico a Pozzuoli. Infatti.
Scalzò immediatamente l’accompagnatore di Lucia, tal avvocato Capra, e alla fine del ricevimento si impose per scortarla fino a casa. Ci scusiamo con l’avvocato e gli eventuali suoi discendenti, ma il racconto di nostra madre ci ha sempre fatto ridere, un po’ per il cognome del suddetto e poi perché ci immaginavamo la mamma che si presentava come signora Capra. Rideva anche lei insieme a noi, diceva che quel corteggiatore era belloccio e alla domanda: «Perché hai scelto papà che francamente non era un granché?» rispondeva: «Ma era tanto simpatico e intelligente».
Così, sulle note di Alberto Rabagliati si compì il nostro destino. I due ragazzi, come si usava allora, si fidanzarono presto anche perché la signorina Lucia Ghetti, orfana di padre, era sorvegliata a vista da tre fratelli maggiori e confinata agli arresti domiciliari da una madre poco permissiva e tutt’altro che cordiale. Una madre che, oltre tutto, aveva quarantacinque anni più di sua figlia. Ogni volta che il giovane cronista andava «a morose», la futura suocera, per noi futura nonna Anna, si sedeva sull’ottomana e li fissava intensamente, tanto che quando una sera lo sconsiderato, vedendo l’anziana appisolata, sussurrò all’amata: «Ma la vecchia non va mai a letto?», si sentì rispondere dalla severa sorvegliante: «La vecchia non si muove».
Papà veniva da una famiglia culturalmente superiore a quella della mamma, ma i suoi avevano conosciuto tempi migliori. Il nostro rimpiangeva i mille operai di suo nonno Marco che dall’Appennino partivano verso la Corsica e la Sardegna per fare il carbone di legna. Diceva: «Mi avessero lasciato l’azienda oggi sarei diventato un petroliere». Non andò così. I suoi vecchi fallirono esattamente un anno prima che lui nascesse, travolti dalle conseguenze economiche della Prima guerra mondiale. Sua madre, la nonna Bice, si era maritata (adesso possiamo dirlo) più per ragionamento che per amore con quel Dario, piccolo padrone delle ferriere, e si ritrovò invece sposina a fare la spesa con le monete d’oro, dono di nozze delle sue amiche. Ma non rinunciò mai ad andare a messa con il cappellino e i guanti e si sentì sempre parte della famiglia più importante di Pianaccio. «Eravamo i feudatari» si vantava con la sua consueta modestia. Probabilmente il rimpianto per i passati splendori e il confronto con una realtà fatta di ristrettezza, seppur dignitosa, segnò nostro padre: la sua vita, e poi le nostre, sono state guidate dall’idea di conservare per sé e per chi sarebbe venuto dopo.
Un ruolo fondamentale ebbe lo zio Edgardo, da noi detto Eddi o Gardela, uno dei fratelli della mamma, zitello, facente funzione paterna. Pur apprezzando le doti intellettuali del giovane giornalista, lo zio Eddi rimaneva perplesso per la scarsità dei mezzi del futuro cognato, che era costretto a un abbigliamento, più che minimalista, minimo. Sarto di fama, manteneva l’orfana e la vedova in un signorile appartamento di via Galliera, in pieno centro a Bologna, e si innervosiva quando papà si fregiava con un certo orgoglio della sua condizione proletaria dovuta al fatto che il padre, rovinato, era stato costretto a passare da signorino a magazziniere nello zuccherificio. Gli ricordava i cugini laureati, la nonna maestra, lo zio ingegnere e quel parente che era diventato sottosegretario con Mussolini. «Non capisco questo atteggiamento,» diceva Gardela «almeno pubblicamente dovrebbe dire di essere stato un borghese.» A un certo punto la sua adorata Dadina, così chiamava la sorellina, lo obbligò a confezionare al futuro sposo un vestito come si deve: niente pantaloni a cagarella, spalle di misura giusta e stoffa non recuperata da un vecchio paltò. Non arrivò, in quell’occasione, a esprimersi nei virtuosismi dei frac che spediva a Arthur Rubinstein a Londra, ma si diede da fare.
Il cambio di look non bastò comunque a papà per togliergli le insicurezze. Sembrava un personaggio di Verga, stretto tra il culto per la casa del nespolo dei Malavoglia e Mastro-don Gesualdo con il suo attaccamento alla «roba». Si sentì più sicuro quando poté comprare il primo appartamento, e poi un podere: pur non capendo niente di semina o allevamento di vitelli, credeva, con quella terra, di mettere al riparo la famiglia dalla fame. A ogni crisi economico-politica proponeva di ritirarci in campagna: col grano e le patate saremmo sopravvissuti a qualunque carestia.
Nel 1956, sull’onda del terrore per quanto stava accadendo in Ungheria, costrinse la mamma a fare incetta di zucchero. «Se durante la guerra avessimo avuto un quintale di pepe, saremmo stati ricchi» spiegava. Era convinto che in certi frangenti si ritornasse al baratto: ti do un chilo di zucchero in cambio di una gallina. I chili e chili acquistati finirono nel cassettone regalato dalla nonna Bice agli sposi e ci vollero anni per smaltirli.
La fedele segretaria di papà, Pierangela, dice ancora che a Casa Biagi non si respirava il lusso ma la solidità. Nostro padre viveva il suo mestiere come un impiegato, attaccava la mattina, interrompeva per il pranzo e il pisolino e ricominciava il pomeriggio. Era sua moglie che quotidianamente gli consegnava i soldi per la giornata, il guadagno per lui voleva dire assicurare a sua madre una vecchiaia serena, alle sue figlie l’indipendenza dai mariti e, cosa più importante, la libertà di scelta. Ormai vecchio passeggiava tra i filari della sua vigna e osservava con un certo stupore: «Pensare che ho guadagnato mettendo una parola dietro l’altra».
Ma torniamo a quegli inizi. In un’Europa che bruciava, accompagnato dalla colonna sonora delle sirene che annunciavano i bombardamenti su Bologna, l’amore tra i nostri ragazzi trionfava sul male. I maschi Biagi accolsero subito Lucia con entusiasmo: lo zio Checco, fratello minore di papà, la vedeva addirittura come Marlene nell’Angelo azzurro. Il legame fra i cognati durò tutta la vita e fu sempre di grande complicità e tenerezza.
Con la suocera un po’ meno. Non si fece mai chiamare mamma, anzi, preferì farsi dare del lei e mantenere un formale distacco. Non racconteremo del nonno Dario perché uscì di scena nel 1942 a soli 51 anni in seguito a una banale operazione di ulcera.
Il fidanzamento fra Enzo e Lucia si fece così serio che nel 1941 lui le impedì di allontanarsi per andare a insegnare a Rodi, l’isola del Dodecaneso che fin dal 1912 era stata conquistata dall’Italia nella guerra italo-turca. La raccomandò invece all’anagrafe del Comune di Bologna. Tempo due mesi, e Lucia Ghetti fu licenziata per scarso rendimento. Giustificazione: «Non ero portata e poi non era quello il mio lavoro».
In effetti erano molti gli impegni e le incombenze che non le sarebbero appartenuti. Trovava scandaloso e indelicato, per esempio, che si pretendesse da lei di sintonizzare i canali della televisione. «Non sono un tecnico» affermava convinta e si rifiutava anche di infilare nella presa la spina del giradischi.
Ritornando ai primi capitoli di questa storia, mentre la guerra infuriava, papà scelse la via della montagna e la mamma scelse di opporsi alla sua famiglia, contraria al matrimonio, proponendogli la fuga d’amore. Istanza respinta: lui aveva avuto un’educazione cattolica che lei, per altro, figlia di un anarchico e di un’atea, gli rinfacciò per tutta la vita. Inoltre in Casa Biagi vigevano il rispetto per le regole sociali e un certo conformismo. Questi erano gli aspetti di nostro padre che non capivamo. Ci mandava a studiare l’inglese, libere di vivere a 18 anni in un appartamento a Londra, poi, a Milano, il coprifuoco scattava a mezzanotte. Chi ha pagato di più certe rigidità è stata la primogenita. Bice non ha mai potuto andare in vacanza col fidanzato, per la verità non ha mai osato chiederlo. Pochi giorni prima del sì, in campagna con il promesso sposo e la nonna Bice, si trovò la vecchietta nel letto accanto al suo. «Non sta bene che dormiate sotto lo stesso tetto senza sorveglianza» fu la spiegazione dell’anziana signora.
Se alle nostre richieste di un weekend con il moroso di turno papà ululava: «Non pago lune di miele anticipate», le idee della mamma in materia erano più aperte. Per lei, convinta che la verginità fosse solo uno stato mentale, contava soprattutto che fossimo innamorate. Insomma, da noi c’era la continua disubbidienza a quella norma pedagogica che vuole concordanza educativa tra i genitori.
A conti fatti oggi, signore sessantenni, riconosciamo nel rigore e nel senso del dovere imposti da nostro padre un codice di comportamento che ci ha aiutato a cercare di essere persone serie o quantomeno poco cialtrone, così come l’anarchia materna ci lascia un ricordo divertente del nostro passato. In effetti, appena papà partiva per un servizio, il clima cambiava, la nebbia della severità si diradava e sorgeva il sole della libertà, a volte anche un po’ sfrenata. Da grandi, ogni volta che il campo era libero diventarono un’abitudine le lunghe chiacchierate notturne con la mamma. Si rivolgeva a noi come fossimo amiche, non tralasciando niente della sua vita. Riandava a quando, a braccetto col fratello Eddi, beccò l’allora fidanzato Enzino all’uscita del casino di via San Marcellino a Bologna. Tragedia. Papà si trincerò dietro la scusa del rispetto per la sua illibatezza e le mandò un’enorme ciotola di violette, che non fu apprezzata ma finì nel canale che scorreva dietro la casa di via Galliera. In qualche modo devono aver fatto la pace e anche nostro padre dimostrò la sua vena di follia perché solo dei matti si potevano sposare, nella chiesina di Pianaccio, il 18 dicembre 1943, nel pieno della guerra.
Esilarante la cronaca della prima notte. La coppia giaceva vestita su un altissimo letto di ferro smaltato, angeli e fiori dipinti sulla testiera, osservati da quei signori raffigurati nei quadri del bisnonno che avrebbero poi terrorizzato i nostri sonni di bambine. Il partigiano Enzo doveva infatti tenersi sempre pronto per la fuga, caso mai i tedeschi avessero deciso un rastrellamento, e la nonna Bice, quarantacinquenne, entrava ogni dieci minuti nella stanza nuziale per controllare se i ragazzi avessero freddo.
Il racconto familiare di quegli anni si snoda tra gli orrori bellici, la fame patita, le angherie di una suocera troppo giovane e gelosa, senza la quale, però, la sposina non sarebbe sopravvissuta nemmeno mezza giornata in quel villaggio di montagna. Non è un caso che le giovani amiche sfollate a Pianaccio la chiamassero la «svenevole» Lucia: passava molte ore a letto causa anemia e forte avversione per la polenta e le castagne. Unica consolazione, le adorate saponette che teneva nascoste perché servivano a idratare solo ed esclusivamente la sua pelle.
E qui è doveroso fare un accenno a un’altra «patologia» materna, una grave forma di dipendenza da creme, bistecche crude distese sul volto, maschere ad rugam evitandam. Non c’è stata mattina che i nostri occhiali da bimbe miopi, ancora un’altra eredità paterna, non venissero ricoperti da una patina untuosa nell’accostare i visetti per il bacino pre scuola. Nostra madre non ci chiedeva «Come stai?», ma «Ti sei messa la crema?», e noi le abbiamo dato ben poca soddisfazione. «Vi ho fatto una pelle di luna,» ci sgridava «poi vi siete rovinate da sole.» Papà la prendeva in giro: «Da giovane, Lucia, ti bastavano i saponi. Poi, con gli anni, non hai potuto fare a meno delle perle perché danno luce, della pelliccia per difenderti dall’artrosi e del cachemire perché non irrita». Lei rispondeva piccata, non rinunciava a niente, ma gli ricordava che alla prima di una commedia firmata Enzo Biagi, non possedendo un cappotto nero, si era presentata spavalda con un mantello scozzese.
Al di là dei lati frivoli, era una donna di carattere, e lo dimostrò quando, durante un rastrellamento, i tedeschi entrarono nella cucina di Pianaccio e lei protesse l’amato, costretto a passare una notte piovosa nell’orto sotto le piante dei fagioli, spiegando ai soldati della Wermacht che quella pipa calda appoggiata sul camino era la sua. Teniamo conto che a quei tempi non fumava nemmeno una delle quaranta sigarette quotidiane che le avrebbero tenuto compagnia fino alla morte.
Questi momenti fanno parte dell’aneddotica, i capitoli seri di quegli anni ci sono stati trasmessi più da papà che dalla mamma. Ci raccontava che era diventato antifascista a diciotto anni, dopo l’annessione dell’Austria alla Germania. Ci riferiva delle liti con il padre, fascista e capofabbricato, che gli dava del disfattista, e delle paure di sua madre che i vicini lo scoprissero ad ascoltare Radio Mosca. Ci parlava della signora Ines che gli aveva procurato un documento falso per l’esonero dal servizio militare. Ricordava i suoi compagni ebrei, improvvisamente scomparsi dalla classe. Rammentava Gino Albertazzi, partito per la Russia e finito da qualche parte vicino a Stalingrado, rivendicava la sua avversione alle armi («Non sopporto chi fa bum anche con la bocca»), e andava orgoglioso della sua adesione al Partito d’Azione. Si rattristava perché il suo amico Alberto Vitale era andato con quelli di Salò.
Una volta, sarà stato il 1957, venne a Pianaccio il capitano Pietro, il comandante della piccola brigata di montagna alla quale papà si era unito: mangiammo in sala da pranzo e la nonna aveva apparecchiato con i piatti delle feste. Nei loro discorsi c’era un infinito rimpianto per Sandro Contini Bonacossi, il conte appartenente alla grande famiglia di collezionisti fiorentini che da partigiano si lavava nell’acquaio della cucina della nonna Bice. «Sandro è uno degli uomini più coraggiosi che ho conosciuto, e anche dei più intelligenti e umani. Vittima, credo, di confuse vicende familiari. Allievo di Ragghianti e di Longhi, era cresciuto in una casa dove erano esibiti tanti capolavori dell’arte italiana. Se ne andò dall’Italia. Lo ritrovai a New York, dove lavorava alla Fondazione Samuel Kress; era triste, mi spiegò che aveva perfezionato l’inglese guardando la televisione. Nel museo esponevano anche costumi di samurai: li indossammo e chiudemmo per mezz’ora la porta ai visitatori per imbastire un improbabile duello in memoria di certe ragazzate del passato. Sandro aveva sul comodino una piccola foto di Elsa [l’ex moglie, Elsa De Giorgi, N.d.R.]; disse una battuta amara, e si avvertiva il rimpianto. Si è ucciso.» Papà appena poteva si ritrovava con Ferruccio Pilla, cognato del presidente Ciampi, a Ronchidoso, il luogo dove si era costituita la loro formazione.
Ancora frequentiamo Checco, l’avvocato Francesco Berti Arnoaldi Veli, e nei pomeriggi d’estate nella sua casa alla Guanella scopriamo sempre qualcosa di più di nostro padre partigiano. «Checco fu il primo della brigata che conobbi, legammo subito; mi diede la sua pistola. Era uno dei più giovani, ma non aveva la crudeltà dei ragazzi che non capiscono neppure cos’è la morte; era uno che pensava parecchio… Con Checco leggevamo la vita dei fratelli Rosselli. Mi piacquero molto quei borghesi ricchi che avevano saputo rinunciare a tutto, senza compromessi.»
Quando eravamo piccole l’episodio della guerra che più ci colpiva era il racconto della fucilazione da parte dei partigiani dello zio Gigi, fascista, fratello della nonna Bice. In famiglia non se ne parlava volentieri, c’erano dolore e imbarazzo e noi, pur bambine, capivamo che era meglio non fare domande. Sapevamo solo che era stato sepolto in un bosco ed esumato dalle sue sorelle.
Nostro padre ci ha parlato diffusamente e quasi ossessivamente della Resistenza soltanto negli ultimi anni della sua vita. La spiegazione sta forse in questa breve citazione da «Patrioti», il giornale che fondò nei quattordici mesi in montagna con Giustizia e Libertà: «E i ragazzi lasciarono le case e andarono sui monti. Lasciarono la loro giovinezza che non aveva e non avrebbe mai più trovato la sua stagione. Videro la morte e uccisero, seppero la crudeltà e l’amore, la disperazione e la speranza. Offrirono i loro vent’anni per avere una certezza, una fede che li sollevasse. La trovarono in un nome. Libertà. Li sostenne nei giorni duri; li animerà se dovranno ancora combattere perché nessuno tolga – agli uomini di vent’anni già vecchi – quella libertà che fu spesso la sola fiamma per riscaldare la loro inesistente giovinezza».
E la vita continua. Il 25 aprile 1945 papà legge da Bologna la notizia della Liberazione ai microfoni della radio della Quinta Armata, insieme con Tommaso Giglio e Antonio Ghirelli. Riprende a lavorare al «Carlino» che si chiamava «Giornale dell’Emilia».
Altra data fondamentale è il 2 giugno 1946: papà e la mamma scelgono la Repubblica e la nonna Bice viene blindata in casa per impedirle di votare per la sua amata Casa Savoia.
Non un giorno storico, ma importante per Casa Biagi, è il 5 maggio 1947: viene alla luce la primogenita coronando il sogno materno fino ad allora deluso. «Sembrava che non potessi aver figli» raccontava la mamma. «Vostro padre mi consolava dicendo che a lui la paternità non interessava un granché, ma io soffrivo. Dopo mesi di nausee mi è venuto un dubbio. Non ero esaurita, ma incinta.» Poi, per addolcire la pillola, ci rassicurava: «Comunque, una volta arrivate, papà vi ha molto amate». È sempre stato un uomo sincero, al limite della brutalità, e possiamo assicurare che solo verso la fine, dopo anni di nostro accudimento, ha riconosciuto che era stata una benedizione aver messo al mondo tre femmine. Concetto che abbiamo ribadito davanti alla sua camera ardente. Dopo che centinaia e centinaia di persone si erano complimentate con noi per la fortuna di aver avuto quel padre, la Carla, con i suoi consueti modini, ha chiarito a una signora: «Guardi che anche a lui, con noi, è andata di lusso».
Di una cosa siamo certe, almeno a sentire nostra madre: nessuna donna nella storia dell’umanità aveva avuto un parto come il suo. I dolori furono strazianti, imperversarono per giorni e notti, lei più volte minacciò di buttarsi giù dalla finestra, e con queste descrizioni ci diede il viatico alle nostre future gravidanze. Quando, dopo nove anni di matrimonio, la Bice, contro i pronostici di parecchi specialisti, mostrò alla mamma il cerchio perfetto del test che certificava il suo stato interessante, il commento fu: «Speriamo che poi non ti venga l’esaurimento come a me ogni volta che sono diventata madre». In effetti, subito dopo il lieto evento per mami si aprì un altro capitolo doloroso. Pur dotata di un possente torace, non aveva una goccia di latte. E mentre la piccola Bice vagiva per i morsi della fame, si trovò una balia, come si diceva, bagnata. Di lei si conosce solo il nome, Giovanna, e si sa che era di Monsummano. Nostra madre non ha mai voluto raccontare alla Bice niente di più, nel terrore che potesse andare a cercare quella nutrice. Alla richiesta: «Potrei conoscere la mia sorella di latte?», la questione veniva liquidata con una spiegazione lapidaria: «No, perché la Gi...