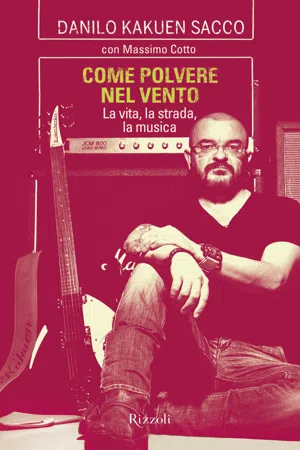![]()
Una premessa
Per diciannove tour ho avuto il piacere e la responsabilità di lavorare con un gruppo musicale italiano che certamente tutti conoscete.
Essendo stato diffidato (al momento di andare in stampa, per ora, due volte) dall’usare il nome di detto gruppo e non volendo creare problemi né urtare la sensibilità di nessuno accostando il mio nome a quello del gruppo, ogni qualvolta dovrò menzionarlo lo chiamerò semplicemente N., dato che non, e ribadisco non, intendo creare disagi, malumori né polemiche che possano essere strumentalizzate da chicchessia.
Grazie.
![]()
1.
Il canto
Per molti anni, una notte su tre ho sognato di perdermi in un labirinto, incapace di trovare la via d’uscita. Mi svegliavo terrorizzato, andavo a dormire terrorizzato. Una notte, finalmente, cambia qualcosa. Mi perdo nel labirinto e come sempre mi affanno per venirne fuori. A un certo punto sento la voce di una bambina che canta. Seguo la voce, cerco di trovarne la fonte. Finisco in un tunnel buio. Continuo a sentire la voce, mi faccio coraggio e non mi fermo. Arrivo alla fine del tunnel. C’è una donna con in braccio una bambina. È lei che canta. Le saluto, le supero e mi avvicino a una porta semiaperta da cui filtra un raggio di luce. Apro la porta e vado via.
Non ho mai più fatto quell’incubo.
Il canto mi ha salvato la vita.
![]()
2.
Rinascite
Tre ore e vengo al mondo. Centottanta minuti. Diecimilaottocento secondi. Passeranno in un attimo o in un secolo, chissà.
Tre ore e rinasco. Non è da tutti, ammettiamolo. Sono già morto e rinato quattro volte: dopo la depressione, dopo un incidente, dopo aver conosciuto il Dalai Lama e aver abbracciato il buddismo, dopo un infarto. Vi racconterò tutto, dovete solo avere un po’ di pazienza. Ora è presto, perché sto per vedere la luce. Per la quinta volta.
E stavolta è diverso. Diciannove anni pesano. Sono quasi quattro lustri. Diciannove anni con i N., che per me sono stati molto più di una band. Amicizia, ragione di vita, musica, incontri, lacrime, sorrisi, fatica, rabbia, dolore, risate. C’è stato un momento in cui ho pensato che i N. fossero qualcosa di più grande della vita stessa, perché della vita concentravano l’essenza. Cantavo, salivo sul palco più di cento sere l’anno rinnovando ogni volta un rito straordinario, giravo il mondo e conoscevo le culture degli altri, imparando sempre qualcosa di nuovo su me stesso perché è dal confronto che arrivano i miglioramenti. Con i ragazzi, quasi tutti, dividevo ogni cosa e moltiplicavo le emozioni. Diciannove anni di suoni e canzoni. E bevute. Una famiglia, per qualche anno. Qualsiasi cosa accada, tutto questo non sarà mai dimenticato. Né rinnegato. Tradito. Venduto. A nessun prezzo. Sia chiaro a tutti: la mia vita con i N. è stata fantastica. All’inizio difficile, quasi terribile, perché si trattava di vincere diffidenze e resistenze. Certo, tutte comprensibili. La gente veniva a sentire i N. e, al posto di Augusto Daolio, trovava un ragazzino mai visto prima. Al posto della storia c’era una scommessa, al posto della leggenda un contadino. Poco alla volta, giorno dopo giorno, centimetro dopo centimetro ho guadagnato terreno. Mi sono conquistato il rispetto di tutti e l’amore di molti. Non potrei mai tradirli.
Tre ore. Sono a Osnago, in provincia di Lecco, un paese attraversato da due fiumi, il Molgora e il Curone. Mi piace l’idea: il fiume scorre, non si arresta se non a destinazione. Poco più di 4500 abitanti. L’albergo dove mi trovo è tranquillo come la gente del posto. Ho pranzato all’aperto, in un bar che fa anche piatti caldi. Roba leggera. Io, Chiara (che è perfetta e discreta, a volte mi prende la mano e finge di essere sicura che tutto andrà bene), Massimo Cotto (l’unico al mondo che si è perso quattro volte da Milano a Osnago, che distano 24 chilometri, e che è arrivato ieri sera a cena finita da due ore) e mio fratello Gianmario (che non si capisce mai cosa pensi, e forse è meglio così). Nel bene e nel male, la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova vita l’ho attraversata con loro. È bello che le ultime ore le viviamo insieme.
Due ore e mezzo. Arriva Massimo Bubola con la sua Erika. Massimo è stato fondamentale nella mia vita, perché mi ha aiutato quando nessuno mi tendeva la mano. Se stasera si apre una nuova porta, è cosa buona e giusta che sia con lui. Prendiamo un aperitivo. Da persona intelligente, Massimo parla di tutto ma non del concerto, non di quello che sta per accadere. Non ho bisogno di altra tensione. Sono sicuro di quello che faccio, ma sarebbe stupido dire che non sono teso.
Due ore. Ultime prove. La band va come un treno. Non posso avere paura di nulla, con loro. Se anche, paradossalmente, mi fermassi io, andrebbero avanti loro. Certo, meglio evitare. Il palco è già pieno di regali. Dio benedica il mio pubblico.
Un’ora. Torniamo in albergo. Preferisco arrivare all’ultimo momento sul luogo del concerto. Non mi piace attendere in camerino. Quando arrivo dove devo cantare, ho così tanta voglia di palco che mi sembra di sprecare il mio tempo a fare qualsiasi altra cosa.
Mezz’ora. Siamo ancora in albergo. Si sta facendo tardi, ma Gianmario non è ancora passato a prenderci. Ora non parliamo quasi più. Io, Chiara, Massimo Cotto, Massimo Bubola guardiamo fissi in punti diversi. Si avvicina il momento in cui non si faranno prigionieri.
Un minuto. Entro nell’ampio spazio allestito per il concerto come un pugile prima del combattimento. Stasera dobbiamo vincere tutti: io, la band, i miei collaboratori, il mio pubblico, la musica. Sento Massimo Cotto che parla dal palco. C’è un boato del pubblico, chissà cos’ha detto. Tra poco si va.
Si va.
Di nuovo vivo.
Di nuovo addosso alla musica e con la musica addosso.
Di nuovo parte del tutto.
Di nuovo polvere nel vento.
![]()
3.
Il male di vivere
Sono nato insoddisfatto. Mi sento inferiore a tutti. Sono molto esigente verso me stesso e mai appagato dal risultato. Vorrei cambiare così tanto di me, che farei prima a rottamarmi.
Oggi riesco ad accettarmi come sono, anche se è difficile, ma c’è stato un tempo in cui non ce la facevo.
Ho conosciuto la depressione.
Solo a scriverne il nome, ho un brivido.
Dai diciotto ai ventitré anni. Mica uno scherzo.
Mischiavo alcol e psicofarmaci. Un idiota totale. Avevo paura della vita. Mi imbottivo di pasticche e poi andavo a dormire. Tipico dei depressi, che da svegli soffrono di più. Molto meglio l’intontimento o il sonno.
Ero un’ameba incapace di godersi la vita e di avere rapporti sani con le persone. Al lavoro mi isolavo. Non davo fastidio, ma non stavo bene. Occupavo una porzione di spazio-tempo. Sopravvivevo. Vivere è un’altra cosa. Una delle poche cose che mi faceva stare bene era ascoltare Tomorrow degli U2. Per quei pochi minuti mi sentivo in pace con il mondo. Poi tornava l’inferno.
Come ci sono finito dentro, non so. Se sapessimo da dove viene quel dolore, sarebbe più facile guarirne.
Mi svegliavo la mattina e pensavo che non c’era una sola ragione per cui valesse la pena affrontare la giornata.
Il male di vivere.
Non è facile parlare di queste cose. Anche perché dalla depressione non si guarisce. Sia chiaro a tutti. Ci sono momenti in cui sei in grado di metterla a dormire, a tacere per un po’. Ma stai sicuro che prima o poi salterà di nuovo fuori.
È una bestia terribile.
Una volta ho letto una bellissima storia che riguardava Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman. Erano molto amici, tanto da potersi permettere battute pesanti. Così una volta Gassman disse a Mastroianni, già malato da tempo: «Caro Marcello, beato te che hai un tumore. Io ho la depressione».
dp n="17" folio="17" ? Beh, il commento è certamente opinabile, ma Gassman disse una piccola verità. Dalla depressione comunque non si guarisce mai. Nei momenti belli riesco a tenerla sotto controllo e a non farle guadagnare troppi centimetri. Però rimango un ansioso cronico e questo fa di me un buddista anomalo. Il buddista vive il presente e dice: qui e ora, perché del doman non v’è certezza e perché il passato è andato. Il futuro non esiste, il passato è uno spettro. Tutto vero. Però l’ansia rimane. Questo significa che devo ancora studiare.
L’unico luogo dove comando io e dove non ho paura di nessuno è il palco.
![]()
4.
Famiglia, amore, morte
Sono nato in un pueblito, in un piccolo paese dove le persone sono abituate a stringersi l’una con l’altra. All’epoca si chiamava semplicemente Agliano, oggi è Agliano Terme, per dare un tocco di mondanità a un bellissimo gruppo di case che solo un’anima insensibile potrebbe definire anonimo e uguale a tanti altri paesi di campagna.
Era il 6 giugno 1965, ovvero 6.6.65, tre 6 consecutivi, involontario omaggio al diavolo, a cui non credo. Credo nell’esistenza del male, ma non nella sua straripante forza. A volte il più dolce dei sorrisi basta a far indietreggiare un esercito.
Gemelli, seconda decade. Non so nulla del mio quadro astrale, se non che sono nato alle dieci di sera. In quel giorno sono successe molte cose nel corso dei secoli, belle e brutte: il 6 giugno 1861 moriva Camillo Benso conte di Cavour, il 6 giugno 1944 l’operazione Overlord dava il via alla battaglia di Normandia, il 6 giugno 1972 David Bowie pubblicava «The Rise and Fall of Ziggy Stardust». Nella Corea del Sud il 6 giugno è il giorno della memoria. A me piace sapere che il 6 giugno è considerato il giorno del visionario, dei pazzi. Questa definizione mi si addice parecchio, nel bene e nel male. Sono certamente pazzo, altrimenti non avrei abbandonato i N., sono sicuramente visionario: ecco perché ho abbandonato i N.
Sono nato in casa, come si usava una volta. Niente ospedale, con una levatrice. Che ci crediate o meno, io ricordo il momento della mia nascita. Non dall’inizio alla fine, certo. Tanti flash, però distinti. Sensazioni. Ricordo tanto freddo, ad esempio. Se pensate che questo provi che sono pazzo e visionario, sappiate che una persona su tre ricorda quei momenti, o è convinta di ricordarli. Solo che non sempre ha il coraggio di dirlo.
Sono cresciuto in un ambiente molto umile, ma caldo, accogliente. Un nido che mi ha protetto e che al solo ripensarci ancora mi fa star bene. In famiglia c’era una bellissima atmosfera, anche se la situazione non era affatto semplice. Eravamo poveri, come molta altra gente in quella zona del Monferrato. I miei si sbattevano per farci crescere sereni e ci sono riusciti. Avevamo sempre la pancia piena, nonostante tutto. Io correvo nei campi e mi rifugiavo nei boschi come fossero luoghi delle fate. Bastava l’odore del pane per farmi stare bene. C’era questo fornaio, Lejo, di cui nessuno sapeva il nome vero. Era Lejo per tutti, come si usa in campagna, dove si vive di diminutivi o soprannomi. Mio padre si chiamava Pietro, ma per tutti era Mario, vai a sapere perché. Mio zio Coriolano tutti lo chiamavano Nanni. Roba di paese.
Lejo faceva il pane e poi lo portava la mattina presto casa per casa, come si usava anche per il latte. Per me era festa ogni volta che lo sentivo avvicinarsi con il suo Ape.
C’era un altro motocarro che mi dava gioia. Arrivava da Savona. Portava il pesce. Una volta la settimana. Faceva il giro dei paesi e poi tornava in Liguria. Mia madre mi comprava un cartoccio di gianchetti sotto sale e io impazzivo. Non era ancora come adesso, che la pesca è regolata da precise disposizioni e restrizioni. Io, i gianchetti, che dalle mie parti chiamavamo ceche, me li spazzolavo per colazione. «La colazione dei campioni» diceva mia madre.
dp n="22" folio="22" ?
Mia madre si chiama Letizia, è nata nel 1936. Mio padre non l’ha mai chiamata con il suo vero nome. Mai. Per lui era Lidia. La leggenda racconta che Lidia fosse il nome del suo primo amore, della ragazza che gli aveva fatto perdere la testa. Mio padre non l’aveva dimenticata, mia madre abbozzava. Come spesso accade, le donne, più intelligenti degli uomini, assecondano, tanto sanno che alla fine vinceranno loro. Sempre.
È stata mia madre a crescere me e mio fratello Gianmario, perché mio padre, di dieci anni più vecchio, era un marittimo. Stava in mare dieci mesi l’anno. Batteva le rotte transoceaniche. La sua preferita era Giappone-Sudafrica-Brasile e ritorno. Partiva con l’aereo, arrivava in Giappone e lì si imbarcava. A casa non c’era mai, ma lui era felice. L’acqua, per mio padre, era tutto. A distanza di tempo sono felice che lui abbia realizzato i suoi sogni, però è innegabile che mi mancasse. Quando sei piccolo e non hai un genitore, sei felice a metà.
Per fortuna, l’assenza di una figura paterna è stata colmata dal mio zio materno, il buon Coriolano alias Nanni. Era grande come un armadio. Occhi blu cobalto e capelli biondi. Lo chiamavano anche il Tedesco, soprannome insolito per un combattente partigiano. Professione calzolaio. Ciabattino. Lo guardavo lavorare per ore e ore. In silenzio. Ricordo l’odore del cuoio e della colla. Inebriante. Mio zio ripeteva sempre: «Ogni cosa si può aggiustare, non dimenticarlo mai».
Mio zio Nanni dava nuova vita alle cose vecchie. Ho ripensato a lungo a lui e ai suoi insegnamenti quando ho cominciato a valutare l’idea di lasciare i N. Avevo bisogno di un nuovo soffio di vita. Volevo le mie vecchie scarpe, ma aggiustate. Gli ideali erano sempre quelli ma sentivo la necessità di aria fresca, di energia nuova, di nuovi compagni che mi apprezzassero per quello che ero, nelle mie molte fragilità e nelle mie poche grandezze. Qualcuno che mi considerasse come essere umano, non solo come il cantante del gruppo in cui suonavano. Ogni cosa si può aggiustare, mi ripetevo. E così è stato. Ho preso la decisione quando sono riuscito a mettere insieme tutti i tasselli, quando ho finalmente visto la mia storia con i N. in prospettiva, nella sua totalità e non un pezzo alla volta.
Come capita a tutti gli esseri umani, mi devo sforzare per avere una visuale completa. Mi lascio abbagliare dai singoli elementi. È come la storiella dei quattro ...