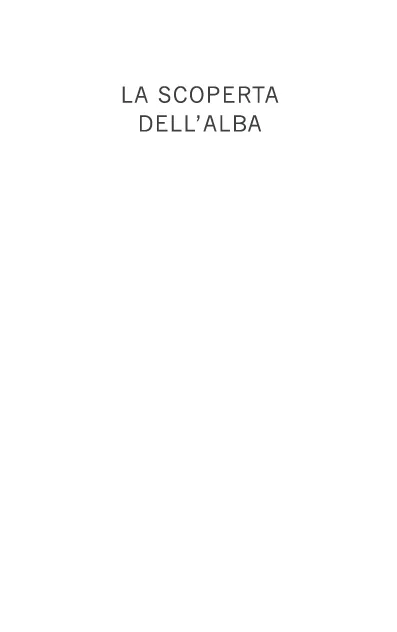È un’alba semplice, quella di oggi. Da quando il mio orologio biologico ha cominciato a svegliarsi regolarmente all’ora in cui il giorno comincia, io ho preso a organizzare la natura dell’alba. Ho iniziato a leggere le differenze tra quelle delle diverse stagioni, a selezionare e preferire le combinazioni dei colori, le posizioni del sole. Ogni alba ha un senso, uno diverso. E un grado di intima complessità. Ma l’alba non ha dignità. Né le enciclopedie, né Google si occupano di lei. È considerata solamente una scansione del tempo che passa, un viandante invisibile e leggero. Invece non è così. Le albe che vedo da un anno, ogni giorno, sono anticipazioni di Dio. Sono silenzio e grandezza, pausa e attesa, inizio e fine, tradizione e cambiamento. Le guardo come se fossero un mondo possibile, intenso, lieve, pieno di colori. Ma qui, nella soffitta dove mi rifugio appena sveglio, non siamo soli, l’alba e io. Ci sono molti compagni: il respiro di mia moglie che dorme nella stanza vicina, i denti digrignati a intervalli regolari da mia figlia Stella e una musica lontana che si diffonde dalle cuffie dell’iPod che mio figlio non ha saputo spegnere prima di addormentarsi. Così, perso per perso, accendo il televisore e lo lascio muto, come un colore di traverso. E ogni tanto sposto gli occhi. E mi sembra, nel fresco del mattino, di poter vivere in pochi istanti il senso del nostro tempo. La meravigliosa possibilità dell’alba, i suoi colori che annunciano, prevedono, ingannano. Il senso lieve di un tempo come speranza. Poi quelle tinte di traverso, forti come un grido. Non ho bisogno delle parole della tv che è, comunque, muta. Vedo il rosso del sangue e quell’impiastro di colori che sono le carcasse delle auto esplose. Vedo il blu diventato grigio del mare che si riduce a onda, enorme onda. Vedo il celeste pacchiano dei costumi ridotti di ballerine che non ballano.
Quale è la realtà? Ciò che viene prima come l’alba o ciò che viene dopo come la televisione? È una stagione difficile per me, perché sono insieme alba e tramonto, speranza e delusione. Perché il tempo mi sfugge e mi sembra, riguardandola, che la mia vita sia stata giusta ma piccola. Che la mia alba e il mondo che essa rischiara avrebbero meritato di più da uno come me.
Da anni, all’Archivio di Stato, mi occupo di raccogliere, catalogare, leggere e riassumere i diari che i miei contemporanei non smettono di scrivere. Piccole opere, stampate spesso a spese degli stessi autori, nelle quali ciascuno, arrivato a una stazione della vita, sente il bisogno di raccontare al mondo la sua esistenza. Di renderla, così, eterna. Di farla grande perché è la carta, che resiste al tempo, che fa divenire quella vita unica. Non un elenco di giorni dimenticabili ma una sequenza di eventi serrati. Forse veri, forse falsi. Forse illusioni di ricordo, forti come una memoria autentica. Costruzioni della volontà, rimpianti di quello che si sarebbe potuto fare trasformati in ciò che si è fatto. Sono storie di piccoli eroi, di illusioni perdute, di sogni inseguiti inutilmente. Sono storie di mogli e commilitoni, di figli e di capuffici, di amici perduti sempre troppo presto, di animali fedeli e di fotografie indispensabili. Sono storie piccole nella grande storia. È questo che mi piaceva, quando ho iniziato. Vivere molte vite. Vite vere, non inventate come quelle dei romanzi. Ho letto migliaia di diari, ho conosciuto migliaia di persone, ho sofferto e gioito con loro. Sono stato padre, figlio, compagno di battaglia, vicino di banco, passeggero di treno, artista del circo, macchinista, atleta e martire. Ho vissuto migliaia di vite, cercando la mia. In quelle pagine lette in solitudine nella mia stanza sentendo musica da pianoforte, lieve lieve, ho anche cercato conforto e risposte. Ho cercato i precedenti della mia vita, le albe a rovescio. In quelle migliaia di piccoli, poveri libri divisi per stagione storica, per tema, per area geografica ho trovato le pagine che potevano parlare e consigliare la mia esistenza quando la terra tremava e io non trovavo appoggi.
Nel diario di una madre, classificato alla voce «disagi», c’è il racconto dettagliato del giorno preciso in cui la sua vita tremò e le sue certezze si fecero coriandoli. Nelle parole di quella donna sconosciuta e insieme così prossima ho cercato risposte al sisma mio. La signora partorì un bambino alla metà degli anni Sessanta. Lo aveva atteso come ciò che avrebbe dato alla sua vita un senso vero, grande. Come ciò che le avrebbe fatto pensare di vivere e non solo di attraversare il tempo. Ma Andrea, suo figlio, aveva qualcosa che non andava. I medici facevano fatica a spegnerle il sorriso dalle labbra, a convincerla a credere che avrebbe avuto una vita diversa da quella che aveva immaginato nei nove mesi, e prima, e ora. Si chiama sindrome di Down ed è una condizione, forse più che una malattia. Nel suo diario la signora raccontava, per pagine e pagine, la storia del suo amore speciale per Andrea. Descriveva con sincerità la rabbia e la malinconia, le umiliazioni e le angosce vissute al parco, nei giochi dei bambini, nella scuola, nello sport. Andrea era maltrattato da innocenti, i suoi coetanei. Fuggivano da lui, non lo capivano. E Andrea si sentiva sempre più isolato. Crescendo era sempre più tenero e malinconico. Non usciva mai da solo.
In un pomeriggio d’estate, avrà avuto quattordici anni, aspettò che i suoi genitori dormissero. Scivolò verso la porta e se la chiuse dietro. Si sentiva padrone del mondo. Chiamò l’ascensore e si rannicchiò in modo che nessuno potesse vederlo e avvertire la madre. Uscì dal portone e si avviò verso il parco. Era contento, libero e salutava tutti per strada. Girò per la villa comunale, si infilò negli edifici, guardò i suoi coetanei che giocavano a pallone e fece il tifo scegliendo a caso. Si comprò un cremino e si mise su una panchina. Era il tramonto e lui aspettava, felice. Non sapeva cosa, o forse sì. Avvertì da lontano dei colori confusi che correvano verso di lui. Non sentiva le grida che uscivano da quella bocca aperta che ora vedeva e riconosceva, familiare. La sua attenzione era concentrata sul suono dell’acqua della fontanella che era vicino a lui. La guardava e sorrideva e si sentiva grande e padrone dei suoi suoni.
Stella, la mia Stella, non so quando mai potrà diventare padrona dei suoni. So che ora, che ha dodici anni, mi sembra l’origine del mondo. Mi sembra la vita umana ricondotta a essenza e purezza. È generosa e ama il prossimo. Abbraccia chiunque, non immagina e non capisce che qualcuno possa fare male a un altro. Le appare insensato, inutile, tempo perso.
Quando è nata, mia moglie aveva quarant’anni e, ho scoperto poi, l’incidenza dell’età sui parti di bambini down è molto forte. Una donna che ha meno di venticinque anni ha una probabilità su 1376, una di quaranta ne ha una su 126. Quella gravidanza l’avevamo voluta insieme, cercata. Sapendo che poteva essere un modo per ritrovare sorriso e speranza, voglia di svegliarsi al mattino e di vivere insieme il futuro. E pensavamo che Lorenzo sarebbe stato contento di avere un fratello o una sorella a otto anni, che era l’ultimo tempo utile perché tra loro potesse stabilirsi una relazione viva.
Ma quando portarono Stella a Giulia per l’allattamento vidi che lei la guardava in modo strano. Che il sorriso con il quale accompagnava le sue mani che toccavano leggere il nasino, le orecchie, il pancino non era sereno, limpido. Andavo e venivo dall’ospedale e non mi sembrava che Stella avesse nulla di diverso da quello che vedevo sul volto degli altri bambini che sgambettavano nel nido. Ma io sono padre, non capisco. Un mattino entrai nella sua stanza e trovai Giulia che piangeva con il volto schiacciato contro il cuscino. Si interruppe e mi guardò con gli occhi bagnati. Restammo in silenzio così qualche istante, con la paura di parlarci. «Stella è una bambina down» mi disse piano. Mi sedetti sul letto, le presi la mano. Pensai a Lorenzo che aspettava a casa festoso. Pensai ai nonni, agli amici. Pensai agli anni di fronte a noi. Pensai che una gioia infinita poteva diventare un’ansia infinita. Pensai a Stella nella sua culla con il fiocco rosa già diversa, inconsapevolmente diversa, da tutti quelli che le frignavano attorno.
Guardai Giulia e mi resi conto che aveva paura per me. Una madre non può fuggire da suo figlio, un padre sì. E lo hanno fatto in tanti. Gli uomini hanno paura dei dolori degli altri. Ne conosco molti che hanno lasciato la moglie dopo che si era ammalata o altri che non hanno retto a figli difficili. Il dolore fa paura agli uomini, li costringe a non essere soli al comando. Aveva ragione, Giulia, ad avere paura per me.
Quando uscii dalla sua stanza, mi fermai davanti al nido. Era sera, ormai. Date le circostanze ci avevano concesso di stare insieme più a lungo degli altri. Andai di fronte alla grande finestra dietro la quale i bambini dormivano e cercai con lo sguardo la mia piccola Stella. Ora vedevo ciò che non avevo visto. E forse anche ciò che non si vedeva davvero. Gli occhi, quel taglio degli occhi, e il nasino, a patata. Appoggiai una mano al vetro e piano piano scivolai fino a sedermi a terra, con le spalle contro la parete del nido. Il corridoio era vuoto, c’era penombra. Potevo piangere, liberamente, con la schiena rivolta a Stella. Che lei non vedesse me, e io non vedessi lei.
Sono passati dodici anni da quei giorni. E io mi sono innamorato di quella creatura fragile. E ogni alba, guardando il sole che comincia, penso a lei. Penso al momento in cui la sveglierò e all’abbraccio forte che mi darà. Penso al tragitto che faremo insieme, lei seduta in macchina vicino a me. Non sento, se ci penso, le parole che ci diciamo, ma vedo le sue espressioni. E mi sembrano la continuazione dell’alba.
Mia moglie va a lavorare dopo di noi e se la prende comoda. È molto concentrata sulla sua carriera e sembra distratta, assente. Non tollera nulla dei vent’anni di Lorenzo, non sa far altro che trattare Stella come un piccolo animale indifeso. Parliamo poco, noi due. Non abbiamo molto da dirci. Di quello che succede nel suo lavoro, di quante case abbia venduto oggi, di quali elogi le abbiano fatto, di come siano cresciute le azioni dell’immobiliare, a me non importa assolutamente nulla. Delle vite che incontro nei diari non le parlo neppure. Non sembra interessata alla sua, di vita, o alla nostra, figurarsi a quella degli altri.
C’è molto silenzio in casa, la sera. Giulia è davanti al computer, Stella disegna nella sua stanza e Lorenzo fa rimbalzare il pallone contro il canestro che ha montato sopra la porta della camera. Ha poche passioni quel ragazzo: la sorella, Italo Calvino, Michael Jordan. Una la accudisce, l’altro lo studia, il terzo lo venera.
In una delle ville della nostra città c’è una cascata. D’estate è bello andarci, gli schizzi ti rinfrescano e i bambini si divertono ad avvicinarsi e allontanarsi. Era il posto preferito di Lorenzo al tempo in cui Stella nacque. È lì che glielo dissi. Aveva otto anni ma è sempre stato un bambino saggio, equilibrato. I suoi grandi occhi cercavano le cose da capire, la sua testa era un magazzino di perché, ogni ragione rivelata delle cose non gli bastava. Sembrava assetato di senso.
Proprio la ricerca del senso, l’elogio del dubbio, il meraviglioso fascino della ricerca mi avevano catturato nelle pagine di uno dei miei diari. L’autore era un matematico, cresciuto alla scuola di Renato Caccioppoli. Aveva convissuto con i numeri e con l’inquietudine febbrile della scoperta degli infiniti. Gli astronomi li frequentano, li cercano, li studiano. I filosofi li immaginano, li raccontano, li inventano. I matematici li rendono viv...