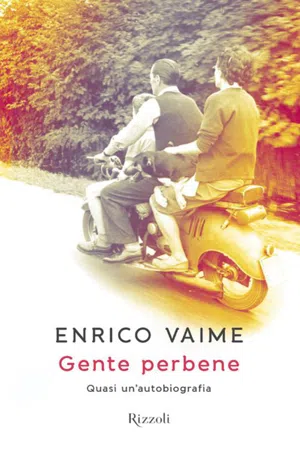![]()
1
La guerra è passata
Mio padre era un bell’uomo. Credo.
Adesso è difficile sostenerlo con certezza: il tempo ha modificato molti canoni estetici e quello che può risultare dal ricordo o dalla visione di vecchie foto deve essere vagliato con lucido distacco critico.
A me sembrava bello. E trovavo elegante il suo modo di porgersi agli altri, quel guardare in faccia il prossimo con attenzione atteggiando al contempo il viso a una rassicurante disponibilità, la testa leggermente piegata da un lato, un accenno di sorriso sulle labbra che si muovevano ripetendo silenziosamente le parole anche usuali rivoltegli da qualsiasi pur irrilevante interlocutore.
Si creava un’atmosfera di cordialità e benevolenza incontrandolo: ci si disponeva favorevolmente a quell’intesa anche mimicamente richiesta. Questo modo di approcciarsi era suggerito (noi lo sapevamo) da ragioni tecniche: papà aveva un udito debole, una leggera forma di sordità che richiedeva aiuto nell’avvicinarsi alla fonte sonora il più possibile e nella decrittazione dei movimenti labiali del prossimo.
Non era sordo: solo un po’ e non sempre. Anche se mia madre, durante certi momenti di tensione (ce ne sono in tutte le famiglie, diamine), faceva riferimento a quel piccolo handicap esagerandone la gravità o mettendone polemicamente in dubbio l’esistenza («E non fare finta di non sentire!»). Su questa frase papà se ne usciva con una battuta ironica che divertiva solo me.
«Che hai detto? Non ho capito!» rispondeva alzando il tono della voce.
Mio padre era spiritoso. Credo.
Anche qui può sorgere qualche dubbio sulla obiettività di questa osservazione: il fascino del ruolo di capofamiglia, può influenzare i giudizi. Così come l’affetto che un figlio riserva al proprio genitore, per un’infinità di ragioni tutte condivisibili, può suggerire assoluzioni o plausi eccessivi. Mio padre mi andava bene com’era. E la montagna di difetti che mia madre a volte elencava, attribuendoglieli nei momenti di dissenso, non riuscivo a rilevarla. Se c’erano, poi. Chissà. E (questo ho avuto la forza di ammetterlo piuttosto presto nell’adolescenza) mi turbavo quando mamma, all’acme di qualche sfogo d’ira, rifaceva il verso a papà: ripeteva la sua ultima frase, storcendo esageratamente la testa come lui era solito fare (con una sua grazia, però). E muoveva vistosamente le labbra nella parodia di quella sorta di doppiaggio del sonoro altrui sul quale lui aveva qualche (piccola) difficoltà di ricezione. Poi ripeteva con scherno l’ultima frase detta dal marito, esagerando il frullio delle erre che papà pronunciava arrotandole un po’.
Lo facevo anch’io parlando, senza accorgermene: non era una erre francese. Né moscia. Era una sorta di piccolo frullo che avvertivano solo i più ricettivi o maldisposti.
Per quello che mi riguarda, non fu mai un problema vero quel piccolissimo e non sempre riscontrabile difetto di pronuncia. Quando per esempio la parola iniziava con quella lettera, allora la dizione risentiva di quel vezzo (o difetto) e la erre frullava un po’. Quando invece la erre era nel corpo di un termine, superavo la prova di dizione corretta senza sforzo.
Quando lo spiegavo a qualche amichetto malizioso usavo un esempio efficace. Chiarivo come avessi qualche difficoltà nel dire «rompicoglioni». Ma me la cavavo in scioltezza con «stronzo».
Ero quel che si diceva un ragazzo sveglio. Credo.
Nonostante una certa timidezza che a volte mi costringeva a presentarmi con discrezione, da molti confusa con una totale disponibilità – quasi remissione – verso il mondo, che però non sentivo in effetti di avere. Non ero, come credo i più pensassero, un tipo che sapendo stare al posto suo risultava facile da trattare, anzi da gestire.
Accumulavo (ora, a distanza di tempo posso dirlo) esperienze e opinioni che prima o poi avrei sfruttato in una vita che immaginavo serena (se mi passate un termine così generico e banale).
Perché il peggio stava passando. E, in un certo senso, passò.
La guerra era da poco finita: si trattava di rimuovere le macerie e ricostruire. Stavolta senza commettere gli errori di un periodo storico che ancora stavamo cercando di comprendere: come era potuto succedere quello che era successo? E dov’erano finiti i colpevoli? E quanti erano, se c’erano? E gli altri, quelli che s’erano trovati a subire: tutte vittime innocenti?
Avevo curiosità e dubbi che cercai di placare nel tempo. Ne parleremo perché questa storia comincia lì, in quegli anni Quaranta e spicci che chiusero un’epoca e ne aprirono un’altra: quella che stiamo ancora vivendo.
Ero insomma quel che si diceva, ribadisco, un bravoragazzo.
Questo giudizio preventivo sul quale alcuni potrebbero eccepire (io per primo) era influenzato dall’aspetto: il mio aspetto. Che non mi è mai piaciuto. L’aspetto da bravoragazzo era per certi versi depistante. I colori tenui sono ingannevoli: i biondi con gli occhi chiari non è detto che siano tutti angelici. O delicati dentro come lo sembrano fuori.
Non mi piaceva essere biondo. Intimamente ero (mi sentivo) moro.
Ero un ragazzo educato, certo. Somigliavo alla mamma. D’aspetto.
Non vorrei si pensasse che non fossi legato a mia madre, una signora solare che chiunque ha sempre trovato gradevole e vitale. Certo, in casa, nella quotidianità, vengono fuori i difetti e le intolleranze. L’intimità rivela, di solito, il peggio di ognuno. Ma l’intimità ha anche una sua zona di tenerezza e di calore. Io ricordo ancora certi momenti. Quando per esempio partivo anche per poco e salutavo i miei. L’abbraccio esuberante di mamma, la vicinanza del suo corpo nell’effusione: aveva un buon odore di mandorla. Un ricordo preciso. Come la frase (sempre quella) di papà: «Mi raccomando» diceva nei distacchi, con la erre che frullava più del solito, forse per l’emozione.
E si girava in fretta dall’altra parte perché aveva paura di scoppiare a piangere. Credo.
Anche a me succedeva, a volte. I mori (naturali o criptici) sono fatti così. Hanno le lacrime in saccoccia, come si dice dalle nostre parti.
«Saccoccia» è una parola povera, un termine popolaresco che sta per tasca. Più adatto ai meno abbienti. Nella tasca ci sono documenti e danaro. Nella saccoccia, spicci e avanzi. E lacrime.
Da noi si parla una lingua non troppo influenzata dal dialetto. Non particolarmente elegante, ma neanche così rozza o volgare. O spocchiosa come succede altrove, dove si ha la pretesa di avere inventato (addirittura!) l’italiano. O di averlo migliorato. E non pensate solo ai fiorentini che hanno questa fissa dell’italiano che è diventata lingua grazie a loro. Dante era bravo, certo. E non si discute. Per quanto …
La Comedìa è troppo lunga. E ci sono anche dei momenti mortiferi. Qualcuno dovrà dirlo prima o poi: è lunga! E piena di toscani per lo più rompicoglioni: troppi.
Comunque, certo, molto dobbiamo al Poeta, sul piano della comunicazione e della forma. Ma non voglio imbarcarmi in discorsi che pretendono una cultura ben più completa e profonda della mia, ragazzo educato, ma di provincia. Nel senso buono. Ma anche no. Quanto alla lingua che a volte uso spregiudicatamente, di solito è accettata perché, a parte qualche insopprimibile vezzo lessicale, cerca di essere corretta. Non sopporto quanti si appoggiano a dialetti e cadenze per rafforzare concetti che abbisognerebbero della logica, non del colore. Certi mezzucci retorici che spingono all’uso di localismi gergali suggestivi mi ripugnano. Mi fanno venire le buggere, le paturnie, le giavernie, le fregne (in italiano: mi innervosiscono).
Sono partito da un tempo lontano in cui tutto era diverso. Anche il modo di parlare. Anche noi. Diversi nell’aspetto persino. Guardavamo con occhi ancora increduli come la vita – che solo un paio di anni prima sembrava essere arrivata a una sinistra conclusione – non si fosse fermata. Anche se s’erano fatte le prove generali della fine del mondo, eravamo arrivati al 1945.
Tutti ricordavano ancora molto, se non tutto, di quello che era successo: gli anni della paura, quella guerra che dalle mie parti era arrivata con strana lentezza. Mentre tutto crollava sotto le bombe, da noi non erano tanto le esplosioni a sconvolgere una vita fatta di stenti e attesa del peggio (che, anche quando non arriva, di danni ne fa tanti ugualmente in chi comunque l’aspetta). Una strana paura c’era rimasta dentro amplificata da un senso di impotenza e fragilità, un’incapacità di reazione che avrebbe richiesto un controllo dei nervi che nessuno sembrava avere più. Si andava nel panico con facilità. Quando, per fare un esempio, a Liberazione avvenuta si festeggiò l’evento con dei fuochi d’artificio in piazza, dovettero interrompere la manifestazione perché, sugli scoppi di razzi e castagnole, i bambini s’erano messi a piangere, le donne svenivano, e tutti, pur tentando di dominarsi, cercarono istintivamente un riparo.
Io cercai con gli occhi mio padre. E lo vidi che sorreggeva la mamma, sconvolta in quell’atmosfera di psicosi collettiva. Rimasi dov’ero a guardare quel quadretto familiare che mi vedeva escluso. I bambini hanno uno strano modo di reagire a volte: guardavo i miei genitori preoccupati ognuno dell’altro (sembrava). E io?
Mi aggiunsi a loro che (seppure solo per un momento, d’accordo) m’avevano trascurato. Avvicinatomi, non ebbi l’accoglienza che avrei voluto. Il panico rilevatore di reazioni sopite ma non superate era passato. Tutti, mi sembrò, furono colti da un attimo di imbarazzo per quella reazione esagerata. E ognuno rientrò più in fretta possibile nel ruolo che giocava prima della inopinata manifestazione pirotecnica.
«Sono qui!» dissi avvicinandomi ai miei, col tono enfatico di una rivelazione destinata a sconvolgere.
«Hai perso il berretto» notò mia madre, preoccupandosi di un accessorio piuttosto che del resto (io!), la cui presenza si dava ormai per normale. Mi sarebbe piaciuto (me lo aspettavo!) un abbraccio, una carezza, anche una lacrima liberatoria, via.
«Eccolo, il berretto» dissi togliendomelo dalla tasca nella quale l’avevo infilato.
«Ah, meno male» disse la mamma rasserenandosi. Per il berretto, accidenti. Mi incupii.
C’eravamo, dopo un attimo di paura ingiustificata, ricompattati. C’era tutto, anche il berretto, la cui ipotizzata assenza aveva turbato mia madre, accidenti. Fu quella una delle prime volte (forse la prima?) in cui mi sentii come un elemento aggiunto a quel gruppo: può darsi che stia valorizzando troppo un dettaglio, che conceda all’episodio, apparentemente secondario, un’importanza esagerata. E va beh. Ma negli attimi (eterni) in cui con gli occhi avevo cercato mio padre e mia madre, avevo ricostruito la mia vita immaginando mentalmente di doverla affrontare di colpo da solo, senza quella signora solare che odorava di mandorla e quell’uomo gentile e disponibile, pronto a recepire, pur con qualche difficoltà, le chiacchiere di chiunque con un sorriso.
E avevo capito, nella innaturale velocità del flash, che senza di loro tutto avrebbe avuto un altro senso.
Mentre, tornando verso casa, cercavo di allontanare certi pensieri e ricacciare la lacrime che stavano per uscire dalla saccoccia, decisi (eppure ero poco più di un bambino) che mi sarei sforzato di perdere certe debolezze che mi facevano star male. Ipotizzai, senza riuscire a definirla compiutamente, una autonomia che avrei presto conquistato.
Prima di arrivare a casa buttai il berretto in un tombino.
![]()
2
Il Borgo Bello
La nostra casa mi sembrava bella. Per capire che era brutta ci vollero anni: col tempo ci si accorge che certe cose, che ci sembrano eleganti e originali, sono banali e pacchiane.
Fino alle medie guardai il barometro tirolese, con l’omino e la donnina che uscivano dalla casetta di legno con l’ombrellino a predire il maltempo, con sincera ammirazione. Poi negli anni quel prodotto artigianale mi apparve di un gusto così scadente che quando una pallonata lo demolì mi sentii sollevato e subii i rimproveri con la fermezza di chi sa di aver compiuto (con involontarietà discutibile) un gesto quasi doveroso. Sì, anche una tremenda ceramica rappresentante la testa della Fortuna bendata subì una sorte analoga. La colpa (o il merito?) venne attribuita a una cameriera.
Certo l’oggettistica di quegli anni contribuiva al depistaggio del gusto, confermando quella volgarità di fondo radicata (oggi lo è meno?) nel ceto medio: in un clima di precarietà si finisce per valorizzare e affezionarsi anche al mediocre o al peggio (che è meglio del niente, per alcuni).
Nel tempo si cambia. Per fortuna.
Quanta nostalgia, negli anni andati, per quei mobili del salotto che mi apparivano addirittura sontuosi: il buffet, il controbuffet, le poltrone Novecento coi braccioli di legno impellicciato, il puff, il regolamentare tavolinetto ottagonale sistemato al centro di quell’angolo considerato prezioso ed esclusivo e perciò poco frequentato. E sul tavolino ottagonale, un centrino fatto a uncinetto che debordava fuori dal mobile in una inutile cascata ricca di palline di cotone (che un gatto eliminò con felice intu...