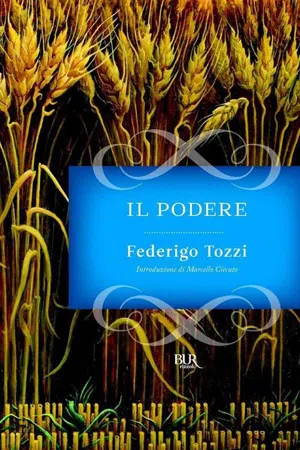
- 208 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il podere
Informazioni su questo libro
Tozzi mostra al meglio una generale condizione di squilibrio, talvolta anche patologico, che è la ferita inguaribile sopportata da ognuno, l'ossessione originaria dell'essere separato da cui già Baudelaire provò a evadere con tragica impotenza." – Marcello Ciccuto
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Print ISBN
9788817061506eBook ISBN
9788858640524INTRODUZIONE
Quasi a modificare per caso un assolutizzante e ben più atroce aforisma di belliana memoria, Ortega y Gasset riesce bene a condensare nell’« io sono io e la mia circostanza» quella situazione di sfiducia nella soggettività, nell’organicità della sfera personale che informa il crollo novecentesco della coscienza kantiana, fondata su rapporti lineari fra soggetto, oggetto e pensiero. L’espressione potrebbe peraltro piegarsi a illustrare fulmineamente anche il valore dei segni propri alla narrativa tozziana.
Perché, se il personaggio pirandelliano, tanto amato dal senese, «esprime come sua viva passione e tormento... l’inganno della comprensione reciproca fondata irrimediabilmente sulla vuota astrazione delle parole: la molteplice personalità d’ognuno secondo tutte le possibilità d’essere che si trovano in ciascuno di noi; e infine il tragico conflitto immanente tra la vita che di continuo si muove e cambia e la forma che la fissa immutabile» » (Maschere nude), a tale scambio fra realtà e finzione, che impedisce di acquistare la coscienza normale e personale delle cose, corrisponde in Tozzi un senso ancor più profondo di perdita dell’Essere, su cui è giocato tutto il linguaggio espressivo a grado zero delle ’bestie’dei suoi romanzi e racconti. Nell’ostentazione del valore relativo di ogni verità, l’ ’assenza’ di cui Remigio Selmi, Leopoldo Gradi, i fratelli Gambi sono i simboli espressivi diventa il vero dato di partenza per tutto un versante della produzione dello scrittore, o, se vogliamo, l’approdo di una lunga speculazione all’interno della coscienza: nel cosmo tozziano si rivela sin dagli inizi fallito il progetto di una concreta rappresentatività del reale da parte di chi non può più «stabilirsi un punto di vista fermo e incrollabile», e per parte sua la reazione dello scrittore si volge a un’idea ’organica’ del mondo e della scrittura che pretenderebbe di definirla. Di qui la ricerca di verità diverse, interiori, legate a una primitività istintiva che faccia saltare dalle fondamenta la corrispondenza romantico-analogica fra uomo e natura, e renda conto però nel contempo della non appartenenza dei personaggi tozziani all’ordine artificioso del reale, in una negazione continua della propria consistenza umana, di un concetto di individualità, o di ogni solida dimensione sociale e comunicativa:
«Questo senso dell’immediatezza [...] ci deve salvare a tutti i costi dal perder tempo innalzando piramidi di teoria e di propositi che noi non abbiamo. Non bisogna credere più che le stesse cause tornino a presentarsi più di una volta. Quella realtà ignota e indefinibile che noi chiamiamo tempo, è sempre diseguale; e ci invita a riflettere che le nostre responsabilità sono improrogabili e uniche. Bisogna mettere gli uomini nella condizione di attuare i propri stati d’animo, trasformandoli senz’altro in fatti compiuti. Perché un fatto da compiere, anche se noi possiamo descriverlo minutamente, è sempre una specie di interruzione e non mai un segno di intensità pura. Se invece, esaminiamo la storia interiore di noi stessi, bisogna convenire che il più delle volte è rimasta passiva e cieca [...] Noi abbiamo [...] scambiati i simboli della vita per la sostanza della vita; e ci siamo contentati di rifare più o meno volentieri la stessa strada degli altri (F. Tozzi, Le nostre ombre) ».
Sarebbe assai evidente, insomma, l’idea di un’usura che, nel caso della narrativa tozziana e de Il podere in particolare, le leggi della ’ragione economica’o il potere tout court (foraggiato dalla vita su cui grava) recherebbero all’individuo della nuova società borghese, costringendolo a negare se stesso, kafkianamente, nella inutilità più assoluta. Si dirà però, d’altro canto, di come Tozzi esempli al meglio una più generale condizione di squilibrio, talvolta anche patologico, che è la ferita inguaribile sopportata da ognuno, l’ossessione originaria dell’essere separato da cui già Baudelaire provò ad evadere con tragica impotenza. E si parlerà allora di malattia, non nel senso proprio manniano, valido per i Leverkhün o i Castorp, e neppure nell’ampiezza teoretica dell’accezione sveviana; piuttosto di una malattia organizzata, nei profondi strati metaforici, sul tema dei rapporti difficili, tesi, problematici fra pensiero e vita, unici forse a consentire, nello squilibrio sistematico dell’esperienza psicologica, la percezione del mistero funebre e sacro della vita stessa (contro una ’salute’ per la quale coscienza e realtà fisica appaiono in rapporto di insignificante reflet).
Solo in questa prospettiva si giustifica, credo, e si comprende a pieno l’alienazione apparentemente assurda e la fine tragica dei personaggi tozziani. Nel caso di Remigio Selmi, ne Il podere, assistiamo senz’altro ad un inesorabile processo di colpevolizzazione, come ha indicato Maxia; ma soprattutto, aggiungeremmo, alla mise en abîme di una crisi a priori, segnalata sin dall’inizio da una doppia espropriazione del protagonista, stretto fra la violenza della morte del padre e l’imposizione, ingrata, dell’eredità. In questa degradazione improvvisa dei punti di riferimento (tra due morti o assenze si esaurisce poi la vicenda del romanzo) è il peccato d’origine del personaggio, la cronica inabilità del soggetto alla vita ’normale’, la malattia della cecità. Inutile apparirà per questo il tentativo di Remigio di adeguarsi alla logica della comunità contadina, storicamente aggregata a confusione dei ruoli, debole divisione del lavoro, solidarietà meccaniche, staticità, impermeabilità ad influenze esterne, per definizione quindi adatta a incrementare una condizione già schizofrenica per il novello proprietario (in altri termini la «confusione dei messaggi, [l’] incapacità di contestualizzare e quindi d’interpretare il senso di un messaggio comunicativo » ben illustrate dal Gioanola): soprattutto se tale tentativo assume l’aspetto di un’evasione o di un rifugio coatto nell’allucinazione, che da sempre altera la percezione corretta nel prevalere dell’apparente. Tozzi insiste su questo dato, se è vero che si sottolinea, alle proiezioni idilliche cui si abbandona il Selmi all’inizio del romanzo («Giacomo era già in agonia ... Da tutte e due le finestre aperte, l’aria odorosa della primavera entrava nella camera. Le anatre schiamazzavano, sguazzando nel fango del fontone; e le galline, che nessuno s’era ricordato di governare, crocchiolavano forte. Un lungo suono di campane scivolava per il cielo; da Siena alta, giù verso la Val d’Arbia. Un mucchio enorme di nuvolette rosse si radunò sopra i pioppi della Tressa, come richiamato da quel suono... » p. 15), la dura opposizione di una natura tutt’altro che materna (« Le falci tutte insieme luccicavano tra gli steli del grano; con un rumore simile a uno strappo rapido. Urtavano, talvolta, sopra un sasso con un suono languido e smorzato. S’insinuavano curve tra le spighe; e le spighe sbattevano sopra i volti; qualche stelo s’insanguinava dopo aver fatto un taglio o una scorticatura. Allora il contadino, senza schiudere il pugno pieno di mèsse, si guardava un istante; poi la falce s’affondava ancora, lucida e affilata. Dietro gli uomini, gl’insetti disturbati saltellavano insieme da tutte le parti, verdi, neri o grigi; mentre certi ragni dalle zampe lunghissime ed esili percorrevano i solchi, sparendo nell’ombra di una fenditura, ricomparendo subito in cima a qualche zolla. Le lucertole scappavano sempre innanzi; qualche ramarro osava indugiare, ma, poi, spariva anche più rapido... », p. 92); anzi brutale e minacciosa, capace com’è di respingere l’intruso o di ’invaderlo’, addirittura, a seconda che si intenda distruggere ogni dolcezza regressiva («Ormai trovavasi di fronte alle cose, come una inimicizia. Anche il suo podere era un nemico; e sentiva che perfino le viti e il grano si farebbero amare soltanto se egli impedisse a qualunque altro di diventarne il proprietario. La casa stessa gli era ostile: bastava guardare gli spigoli delle cantonate. Se non aveva l’animo di distruggerla e di ricostruirla, anche la casa non ce lo voleva. Da tutto, la dolcezza era sparita», p. 142; e nel ritmo quasi meccanico del romanzo, al tanto ricercato blessed mood subentra, come l’epilessia dostoewskijana all’aura estatica, la coscienza dell’imprescindibile caduta: «Una grande tristezza lo invase, sentendo confusamente quanta ambiguità gli era attorno, e come, tra qualche giorno soltanto, egli si sarebbe trovato a contrasti violenti e insoliti», p. 10), o, infine e più radicalmente, far sì che l’uomo perda i limiti di sé sino a far tutt’uno con quanto vorrebbe dominare («Allora Remigio si sentì pieno d’ombra come la campagna. Guardò il podere, giù lungo la Tressa; e dov’era già buio. E gli parve che la morte fosse lì; che poteva venire fino a lui, come il vento che faceva cigolare i cipressi », pp. 72-73).
Restano alcune ’evasioni’ per il protagonista, inadeguate certo a imporre una qualsiasi volontà (è il caso esemplare e angosciante nella sua nettezza di p. 110) ma più che sufficienti a illuminarne la totale paralisi («Tutta la vita sembrava chiusa dentro un sacco, da cui non c’era modo di mettere fuori la testa »).
Così, nella ricerca di un adattamento incongruo alla complessità imperscrutabile della vita, Remigio è condannato alla follia dell’inconsistenza, tradotta a livello di scrittura nello sconvolgimento della lineare gerarchia narrativa, a tutto favore di prelievi verticali, momentanei, perfetti direi, vocianamente parlando, nel rendere il vagare dei personaggi «nell’estremità bizzarre del destino ».
E sarà proprio la forma di questa sostanziale perplessità emotiva, con il richiamo ai drammi dell’esistenza quotidiana, con il senso di un rapporto sempre più astratto fra parole e cose, a ergersi a denuncia notevolissima di una crisi esistenziale e storica, sulla linea maestra di un Giovanni Verga impegnato a individuare «la mancanza di significato della vita nel tempo e nello spazio e quindi la solitudine dell’uomo» (Bigazzi). E la coscienza novecentesca sarà in debito verso Tozzi per l’indicazione modernissima e pressoché sistematica dell’incubo quale obiettivo obbligato de...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Il podere