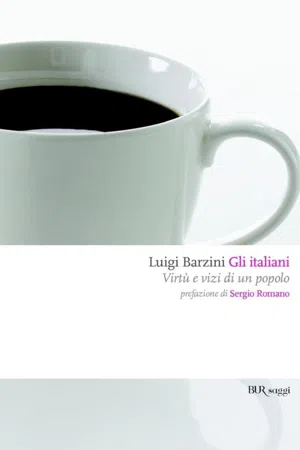![]()
PREFAZIONE
La prima edizione di questo libro apparve a New York nel 1964, ebbe subito molto successo e rimase per quasi un anno nella lista dei libri maggiormente venduti. Il merito, ovviamente, fu soprattutto dell’autore. Ma per comprendere l’accoglienza degli americani al saggio di Luigi Barzini sui vizi e le virtù dei suoi compatrioti, occorre ricordare che l’Italia, in quel momento era «di moda». Ci eravamo rialzati dalla disfatta, avevamo ricominciato a lavorare con successo, eravamo stati protagonisti di un «miracolo economico», avevamo una lira fermamente ancorata al dollaro che aveva ottenuto, qualche anno prima, un «Oscar» per la sua stabilità. Il regime politico italiano ispirava fiducia. La nuova classe dirigente aveva cambiato la forma dello Stato, adottato una nuova costituzione, tenuto a bada i comunisti, sottoscritto trattati che conferivano all’Italia un posto rispettabile fra le grandi democrazie. Negli anni immediatamente precedenti la pubblicazione del libro di Barzini vi era stata una «svolta a sinistra», di cui l’autore diffidava. Ma a molti uomini politici stranieri, fra cui il presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy, quella svolta parve necessaria per il consolidamento del sistema democratico italiano.
Non basta. Il paese sembrava attraversare un nuovo rinascimento. I registi cinematografici italiani avevano creato un nuovo stile e i registi americani usavano le risorse artigianali di Cinecittà per le produzioni colossali di Hollywood. Il mondo conosceva e apprezzava la letteratura, il teatro, la moda, le automobili, le motociclette, le macchine per scrivere e il design industriale degli italiani. Risale all’inizio degli anni Sessanta una collana interamente italiana della Oxfrod University Press in cui apparvero, con alcune grandi opere (Dante, Machiavelli, Guicciardini, Alfieri, Leopardi), molti classici minori: Gozzi, Pellico, Fogazzaro, Goldoni, Abba, i racconti dell’Ottocento, Pirandello. Esisteva una scienza italiana, particolarmente attiva in alcuni settori: chimica, fisica, tecnica delle costruzioni. La vecchia scuola di Enrico Fermi in via Panisperna era ancora uno straordinario vivaio di talenti e ricerche. Il Cnen (Comitato nazionale per l’energia nucleare) intendeva costruire una rete di centrali che avrebbe garantito l’autosufficienza energetica del paese. Nel dicembre del 1963 Giulio Natta ricevette il premio Nobel per le sue ricerche sul propilene isottatico. Nello stesso periodo Pier Luigi Nervi aveva appena terminato il Palazzo del Lavoro a Torino e si apprestava a realizzare la stazione per autolinee al ponte George Washington di New York. Ditte italiane cominciarono in quegli anni la costruzione di alcune fra le più grandi dighe del mondo, soprattutto in America Latina e in Asia. Quando un editore americano chiese a Luigi Barzini di scrivere un libro sul suo paese, l’immagine dell’Italia era complessivamente positiva e l’«Italian way of life» suscitava simpatie internazionali.
Fra i giornalisti e gli scrittori italiani, Barzini era probabilmente il più adatto all’incarico, l’unico che avesse la doppia formazione culturale e fosse perfettamente capace di «tradurre» l’Italia in concetti e immagini comprensibili al di là dell’Atlantico. Era nato a Milano nel 1908 da uno dei maggiori giornalisti italiani del primo Novecento. «Quando venni al mondo» scrisse in un libro, O America, apparso nel 1977 «mio padre era in servizio nel Nord Europa. Era il 21 dicembre del 1908. Sette giorni dopo ci fu il terremoto di Messina e Luigi Albertini ordinò a papà di sospendere l’inchiesta in Svezia e di precipitarsi in Sicilia. Non ebbe neppure il tempo di fermarsi a Milano, dove io vagivo in culla. Mia madre mi portò in braccio alla stazione perché potesse vedermi. Lui disse: "Lo battezzeremo al mio ritorno". Bene. Fui battezzato un anno e cinque mesi dopo, in Sant’Ambrogio.»
Il vecchio Barzini – Luigi, come il figlio – fu per molti anni il principe dei giornalisti italiani. Arrivò a Pechino subito dopo la rivolta dei boxer, fu in Manciuria all’epoca della guerra russo-giapponese, in Tripolitania durante il conflitto italo-turco, sul fronte veneto durante la prima guerra mondiale e a Parigi per i negoziati di pace. Ma nella seconda metà degli anni Venti decise di fondare e dirigere un quotidiano italiano a New York. Cominciò così l’educazione americana del figlio. Mentre il padre veniva dalla gavetta ed era giunto al «Corriere della Sera» dopo aver fatto le sue prime armi nel «Fanfulla» (un quotidiano fondato a Firenze nel 1870), Luigi il giovane volle diplomarsi in giornalismo alla Columbia University. Imparò a scrivere come i reporter americani: un rapido sunto dell’avvenimento nel primo paragrafo (il «lead»), il resoconto puntuale della vicenda, le dichiarazioni dei testimoni fra virgolette, un titolo asciutto e descrittivo. Quando divenne redattore del «Corriere» nel 1931 dovette disimparare quasi tutto ciò che aveva appreso alla Columbia University per adottare lo stile più letterario e fantasioso del giornalismo italiano. Non gli fu difficile. Ma conservò comunque sempre il gusto dell’informazione e una particolare sensibilità per la descrizione dei fatti; e lo dimostrò molti anni dopo descrivendo per il «Corriere della Sera» l’infarto da cui era stato colpito.
L’Italia ebbe così, dalla prima metà degli anni Trenta, due «Luigi Barzini», divisi da un «jr.» che il giovane aggiunse al proprio nome per distinguersi dal vecchio e rendergli omaggio. Si diceva in quegli anni: «I due Barzini si vogliono molto bene e si stimano molto: ciascuno pensa che l’altro sia il secondo giornalista d’Italia». Mentre «senior» dirigeva «Il Mattino» di Napoli, diventava senatore del Regno e aspirava all’Accademia d’Italia, «junior» faceva ciò che il padre aveva fatto negli anni della sua giovinezza. Fu corrispondente da Londra, inviato speciale in Etiopia nel 1935 e in Cina durante l’invasione giapponese del 1937, osservatore di tutti gli avvenimenti internazionali che procedettero lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Come tutti i grandi giornalisti costruì il proprio personaggio: gli abiti di taglio inglese, l’equitazione, la pipa, il gusto dell’ironia e del paradosso, una certa predilezione per la buona società. Poche persone ebbero come Barzini jr. il dono di affascinare egualmente gli uomini e le donne. Fu fascista come il padre? Era troppo intelligente, informato ed esperto di cose straniere per non sapere che il regime, dopo il patto d’acciaio con la Germania nazista, si era messo su una brutta china. L’esperienza americana lo convinse che gli Stati Uniti, se mai avessero deciso d’intervenire, avrebbero vinto la guerra. Nel 1940 lo disse privatamente, lo lasciò capire nei suoi articoli e si tirò addosso, con la collera di Mussolini, una condanna al confino.
Terminata la guerra fondò un giornale («Il Globo»), diresse un settimanale («La Settimana Incom»), tornò al «Corriere della Sera» e si lasciò sedurre dalla carriera politica. La sua linea era quella atlantica e liberale dei libri che aveva pubblicato negli anni precedenti: Gli americani sono soli al mondo, I comunisti non hanno vinto, Mosca, Mosca. Candidato del Partito liberale italiano, fu deputato per tre legislature del 1958 al 1972. The Italians fu scritto nel mezzo della carriera parlamentare dell’autore e riflette indirettamente, come vedremo, la sua esperienza politica.
«Inviato speciale» nel paese in cui era nato e aveva vissuto la maggior parte della sua vita, Barzini decise di scrivere un saggio in cui avrebbe raccolto, con molta libertà, il frutto delle sue letture e delle sue esperienze. Avrebbe parlato di storia, geografia, arte, gastronomia, amori, tradimenti, delitti, costumi morali e sociali. Anziché scrivere un libro fiducioso e ottimista in cui segnalare gli evidenti progressi che il paese aveva fatto nei vent’anni passati dalla fine della guerra, preferì insistere su alcuni caratteri e comportamenti che avevano contraddistinto i suoi connazionali nel corso della loro storia: la scaltrezza, il realismo, il cinismo, la diffidenza, il pessimismo, l’innato buon senso, la straordinaria intuizione dei suoi geni, la coraggiosa solitudine dei suoi eroi, la sobrietà del suo popolo, la sensibilità artistica dei suoi pittori e scultori. Anziché parlare dell’Italia come di un problema politico, economico e sociale, la descrisse come un’opera d’arte e cercò di spiegare le ragioni per cui questo «capolavoro» non sarebbe mai diventato uno Stato, una compiuta società civile, una rispettabile potenza internazionale. Anziché respingere le accuse e i giudizi dei viaggiatori del nord ne adottò spavaldamente il punto di vista sino a esasperarlo e trasformò i vizi degli italiani in altrettante virtù. Le bugie, gli intrighi, i complotti, le società segrete e il «familismo amorale» divennero nel libro di Barzini i necessari ingredienti di uno straordinario «Grand Tour» senza itinerario attraverso la storia d’Italia. È questa la ragione per cui accanto agli italiani come protagonisti di un’opera d’arte Barzini collocò gli stranieri, vale a dire costoro che da questa opera d’arte furono attratti, sedotti, irritati o disgustati. Lungo tutto il libro italiani e stranieri si guardano, si scrutano, si amano e si disprezzano.
I modelli a cui Barzini fece implicito riferimento sono La civiltà del Rinascimento in Italia di Jacob Burckhardt e Il Rinascimento in Italia di John Addington Symonds. Ma piuttosto che addentrarsi in dotte analisi storiche e politiche preferì raccontare tragiche battaglie, episodi minori, aneddoti rivelatori, e soprattutto disseminare nel libro una serie di «vite parallele», accomunate dalle analogie o dai contrasti; Cola di Rienzo e Mussolini, sir John Hawkwood e Lord Byron, Guicciardini e Machiavelli, Carlo VIII e Napoleone, Cagliostro e Casanova, Winckelmann e il cardinale Albani, Vittorio Emanuele II e Cavour, il barone Ricasoli e don Vito Cascio Ferro, «forse il più grande capo che la mafia abbia mai avuto». Il risultato è un libro in cui convivono tutti i generi della grande pittura. I mercati sovraccarichi di verdure e le vetrine dei negozi sono le nature morte di un pittore fiammingo, la battaglia di Fornovo è un affresco alla maniera di Paolo Uccello, le scene di genere sono dipinte nello stile dei bamboccianti italiani o olandesi, i ritratti e i medaglioni sono maestosi come quelli di Tiziano o sottili come quelli di fra’ Galgario, i personaggi minori (burocrati, industriali, finanzieri, mafiosi) sembrano usciti da un album di Daumier o di Gavarni.
The Italians è quindi anzitutto un saggio, destinato a sopravvivere per la fantasia, l’intuito e le qualità letterarie dell’autore. Ma è inevitabile che il lettore, a più di trent’anni dalla sua prima pubblicazione, voglia applicare il libro alla prova del tempo e si chieda fino a che punto il ritratto disegnato da Luigi Barzini nel 1964 assomigli all’Italia degli anni Novanta. In altre parole: che libro avrebbe scritto Barzini se l’editore americano gli avesse chiesto una nuova edizione per tener conto di ciò che è accaduto in Italia nel corso degli ultimi anni? Quali correzioni avrebbe apportato alle edizioni precedenti? Quale spazio avrebbe dato alle inchieste giudiziarie? Come avrebbe interpretato la richiesta di giustizia della pubblica opinione e la crisi delle istituzioni? Avrebbe parlato del G7 (il club dei paesi maggiormente industrializzati di cui l’Italia fa parte sin dalla metà degli anni Settanta) e del trattato di Maastricht? Avrebbe dedicato un medaglione a Francesco Cossiga, Massimo D’Alema, Gianfranco Fini, Romano Prodi, Silvio Berlusconi? E a quali personaggi storici li avrebbe confrontati per continuare la serie delle «vite parallele»?
Tra l’Italia del 1964 e quella del 1997 corrono molte differenze. La gastronomia italiana d’oggi è molto meno antica e genuina di quella descritta da Barzini. L’Italia «poverissima», di cui parla in un capitolo intitolato Il rovescio della medaglia, è diventata uno dei paesi più prosperi del mondo e occupa ancora, a dispetto della sua crisi, il sesto o quinto posto nella gerarchia dei paesi più sviluppati. Il divorzio, che Barzini considera estraneo alle tradizioni familiari degli italiani, è diventato legge di Stato. I nipoti di coloro che partivano dall’Italia soltanto per emigrare sono diventati a loro volta turisti e viaggiano freneticamente alla ricerca di esperienze esotiche. Il paese dell’arte e della bellezza si è imbruttito, i suoi musei sono chiusi, i suoi boschi bruciano, le sue spiagge sono coperte da villini e da palazzi d’appartamenti in «multiproprietà», i muri delle sue città sono imbrattati da graffiti irrilevanti e indecifrabili. Non basta. Se dovesse aggiornare The Italians Barzini sarebbe probabilmente costretto a constatare che sono scomparsi, insieme all’«opera d’arte», i suoi ammiratori. Gli stranieri che egli descrive nel suo libro – i «mylords», i «connoisseurs», i collezionisti, le vecchie zitelle, gli eccentrici, i Berenson, i Munthe, i Pound, gli Acton, i Krupp, gli anglo-fiorentini e i russo-capresi – sono diventati «rari nantes in gurgite vasto», e il «gurgite», naturalmente, è rappresentato dagli «inclusive tours» che si abbattono sulla penisola con la cadenza delle migrazioni stagionali. Mentre i vecchi italiani e i vecchi stranieri descritti da Barzini si amavano e si disprezzavano, i nuovi italiani e i nuovi stranieri si guardano senza vedersi.
Queste e altre sono le parti del libro di Barzini in cui il lettore ritroverà l’Italia degli anni Sessanta piuttosto che quella degli anni Noscandali, i processi, il teatro televisivo della politica e questa interminabile crisi, Barzini, probabilmente, lo avrebbe fatto in termini non diversi da quelli che ha usato per altri momenti di storia italiana. Il libro quindi ha superato la prova del tempo per due ragioni. In primo luogo perché le sue qualità letterarie ne fanno un piccolo «classico». In secondo luogo perché il ritratto degli italiani è ancora, nonostante tutto, molto somigliante. Se il lettore ne vuole una prova corra subito al capitolo intitolato Il potere della famiglia in cui l’autore parla della famiglia naturale e di tutte le altre – cricche, camarille, mafie, cabale e consorterie – che formano il tessuto della società italiana. Vi troverà, con alcune interessanti citazioni da Antonio Gramsci, una delle ragioni per cui l’interesse comune, in Italia, è costantemente scavalcato da una pluralità di interessi corporativi.
Dovremmo dedurne che il nostro paese è condannato ad essere eternamente eguale a se stesso? I mutamenti avvenuti in Italia dopo la prima edizione del libro dimostrano che anche noi cambiamo, nel bene e nel male. Barzini stesso, a giudicare dal suo Poscritto per il lettore italiano, ne era convinto. Scrisse questo libro, probabilmente, nella speranza che esso avesse per il vecchio corpo italiano gli effetti salutari degli anticorpi. E se constatasse, guardandoci dall’alto della sua redazione celeste, che assomigliamo un po’ meno al suo ritratto, sarebbe il primo a esserne felice.
![]()
POSTILLA
Questa prefazione, scritta nel 1997, appare qui senza correzioni e modifiche. Questo non significa che l’Italia d’oggi sia quella di undici anni fa. Abbiamo dismesso la lira e adottato una nuova moneta. Abbiamo mandato le nostre truppe in Kosovo, in Iraq, in Afghanistan, in Libano. Abbiamo assistito alla crisi e all’implosione finanziaria di alcune aziende nazionali, ma anche all’inattesa rinascita di Fiat e Parmalat. Abbiamo ceduto posizioni importanti nei settori trainanti dell’economia mondiale, ma abbiamo ancora piccole e medie imprese capaci di rinnovarsi e di conquistare mercati stranieri. Siamo stati spettatori di un duello elettorale fra due uomini politici, Silvio Berlusconi e Romano Prodi che sono dalla metà degli anni Novanta i protagonisti della politica nazionale: un capitolo inedito nella storia di un paese che ha avuto mediamente, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, un governo ogni dieci mesi. Anche l’Italia, come ogni altro paese, è cambiata, in parte per la volontà dei propri cittadini, in parte perché trascinata dai mutamenti di un mondo dominato dalle nuove tecnologie.
Ma i vizi, i tic e i dati caratteriali del paese sono rimasti gli stessi. L’Italia continua a essere un paese familistico in cui tutti – partiti politici, gruppi di pressione, ordini professionali, associazioni corporative e sindacati – sono impegnati in una contrattazione permanente che si conclude generalmente senza vinti e vincitori: un esito che garantisce una lunga discesa sul piano inclinato della mediocrità. Non è tutto. Rispetto al 1997 e ancor più rispetto all’anno in cui Barzini scrisse il suo libro, l’Italia è più disunita, più rissosa, più inferocita con la sua classe dirigente, con gli immigrati, con il fisco, con la giustizia, con se stessa. Siamo ormai un popolo di arrabbiati, di «angry young men», come venne chiamato il movimento letterario di John Osborne nell’Inghilterra degli anni Cinquanta e Sessanta. Con due importanti differenze. In primo luogo non siamo, come gli inglesi di allora, giovani. Siamo anzi, grazie alla diminuzione del tasso di natalità, una nazione sempre più vecchia. In secondo luogo la rabbia degli «angry young men» era geniale e costruttiva. Volevano sbarazzarsi della mentalità imperiale, dell’ipocrisia vittoriana, dei tic colonialisti, del peso schiacciante delle tradizioni anacronistiche. Volevano, insomma, rinnovare il Paese. La nostra rabbia contiene, insieme ad alcune eccellenti ragioni, un fondo preoccupante di invidia sociale, xenofobia, giustizialismo, egualitarismo plebeo: caratteri che a Barzini non sarebbero piaciuti.
dp n="13" folio="" ? Ma i cambiamenti non sono soltanto italiani. Il libro di Barzini fu scritto per un paese che l’autore conosceva e amava. Quando apparve, alla metà degli anni Sessanta, The Italians rispondeva alla curiosità della società americana per una terra che non aveva smesso di lanciare al di là dell’Atlantico forti segnali culturali e religiosi. Esistevano ancora gli italo-americani, e sembrava che avrebbero portato con sé, integrandosi nella società americana, una certa dose di «italianità». Barzini, quindi, parlava a lettori che avrebbero capito il senso del suo discorso. Dopo la fine del guerra fredda, e con una forte colpo di acceleratore all’inizio del nuovo secolo, è apparsa un’America alquanto diversa, più egocentrica, più politicamente autosufficiente, più incline a pensare che ciò che va bene per gli Stati Uniti deve andare bene anche per il resto del mondo. È un’America in cui, tanto per fare un esempio, alcuni giudici costituzionali sostengono che la citazione della giurisprudenza straniera nelle sentenze della Corte non è né utile né patriottica. Da questa America sono scomparsi gli italo-americani. Con un certo ritardo rispetto ad altri gruppi nazionali i nomi italiani sono ormai ovunque: nell’industria, nella finanza, nell’università, nella letteratura, nel giornalismo, nelle arti dello spettacolo, nella politica nazionale e locale, nelle forze armate, al vertice degli Stati e del Congresso. Ma hanno abbandonato lungo la strada quei vincoli con il paese d’origine che li rendevano un canale di comunicazione, sia pure limitato e provinciale. Sono soltanto americani con un nome italiano.
Ecco, per grandi linee, ciò è cambiato da quando Barzini ha scritto The Italians e io la mia prefazione. Ma non sono cambiati, per fortuna, l’interesse, lo spirito e il fascino di questo libro.
Sergio Romano, 1997-2008
![]()
PREMESSA PER IL LETTORE ITALIANO
Le cose passate fanno luce alle future, perché el mondo fu sempre di una medesima sorte, e tutto quello che è e sarà è stato in altro tempo; e le cose medesime ritornano ma sotto diversi nomi e colori; però ognuno non le ricognosce, ma solo chi è savio e le osserva e considera diligentemente.
Francesco Guicciardini.
Is there any other country in Europe where the character of the people seems to have been so little affected by political and technological change?
W. H. Auden nella introduzione al Viaggio in Italia di Goethe.
Questo libro non pretende di essere un trattato scientifico. Non è più autorevole né più esatto dei capitoli iniziali di qualche lunghissimo romanzo ottocentesco, nei quali l’autore descrive senza fretta il paese in cui si sta per svolgere la vicenda, il periodo storico, l’indole e i costumi degli abitanti. La tecnica esige, in simili casi, di non indugiare raccontando le cose che si trovano anche altrove (pure se frequentissime), ma di concentrare l’attenzione sui particolari distintivi (anche se più rari), quelli che fanno di un certo paese ciò che è e non un altro. È in fondo anche la tecnica del pittore di ritratti, che, per cogliere la somiglianza del modello, ne deve fare una impercettibile caricatura. Il modello, in questo caso, è la mia terra natale, ed io ho provato a volte le stesse sensazioni del pittore che si cimenta nella più impegnativa e imbarazzante delle imprese, il «Ritratto della Madre dell’Artista». Questa madre è notoriamente illustre. Il suo passato è glorioso, le sue tradizioni sono nobili, i suoi trionfi artistici e scientifici ispirano ammirato stupore e la sua bellezza reverente rispetto. Le ho voluto bene dall’infanzia.
Tuttavia, man mano che crescevo (come capita ai figli di molte madri celebri) le andavo scoprendo un numero preoccupante di difetti. Mi addolorarono alcuni suoi vizi. Non di rado la sua imprevidenza e la sua dappocaggine (mascherata, il più delle volte, di ingegnosa astuzia) mi indignarono. La sua cronica debolezza e le sue disgrazie mi riempirono di pietà e di esasperazione. Devo confessare che mi ha dato grandi gioie ma anche gravissimi dispiaceri e sono sicuro che non me ne risparmierà nel futuro. Fui costretto a concludere che non era sempre lo splendido esempio in cui avevo creduto. Eppure non potrei cambiare madre. Non posso smettere di volerle bene. Per tutto ciò, scrivendo questo libro, tentai di non cedere alla tentazione (quasi irresistibile con chi si ama) di essere inutilmente crudele, di ferire i suoi sentimenti, di dimenticare le sue meravigliose qualità. Allo stesso tempo feci il possibile per non adularla (è stata fin troppo adulata nel passato), per non essere sedotto dalla sua magia e fuorviato dai miei sentimenti filiali. Volevo tracciare di lei il ritratto più onesto che mi fosse possibile.
Mi rendo perfettamente conto che si trovano pochi uomini, in natura, che rappresentano, allo stato puro, il loro carattere nazionale. Tali personaggi sono per lo più convenzioni fittizie, utili per dibattiti politici e polemiche giornalistiche, maschere che servono a suscitare odio, ammirazione, invidia o amore tra gli stranieri. Gli uomini presi uno per uno sono fondamentalmente simili in tutto il mondo, m...