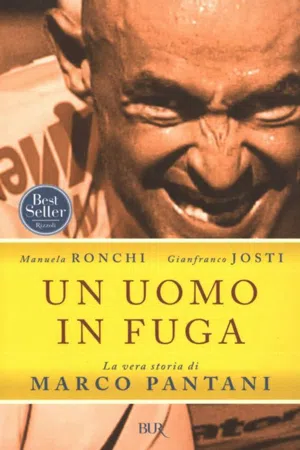![]()
INTRODUZIONE
«SE N’È ANDATO»
PER CINQUE ANNI la mia vita si è intrecciata con quella di Marco Pantani. All’inizio il nostro è stato un rapporto di lavoro, trasformatosi poi in modo radicale e profondo, difficile da spiegare con parole semplici: amicizia, confidenza, complicità sono alcune facce di questo che sintetizza cinque indimenticabili anni, al tempo stesso lunghissimi e brevissimi. Marco Pantani avrebbe dovuto essere l’autore di questo libro. Ne avevamo parlato a lungo, quando nel dicembre dello scorso anno passeggiavamo insieme per i prati del parco di Trenno, a Milano, spingendo la carrozzina di Filippo, mio figlio. Marco avrebbe raccontato le sue esperienze, in particolare la difficilissima lotta per ritrovare se stesso, per riacquistare un equilibrio di vita anche al di fuori del ciclismo. Quando fosse stato pronto, avremmo incaricato Gianfranco Josti, giornalista del «Corriere della Sera», profondo conoscitore del mondo dello sport e sincero ammiratore di Marco, di raccogliere i suoi appunti, di trovare un filo conduttore per il suo libro, che sarebbe stato indirizzato soprattutto ai giovani.
Marco non ce l’ha fatta, se n’è andato in punta di piedi, in silenzio. Nonostante tutto, però, la sua tragica morte è stata accompagnata da un fragore assordante, una confusione che ha travolto tutti, la sua famiglia anzitutto, oltre a me e a tutti coloro che l’hanno amato.
In piena sintonia con la madre, il padre e la sorella di Marco, mi sono assunta l’impegno di scrivere questo libro insieme a Gianfranco. Da quando mi sono affacciata al mondo del ciclismo, il Decano – così è soprannominato nell’ambiente – è sempre stato un preciso punto di riferimento per me. Non solo, era uno dei pochissimi giornalisti che Marco rispettava perché non forzava mai il suo pensiero, anzi, riusciva sempre a cogliere il nocciolo di quello che lui voleva trasmettere. Con lui cercherò in queste pagine di interpretare nel modo più corretto i pensieri, gli stati d’animo e gli episodi che hanno segnato la vita di Marco, non solo campione acclamato e osannato ma anche uomo fragile e autentico. Lo riteniamo un doveroso tributo per ristabilire la verità dopo le troppe menzogne scritte e dette durante gli ultimi anni della sua carriera e dopo la sua fine. Anche alla luce della perizia eseguita sul midollo dopo la sua morte, che restituisce al campione, per quanto solo alla sua memoria, l’orgoglio perduto.
Una fine che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che gli hanno voluto bene davvero.
Il drammatico annuncio, Marco è morto
San Valentino, 14 febbraio 2004. Per me era stato un sabato d’ordinario lavoro, ma con quel senso di inquietudine che immancabilmente mi assaliva quando non avevo notizie di Marco. L’ultima sua telefonata risaliva a lunedì 9: mi aveva annunciato che sarebbe passato da casa a prendere l’auto e che si sarebbe trasferito a Saturnia. Avevo chiamato Elisa Amici, che era solita trascorrere il fine settimana da quelle parti, per chiederle di andare a controllare che tutto procedesse per il meglio. Mi aspettava una serata tranquilla, in compagnia di mio marito Paolo e di Filippo, il mio piccolo, davanti a un film di fantascienza in TV.
Non erano ancora le ventitré quando è squillato il cellulare. Era mio fratello Massimo: «Lela... è morto Marco!». Il sangue mi è andato alla testa.
No, non era possibile, sicuramente si trattava di una notizia falsa. Ma quando Paolo si è sintonizzato su un altro canale e ho udito l’annunciatore affermare: «Marco Pantani è stato trovato morto in un residence di Rimini» mi sono sentita mancare, prima di essere scossa da un’incontenibile crisi di pianto. Mi sono buttata tra le braccia di Paolo con Filippo stretto a me, avvolta da un senso di vuoto, come non volessi accettare la notizia.
In pochi minuti i cellulari sono diventati roventi. Mi aveva chiamato Amedeo Colombo, «mister Shimano», in lacrime; dall’Australia si era fatto vivo Max Biaggi: «Manu, è vera la notizia? Davvero Pantani è morto?».
Ero letteralmente in trance, incapace di arrestare le lacrime, ma sapevo di dovermi mettere subito in contatto con i genitori di Marco. Il cellulare di Tonina suonava, ma nessuno rispondeva. Allora ho provato con quello del papà. «Paolo, sapete già?» Dall’altra parte un minuto eterno di silenzio e poi Paolo ha parlato con voce afona, quasi per paura di ascoltare quanto stavo per dirgli... «No, cosa è successo Manu?» Mi sono resa conto che non sapevano nulla ed ero proprio io a dover dare loro la drammatica notizia. Ho preso fiato... «Paolino, Marco è morto!» Sono state parole urlate e come risposta solo un grido stridulo e lo scatto della comunicazione interrotta.
In quel preciso momento ho compreso quale tragedia si era abbattuta sulla famiglia di Marco e a quali dure prove sarebbe dovuta andare incontro. Paolo e Tonina avevano passato cinque lunghi anni di vera sofferenza, ma sarebbero stati disposti a viverne altri cento per cercare di aiutare il loro Marco. Da tempo temevano che questo momento sarebbe arrivato ma allontanavano il pensiero nella speranza che si accendesse una lampadina nella sua mente in grado di riportarlo alla realtà. Cercai di contattare anche Manola, la sorella. Aveva già ricevuto la notizia. Era a casa a festeggiare il compleanno del figlio Denis (proprio il 14 febbraio compiva quattordici anni) con tredici bambini. Aveva urlato dalla disperazione a tal punto che tutti si erano spaventati. Era confusa, smarrita, disorientata. Non riusciva a parlare con i genitori e riceveva in continuazione telefonate anche da sconosciuti.
E intanto continuavo a ripetermi «non è vero, non è giusto, non può essere vero. Si sono sbagliati». Rivivevo gli ultimi giorni che il Panta aveva trascorso a casa mia, quando, cullando il mio piccolo Filippo, giocava a fare lo «zio Fester». Ma la TV, implacabile, continuava a ripetere la notizia, avanzando dubbi: «Non è dato sapere se si tratti di morte naturale o suicidio».
No, non poteva essere suicidio. Anche nell’ultima telefonata Marco mi aveva parlato di programmi per il futuro. Nella sua voce c’era spesso tanta disperazione, ma ero convinta che si sarebbe ripreso. Ancora una volta, invece, era successo l’irreparabile, e io dovevo correre a Rimini, convocata dal magistrato inquirente Gengarelli, che aveva trovato l’ultima lettera da me lasciata a Marco.
Credo sia stata la notte più lunga e difficile di tutta la mia vita. Ho raccolto in una borsa il necessario per mio figlio, e nel cuore della notte, dopo averlo portato al lago da mia madre, io e mio marito Paolo ci siamo diretti a Rimini.
Nelle lunghe ore trascorse in auto, mentre mio marito guidava, ho rivissuto gli anni trascorsi al fianco di Marco Pantani. Giorni felici, giorni bui, giorni pieni di speranze e di cocenti delusioni. Ho imparato a conoscere il suo carattere, il suo modo di essere, un misto di straordinaria generosità e crudo egoismo. Ho rivissuto le persecuzioni che per cinque anni ha dovuto subire da parte di troppe persone. Ho provato un senso di rabbia, ma anche di frustrazione, per non essere riuscita a tirarlo fuori dal tunnel in cui si era infilato. Con una punta di invidia ho pensato a chi, come Gianfranco Josti, aveva vissuto la stagione dei suoi trionfi.
La memoria è tornata indietro ai suoi racconti, ai suoi giorni di bambino trascorsi in compagnia di nonno Sotero.
Da qui comincia il racconto della sua tormentata vita.
![]()
CAPITOLO 1
L’INFANZIA DI MARCO
E LE PRIME VITTORIE
CAPIRE LA COMPLESSA e allo stesso tempo affascinante personalità di Marco Pantani non è semplice. Dobbiamo partire da lontano, dal racconto di mamma Tonina.
«Manola aveva solo cinque mesi quando sono rimasta incinta di Marco. Da un lato ero felice, perché i bambini mi sono sempre piaciuti, ma dall’altro ero preoccupata perché c’era una miseria che si tagliava con il coltello e io dovevo lavorare. Così sono andata a Bellaria, dai miei genitori, per consentire a mia madre di accudire la piccola, mentre io mi guadagnavo lo stipendio come inserviente ai piani di un albergo. Nonostante il lavoro faticoso, dovevo preoccuparmi anche di portare avanti la casa, così col mio pancione salivo in bicicletta con Manola sul seggiolino per andare a fare la spesa. Un giorno abbiamo fatto anche un bel capitombolo tutti e tre: si vede che era destino di Marco quello di cadere ancor prima di nascere. Paolo, mio marito, era orgoglioso di suo figlio, tanto che quando è nato ha portato tutti gli amici all’ospedale di Cesena: "Guardate che piedi grandi che ha, e come è bello, capelli neri, carnagione scura ma occhi azzurri".»
Un’infanzia un po’ tribolata, quella di Marco e della sorella Manola, sempre pronti a infilarsi in qualche guaio. Esperienze che hanno segnato la vita di Marco, facendo qualche volta rischiare l’infarto ai suoi. Lo stesso Marco, qualche anno dopo, si sarebbe definito così: «Dire che da piccolo ero bricconcello è riduttivo; ero un vero pestifero, uno scalmanato, difficile da gestire e combinavo guai in continuazione. Ero un capobanda, mi piaceva essere il numero uno».
Una volta, tornando a casa tenendo per mano la mamma e il babbo, Marco vide nonno Sotero e gli corse incontro proprio mentre sopraggiungeva un’auto: finì sotto le ruote, ma se la cavò con una botta alla spalla. Mentre Tonina rassettava le camere in albergo, lui scappava in spiaggia e si buttava in acqua, ed erano i clienti che lo andavano a recuperare. Un giorno fu afferrato al volo dalla mamma mentre stava scavalcando la ringhiera di un terrazzo per gettarsi di sotto, convinto di essere un paracadutista. Un altro, per imitare Zorro dopo una festa di carnevale, si lanciò dal tetto di un’automobile sfoggiando il costume cucitogli dalla mamma. Altre bravate Marco le avrebbe confessate solo diversi anni più tardi: Bicio e Massimo, due amici che andavano spesso a prenderlo dopo la scuola, per ferragosto avevano comprato delle anguille vive e lui gliele aveva ammazzate a colpi di bastone. Quella volta finì a padellate in testa.
Monello sì, ma benvoluto da tutti e capobanda fin dai tempi dell’asilo, quando i suoi amichetti si rivolgevano a lui per risolvere i problemi. Tra i più affezionati c’era Fabio, un bambino disabile col quale Marco avrebbe mantenuto in seguito un intenso rapporto, andandolo a trovare appena poteva nella casa-famiglia dove viveva.
E il suo rapporto con la scuola? Racconta Tonina:
«Era stato definito "un ragazzo difficile" e lui questa storia non l’ha mai digerita. La signora Neri, la sua maestra, voleva un’insegnante di sostegno per aiutarla a tenerlo a bada. Per questo Marco non ha mai avuto un buon rapporto con lei. Quando è diventato famoso, la signora Neri è venuta a cercarlo: si era trasferita a Forlì e aveva piacere di rivederlo perché lei aveva immaginato che nella vita avrebbe avuto successo. Quando è morto, accanto alla bara c’era anche il suo mazzo di fiori. A scuola Marco non andava volentieri, perché mal sopportava l’idea di starsene seduto per ore ad ascoltare le lezioni o a fare i compiti e non portava nemmeno le pagelle a casa. Era nonno Sotero che lo andava a prendere, perché io e Paolo dovevamo lavorare e così era lui che controllava la pagella e la firmava».
Il pomeriggio, tenerlo a freno era un problema. S’incontrava con gli amici per combinare le solite marachelle. Catturava i ramarri e fingeva di tirarli addosso alla mamma come pallottole. Giocava nel cortile e Tonina lo teneva d’occhio dalla finestra. Quando si toglieva la maglia per legarsela attorno alla vita voleva dire che si era fatto la pipì addosso. Per Marco, questa era una strategia per catturare l’attenzione. È andato avanti così per anni e ha smesso solo quando hanno rinunciato a sgridarlo. Ragazzo esuberante, ma molto intelligente: «Marco, fai i compiti, fai i compiti», «Sì, dopo li faccio». A casa non studiava, perché memorizzava tutto quello che sentiva in classe dalla maestra. In seconda elementare la pagella riportava questo giudizio:
Situazione di partenza incerta, nonostante l’intelligenza vivace alla quale si contrappone un temperamento nervoso ed irrequieto. Troppo vivace, molto aggressivo, irrimediabilmente negligente e disordinato. Nella vita coi compagni vuole essere sempre all’avanguardia e non ammette la sconfitta. A casa non fa quasi niente, ma a scuola si interessa a tutto ed è pronto alla conversazione su qualunque argomento. Scarso in lingua per la scrittura e l’ortografia troppo trascurate; buone le idee e personali. In aritmetica si arrangia. Però migliora. Pronto nella drammatizzazione.
Per la famiglia Pantani non era facile sbarcare il lunario. Così, sotto il peso del lavoro e di due bambini da crescere, Tonina si ammalò di depressione e rimase a lungo in ospedale. Anche la bicicletta rappresentava un incubo, per lei:
«Abitavamo sul canale. Lui, piccolissimo, ebbe in regalo dal nonno una bici rossa e io avevo sempre il terrore che finisse in acqua. Le cose me le sentivo dentro, così come negli incubi notturni immaginavo che Marco morisse annegato in un mastello usato per lavare la biancheria. Lì, nella vecchia casa di via Garibaldi, Marco ha imparato ad andare in bici grazie agli insegnamenti di mio cognato e del signor Ciani, presidente della Fausto Coppi, un uomo anziano cui s’era molto affezionato».
Quando doveva andare a lavorare, Tonina caricava i bambini sulla bici, Marco davanti, Manola dietro. «Mi raccomando, tenete le gambe larghe perché se mettete i piedi in mezzo alle ruote cadiamo» era la frase di rito prima di ogni tragitto. Un giorno, sul ponte di viale Roma, Manola non seppe resistere alla tentazione: infilò un piede tra i raggi, tutti e tre ruzzolarono a terra e la piccola si ritrovò con un piede maciullato. Comunque, a dispetto di tutte le raccomandazioni dei medici, appena poteva anche lei scappava a fare il bagno in mare con Marco.
Non era certo tranquilla la vita di Tonina e Paolo. Ma c’era la soddisfazione di essere riusciti a comprare, dopo anni di sacrifici, un grande appartamento in un condominio di viale dei Mille.
Marco, come tutti i suoi coetanei, aveva imparato a giocare a calcio. Gli avevano comperato le scarpe coi tacchetti («erano costate un mucchio di soldi»), aveva voglia di mostrare le sue qualità, ma magrolino com’era veniva lasciato sempre in panchina. Reagì tuffandosi sulla bici, anche perché i ragazzi ciclisti si radunavano proprio nell’ampio piazzale davanti al suo condominio. Lì abitava anche Nicola Amaducci, direttore sportivo della Fausto Coppi, da lì partiva il pulmino carico di biciclette per andare alle gare e lì era il raduno di partenza per gli allenamenti, venti-trenta chilometri di strada sotto l’attento controllo del direttore sportivo. Un giorno Marco decise di prendere la bici della mamma per aggregarsi alla compagnia. Pur faticando all’inverosimile, riuscì a rimanere nella scia degli altri, rientrando a casa stanco morto. Dopo quella prodezza, il coro di richieste perché anche Marco si unisse al clan dei giovani ciclisti fu unanime.
La voglia era tanta, ma le disponibilità finanziarie davvero poche. Marco non aveva il coraggio di farsi avanti con suo padre e perorare la causa del suo nuovo interesse per uno sport che aveva soppiantato il calcio, la corsa e il nuoto. D’accordo con la mamma, una sera si decise ad affrontare il padre:
«Babbo, voglio correre in bici».
«Poi capita come col calcio, ti annoi e pianti lì tutto. In più, per correre ci vuole una bici, e quella costa.»
«Non ci sono problemi, mi danno tutto loro, quelli della Fausto Coppi, bici compresa.»
La bici in effetti c’era, una Vicini color grigio metallizzato data in uso dalla Federazione e che da anni è esposta come un trofeo al Bar del Corso di Cesenatico. Era troppo grande per Marco, che riusciva a stento ad arrivare ai pedali, così gli amici lo prendevano in giro perché continuando a muoversi sulla sella «pareva facesse la sfoglia». Ma aveva vinto la sua battaglia e ora poteva confrontarsi con gli altri a colpi di pedale. E, da quel momento, Paolo cominciò a passare il poco tempo libero dietro al figlio in bicicletta. «Ho due lavori da fare» si lamentava papà Pantani con la moglie. «Seguire te e seguire Marco.»
Le prime esperienze in bici
Marco Pantani aveva uno straordinario rapporto con Sotero, il nonno paterno con cui aveva vissuto per un paio d’anni. Erano legatissimi. Il nonno gli aveva insegnato a pescare al mare e sul fiume, qualche volta lo portava a caccia, molto spesso passeggiavano insieme. Più che naturale che volesse assecondare il nipote nella sua nuova passione. Per il tredicesimo compleanno, Marco ricevette in regalo una Vicini Tour de France color rosso sangue di bue, ben più costosa di quella che i genitori avevano deciso di acquistare. «Non ti preoccupare, la differenza la metto io» aveva tagliato corto Sotero con suo figlio Paolo.
A quel punto Marco toccò il cielo con un dito. Nessuna bicicletta era più pulita della sua, dopo l’allenamento se la portava fin dentro casa e se per caso era infangata finiva direttamente nella vasca da bagno. Facile immaginare l’umore di mamma Tonina, che nel frattempo si era messa a vendere piadine in un chiosco.
Ancor più facile immaginare come Marco trascorresse i pomeriggi: in bici, alla scoperta di nuove montagne. Sfruttando le conoscenze di Paolo come cacciatore, si informava sui percorsi e andava a perlustrarli. Rientrava a casa quando era già buio, con centotrenta-centoquaranta chilometri nelle gambe. Non c’era salita o strappo in tutta la Romagna che lui non avesse scalato. E poi era un divertimento andare con i ragazzi della Fausto Coppi, lui sempre in coda fino a quando la strada non cominciava a salire. Allora li rimontava, guardandoli in faccia uno per uno prima di andarsene tutto solo. A distanza di anni, quando era già diventato professionista e aveva colto alcune delle vittorie più significative al Giro e al Tour, Gianfranco Camerini chiese a Pantani: «Chi sei quando stacchi tutti? La salita ti libera la mente dai pensieri?». Marco rispose: «Sono fatto a modo mio, in allenamento non accetto che mi si possa staccare. Voglio il vuoto alle mie spalle, sia in gara che durante le sgambate. Voglio abituarmi di giorno in giorno a essere solo: gli altri devono essere impegnati ad inseguirmi. Finché non li ho staccati tutti non mi sento a mio agio. Tra l’altro, il mio fisico è adattissimo alle salite».
Il 22 aprile 1984 è un giorno che papà Paolo ha ben impresso nella memoria: a Case Castagnole, Marco Pantani, categoria esordienti, vince la sua prima corsa.
«Me la ricordo bene, perché prima della gara scrissi un bigliettino che infilai nella tasca della maglia di Marco. "Devi avere coraggio, o salti tu o fai saltare gli altri." Alla partenza, frugando nel taschino, lo trovò e lo lesse ad alta voce alla presenza della moglie di Amaducci, il direttore sportivo. Mi diede retta, andò in fuga e vinse.»
I successi non arrivavano numerosi perché per gli esordienti si sceglievano percorsi pianeggianti. Ma bastava un cavalcavia perché Marco staccasse tutti, come accadde a La Caserma, un paese tra Forlì e Cervia. Se poi c’era una salita vera, come a Reggello, era come metterlo in carrozza: a tre chilometri dal traguardo, un suo compagno di squadra, Anthony Battistini, era in fuga con oltre un minuto sui primi inseguitori tra cui Marco che all’improvviso, sul tratto più impegnativo della salita, scattò, piantò in asso il gruppetto e dopo aver raggiunto il compagno lo superò presentandosi tutto solo al traguardo.
Dopo l’iniziale disaccordo sulla scelta sportiva di Marco, il padre finì per innamorarsi del ciclismo. Questo fece sì che il suo rapporto col figlio si intensificasse, nonostante fosse a lungo assente per lavoro. Qualche volta Marco seguiva il babbo nel suo vagabondare per l’Italia per la costruzione di impianti idraulici o scarichi industriali. Racconta Paolo:
«Lavoravo in Puglia, a Lesina. Marco, che aveva quindici anni ed era passato nella categoria allievi, era venuto con me. Era sempre fuori ad allenarsi, tra Rodi Garganico e Peschici, ma anche nella Foresta Umbra, capacissimo di fare più di cento chilometri per andare a provare una salita su indicazione di qualche appassionato del posto. Una settimana dopo, il sabato, rientrammo a casa, perché la domenica Marco voleva partecipare ad una corsa con arrivo in salita: stravinse».
Era la F...