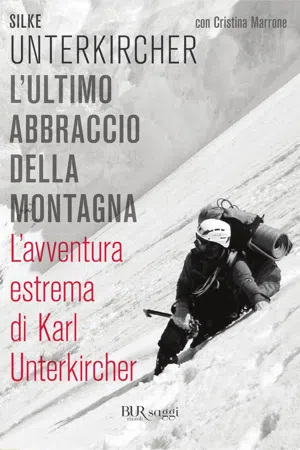1
Il Nanga Parbat, una scelta quasi per caso
«Libertà è il coraggio.»
Pericle
Il giorno prima di partire per il Nanga Parbat, nella catena dell’Himalaya in Pakistan, Karl zoppicava. Aveva solo un paio di sandali ai piedi ed era inciampato in un vaso di fiori davanti all’Edda bar di Selva di Val Gardena. Un bel capitombolo in mezzo alla strada di fronte agli occhi divertiti di chi aveva assistito alla scena. Che cosa pensassero Franz, il proprietario del bar, e i suoi occasionali soccorritori, Karl lo ha scritto nel suo diario: «Vuole andare a fare un Ottomila e non sta neanche in piedi ai 1500». Ed è più o meno quel che pensai anche io quando lo vidi tornare a casa scuro in volto e con un ginocchio dolorante. Gli preparai un impacco ghiacciato, ma la botta era stata violenta e il dolore non diminuiva. «Pensa se fosse passata una macchina, mi avrebbe sicuramente investito» mi disse preoccupato. Ma non c’era nessun’auto in strada in quel momento e il ginocchio non presentava lesioni; il giorno dopo, il 7 giugno 2008, Karl partì con i suoi amici Walter Nones e Simon Kehrer per Islamabad, in Pakistan, con l’obiettivo di scalare la parete Rakhiot del Nanga Parbat, ancora inviolata.
Per la verità il Nanga era stato un ripiego dell’ultima ora. Karl voleva scalare la parete Nord del Gasherbrum I, al confine tra Cina e Pakistan; anche quella una parete mai espugnata. L’aveva adocchiata con Michele Compagnoni, un ragazzo della Valtellina con cui aveva fatto amicizia nella spedizione sull’Everest, durante un’escursione di acclimatazione nella spedizione al Gasherbrum II, nel luglio 2007, e da allora non smetteva più di parlarne, la corteggiava e ne studiava le strategie di conquista, proprio come si fa con una donna. Michele però, un paio di mesi prima della partenza, si ruppe il legamento di un ginocchio e fu operato. Lui sì, si era fatto male seriamente, e rimase a casa.
La squadra per scalare il G1 era così composta: Karl, Daniele Bernasconi, fortissimo rocciatore, un Ragno di Lecco, anche lui reduce dal G2, e Walter Nones, carabiniere e istruttore di alpinismo a Selva con cui Karl era già stato sul K2 e poi sul Monte Genyen.
La burocrazia per ottenere i permessi a scalare le montagne dell’Himalaya è sempre una prova non indifferente per i nervi. Quella volta l’attesa era stata ancora più logorante, un’altalena di speranze e delusioni. Karl si era arreso soltanto dopo molto tempo. Gli avevano fatto credere che ormai fosse fatta, e invece mancava il nulla osta finale: quello dei militari. Il problema quell’anno fu l’Olimpiade: i cinesi avevano bloccato tutte le spedizioni fissate per l’estate 2008 per timore di attentati e proteste in Tibet. L’esercito aveva ordinato di non far avvicinare nessuno ai Campi Base e la speranza di un permesso speciale era alla fine svanita. Karl era veramente arrabbiato. C’è una pagina nel suo diario che rende bene il suo stato d’animo: «Ma ditemi voi se il mondo non è assurdo. Per motivi di sicurezza ci vietano di salire da un lato della montagna, mentre dall’altro versante parecchie persone andranno in cima, la stessa cima». Per questo nacque l’alternativa del Nanga Parbat: un altro Ottomila, un’altra parete inviolata, in Pakistan, Paese relativamente tranquillo, almeno in quel periodo.
La ricerca degli sponsor, la parte forse più complicata e ostica per Karl, era già partita da mesi. A lui sembrò più che naturale contattare prima di tutti Agostino Da Polenza, ex scalatore, oggi organizzatore di spedizioni alpinistiche sugli Ottomila e da due decenni coordinatore delle attività scientifiche in alta quota del Comitato Ev-K2 Cnr, di cui è presidente. Karl aveva cercato Agostino già per il G1, ma non se ne era fatto nulla: il manager gli aveva risposto che in quel momento aveva altri progetti. Sfumato il G1 lo informò comunque del suo nuovo obiettivo. Ma proprio Agostino, che aveva voluto e «arruolato» Karl per l’impresa Everest-K2, non fu per niente convinto da quel progetto. «Il Nanga Parbat? Dai retta a me Karl» disse Da Polenza «questa estate è meglio che prenoti sdraio e ombrelloni a Riccione.» Il dispiacere per quelle parole non fermò Karl. Lo spronò invece a lavorare ancora di più per preparare al meglio la spedizione.
Per il G1, intanto, la macchina degli sponsor era stata ormai attivata, i biglietti aerei fatti, i bidoni con i materiali pronti per essere spediti. Una rinuncia senza alternative avrebbe rappresentato non solo un problema economico, ma sarebbe stata una delusione terribile. Il Nanga sembrò a Karl un valido sostituto. E poi era un suo sogno nel cassetto da prima dell’avventura sull’Everest. La voglia di partire per un Ottomila, infatti, era da tempo sempre più incontenibile, tanto che nell’inverno del 2003 si diede da fare per organizzare una spedizione proprio per il Nanga Parbat. Molti suoi amici e anche colleghi dei Catores, i rocciatori della Val Gardena, si erano dimostrati entusiasti. Ma ancora una volta è il suo diario a raccontare la delusione: «Mi è dispiaciuto che a parole gli amici ci stavano, e quando si è iniziato a fare sul serio uno dopo l’altro si sono ritirati tutti». Così Karl accantonò quel progetto per tirarlo fuori quando sfumò la spedizione al G1.
A Daniele Bernasconi, di cui avevo sempre solo sentito parlare da Karl ma che non conoscevo di persona, il cambio di programma non piacque e si ritirò. Quel versante sconosciuto lo preoccupava e poi quella montagna proprio non gli andava a genio per tutte le tragedie che si era portata dietro. Per i tedeschi, i primi a sfidarla, era stata un bagno di sangue, con decine di vittime, negli anni Trenta. Inoltre Walter e Karl volevano scendere con gli sci e Daniele, che ama più la roccia rispetto al ghiaccio e alla neve, non se la sentiva di affrontare, sci ai piedi, pendenze tanto estreme. All’inizio Karl voleva partire solo con Nones, ma è stato proprio lui a insistere per portare una terza persona: si sentiva più sicuro. Ed è stato un bene che fossero in tre: almeno quando Karl li ha lasciati, in due si sono fatti forza per scendere da quella montagna mostruosa.
Ricordo che fu Walter a proporre di accogliere nella spedizione Simon Kehrer mentre Karl, all’inizio, era un po’ scettico. Anche se Simon era già stato con loro sul monte Genyen, un Seimila, non era sicuro che reggesse altitudini più elevate. Patire il mal di montagna su una via nuova di un Ottomila come il Nanga Parbat significava una morte quasi certa. Alla fine però Karl si convinse: Simon era un bravo scalatore, autonomo, forte e si erano trovati bene in spedizione. Avere un buon affiatamento era un’ottima base di partenza. A quote così alte si vive in simbiosi, si condivide tutto, si dipende l’uno dall’altro. Litigare può voler dire compromettere l’impresa.
I preparativi per la partenza furono frenetici. C’era sempre un problema da risolvere, un imprevisto. Karl era davvero stressato, stanco, sempre al telefono con sponsor e burocrati dall’altra parte del mondo. Ogni volta che riusciva a trovare una soluzione saltava fuori qualche nuova incognita. Ma la cosa che più lo impensieriva, e me lo diceva spesso, era la responsabilità di essere il capo spedizione. Non aveva paura per sé, temeva per i suoi compagni. Questa preoccupazione lo ha accompagnato nell’organizzazione di tutte le sue spedizioni. «Sento troppo il peso di questa impresa» mi disse Karl una sera dopo cena: «Sai bene Silke che non sono preoccupato per me, sono sicuro delle mie potenzialità, delle mie capacità. Se però dovesse succedere qualcosa a Simon e Walter non me lo potrei mai perdonare.» Prima di partire mi confidò che l’obiettivo successivo sarebbe stato il Manaslu, in solitaria: un modo per lasciare a casa l’ansia delle partenze in gruppo e di fare il capo cordata.
Per cercare di stemperare un po’ la tensione, e anche per concederci un po’ di tranquillità con i nostri tre figli, ci regalammo una piccola vacanza. Quattro giorni di mare in Liguria, ad Albenga, tutti per noi. Naturalmente vicino alle falesie, dove Karl poteva continuare ad allenarsi. Ma lui non si sentiva tranquillo, era sempre nervoso, pensava continuamente alle tante faccende che aveva ancora da sbrigare prima di partire. Il giorno prima del nostro ritorno a Selva eravamo in spiaggia: quella mattina lo vidi particolarmente pensieroso e teso, e allora gli proposi di fare un’escursione e provare una via in falesia. Ne tentò tre, ma incredibilmente non riuscì neppure a staccarsi da terra nelle prime due: «Non so che cosa mi stia succedendo, non ci sto più con la testa». Gli suggerii di salire una via più semplice, per cominciare a scaldarsi. Ma lui nemmeno mi ascoltò, non mi prestò attenzione concentrato com’era nei suoi pensieri: l’immagine del Nanga Parbat era sempre nella sua testa. «Se fossi una persona responsabile non dovrei partire» mi disse la stessa sera. Non gli risposi. Lo guardai negli occhi, ma non aprì bocca. Non me la sentii di dirgli di starsene a casa se non si sentiva pronto, di chiedergli di rinunciare al suo progetto. Lontano dalle montagne, Karl si sarebbe depresso, e io non volevo questo. Avrei dovuto restare lontana da lui per due mesi, ma poi, con i nostri tre bambini, lo avrei riabbracciato sereno, felice di aver portato a termine la sua impresa.
Dei tre piccoli terremoti che hanno riempito, durante le sue prolungate assenze, e tuttora occupano, il mio tempo senza Karl, Alex, il primogenito, che ora ha sette anni, è quello, naturalmente, più legato al papà. Lo guardo crescere a vista d’occhio, guardo le sue gambe allungarsi mese dopo mese, lo osservo mentre gioca con i suoi amici, apparentemente spensierato, ma so che per lui la mancanza del padre è un dolore quotidiano. Quando Karl era in spedizione lo sorpresi spesso a piangere nel lettone e chiedere quando sarebbe tornato, e quando lo avrebbe portato ancora a scalare in palestra. Alex ora è diventato l’ometto di casa e so che cerca di non farmi pesare troppo i suoi momenti di tristezza. Miriam è una bimba allegra, un batuffolino biondo di quattro anni dalla curiosità viva e instancabile. E in questo assomiglia a Karl. Marco, anche lui biondo come la sorella, oggi ha due anni, ed è troppo piccolo per ricordarsi del padre. Dei nostri figli forse è quello che gli assomiglia di più. C’è una foto, che ho incorniciato e appeso a una parete della cucina, che più di altre rappresenta la nostra famiglia: siamo nel soggiorno della nostra casa di Selva ed è una delle rare immagini in cui siamo tutti insieme e sorridiamo. È un ritratto che mi è particolarmente caro, scattato poco prima della partenza per il Nanga.
Karl per la sua spedizione si era allenato con scrupolo ed era tecnicamente preparato. Era solo molto stanco per lo stress che comporta organizzare una spedizione del genere. Probabilmente avrebbe avuto bisogno di un manager che lo aiutasse a risolvere gli infiniti problemi burocratici. Invece faceva tutto da solo. È vero che Herbert Mussner, un suo caro amico albergatore, da un anno gli dava una mano, ma il suo aiuto riguardava soprattutto la ricerca degli sponsor e la gestione del sito internet. L’organizzazione pratica era invece tutta sulle spalle di Karl, cosa che lo rendeva molto nervoso perché gli sembrava di rubare tempo alla sua montagna e all’allenamento che gli serviva per conquistarla. Più volte mi offrii di aiutarlo, ma lui rifiutava perché sapeva che avevo già i nostri bambini a cui badare.
Della nostra vacanza in Liguria non fui per niente contenta, e lui lo aveva capito. Sulla via del ritorno, in macchina, mi misi quasi a piangere perché lo sentivo già lontano e mi sembrava che avessimo perso un po’ di quella serenità che è sempre stata la forza della nostra unione. Mentre guidava verso Selva mi mise una mano su un ginocchio. Mi disse: «La va pa bën miëc, popa», che in ladino vuol dire «andrà meglio, ragazza». Sì, sarebbe andata meglio. Ne ero sicura anche io. Dovevamo solo abituarci a una nuova dimensione di vita e ai cambiamenti che ci avevano forse colti impreparati. Karl stava diventando un alpinista conosciuto e stimato, tanti sacrifici stavano dando finalmente i loro frutti. Ma le sue assenze erano diventate ogni giorno più insopportabili per me, per i bambini e anche per lui. Per fortuna i miei genitori e quelli di Karl, gli amici e vicini di casa, mi sono sempre stati accanto. Karl era molto stimato e amato dai suoi concittadini, per i quali era diventato motivo di orgoglio. Selva di Val Gardena, poco meno di tremila anime, crocevia tra la Val di Fassa e la Val Badia, è stato il luogo ideale dove Karl ha potuto coltivare la sua passione per la montagna. Il paese, luogo preferito di vacanza dal mai dimenticato presidente Sandro Pertini, è dominato a Sud dal Sassolungo e a Est dal Gruppo del Sella, tra le più belle cime delle Dolomiti.
Prima di ogni partenza per l’Himalaya c’erano tensioni. E non era solo per lo stress organizzativo. Eravamo entrambi consapevoli dei rischi a cui lui sarebbe andato incontro. Tutto può essere preparato in modo perfetto, l’allenamento ottimale, i materiali sicuri, l’umore alto. Però non basta. Soprattutto se si va a scalare una prima via. Lo sapevo bene anch’io che non solo ero la compagna di un alpinista estremo, ma per tanti anni avevo scalato e conosciuto le incognite della montagna. È impossibile calcolare i rischi che si corrono affrontando un Ottomila. Per tornare sani da un’arrampicata non ci vuole solo abilità, ma anche una buona dose di fortuna. Karl non aveva mai avuto un incidente, non era mai rimasto sepolto sotto una valanga, non aveva mai visto un compagno morire, esperienza che capita spesso a chi va in montagna. E preferiva non tradire le sue emozioni, i suoi turbamenti, quando arrivava la notizia di un alpinista morto. Una volta restò molto colpito per la tragedia di uno scalatore che nemmeno conosceva personalmente: Christian Kuntner che aveva conquistato tredici dei quattordici Ottomila. L’ultimo, la vetta dell’Annapurna, al quarto tentativo, gli fu fatale. Venne travolto dal distacco di un seracco. Accadde il 18 maggio del 2005, mentre Karl era sullo Jasemba, lo stesso giorno in cui nacque la piccola Miriam. Forse anche per questo Karl volle partecipare al funerale di Kuntner e dedicare a lui una nuova via aperta sul Salame del Sassolungo.
Karl e io avevamo stretto un tacito accordo, anni prima, quando lui aveva scelto di fare dell’alpinismo il suo mestiere. Era pronto ad accettare tutto quello che sarebbe potuto succedere. E io con lui. Era un uomo prudente e di grande calma. Banalmente erano queste sue caratteristiche a non farmi impazzire ogni volta che chiudeva la porta per decollare verso l’Himalaya, o più semplicemente per andare a scalare una cima delle nostre Dolomiti. Mi fidavo di lui e della sua esperienza. Non avrebbe mai ceduto a un azzardo rischiando di mettere in pericolo la propria vita e quella dei suoi compagni. Nonostante tutte queste nostre complicità, prima della partenza per il Nanga Parbat, la tristezza aveva preso il sopravvento sull’euforia mescolandosi alla preoccupazione già provata tutte le altre volte. Con tre bambini piccoli non avevo potuto accompagnarlo fino a Malpensa, così la sera prima della partenza siamo andati a mangiare una pizza. Noi due soli. Io avevo voglia di camminare un po’ e in pizzeria ci sono andata e piedi per conto mio. Volevo scaricare con quella breve camminata la tensione che mi stava divorando alla vigilia della partenza. Quando arrivai, lui era lì ad aspettarmi in auto, e siamo entrati insieme. Il locale «L’ ciamin» lo conoscevo bene: c’ero stata tante altre volte con Karl. Ma quella sera, accanto a lui, tutto mi sembrò nuovo, come se fosse stata la prima volta che notavo i colori caldi delle tovaglie, l’atmosfera accogliente e rustica che ci avvolse non appena entrammo. Lasciai scegliere a lui il tavolo e ci sistemammo in un posto un po’ più distante dagli altri clienti. Sebbene una cappa di tristezza gravasse su di noi, quella serata è stata molto bella. Forse una delle più belle che io abbia trascorso con Karl. Ci siamo sentiti profondamente in sintonia, compenetrati l’uno all’altra. E mentre parlavamo, mentre cercavo di rassicurarlo, ho avuto la netta sensazione che non avesse più voglia di partire. A fatica ricacciai indietro le lacrime. Karl era lì davanti a me, mangiava una pizza al prosciutto e sorseggiava birra dal boccale come lo avevo visto fare centinaia di volte, a casa: gesti consueti, familiari, che quella sera, tuttavia, avevano assunto un significato speciale perché sapevo che non li avrei vissuti per molto tempo, fino al suo ritorno.
Nella testa mi si affacciò il pensiero che quella poteva essere la nostra ultima serata insieme. Non era certo la prima volta che mi abbandonavo a una riflessione così triste, ma mentre ero seduta lì in pizzeria più che pensarlo, avvertivo come un presentimento. Naturalmente non dissi niente a Karl. Ma sono sicura che anche lui stava provando le mie stesse emozioni. Poi cominciammo a parlare del futuro, di tutto quello che avremmo fatto dopo il ritorno dal Nanga: cose semplici come acquistare finalmente i mobili per la cameretta dei bambini e una breve vacanza in baita, in montagna. Quella conversazione sui nostri progetti allontanò per un po’ l’angoscia che mi stava attanagliando e si fece finalmente strada nel mio cuore la serenità di essere lì con lui, come una coppia innamorata che si è concessa una serata fuori.
Noi due non eravamo sposati, cosa che non era mai andata giù a sua madre. Lei aveva impartito una educazione severa a Karl, l’aveva allevato secondo principi cattolici e il fatto di non aver suggellato il nostro legame davanti all’altare, per lei era difficile da accettare. La madre di Karl sottolineava spesso, anche con me, quello che per lei era un modo di stare insieme incomprensibile. Ma forse se ne era fatta alla fine una ragione. L’avversione di Karl verso il matrimonio, però, come lui stesso mi ha spiegato più volte, non era legata alla paura di un vincolo che poteva derivare dalla sacralità del rito in chiesa. Lui, molto più banalmente, odiava le cerimonie: un ricevimento di nozze lo avrebbe annoiato a morte. L’abito elegante, i sorrisi forzati ai fotografi, la liturgia davanti al sacerdote, il banchetto, le danze… Secondo me, nel bel mezzo della festa, sarebbe fuggito con le s...