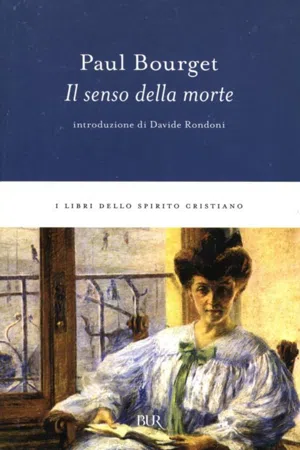![]()
INTRODUZIONE
Il senso della morte è il romanzo più forte di Paul Bourget, un autore ingiustamente dimenticato, di cui questa collana ha già avuto il merito di riproporre I nostri atti ci seguono. Nella prefazione a quel romanzo ci siamo soffermati, anche da un punto di vista letterario, sui meriti dell’autore. Ora, leggere e capire le pagine che seguono significa entrare nel vivo della preoccupazione di Bourget dinanzi all’affermarsi di una cultura non solo estranea ma anche ostile al cattolicesimo.
Ne Il senso della morte (uno degli ultimi romanzi di Bourget) la storia si svolge in un piccolo ospedale di Parigi, specializzato in neurochirurgia, trasformato, per l’incombere della prima guerra mondiale, in struttura sanitaria di sussidio alle truppe al fronte. Mentre dalle linee del conflitto sempre più vicine iniziano ad arrivare i primi feriti e il tragico spettacolo della guerra si fa più presente e vicino, nell’ospedale si consuma, segretamente, un dramma.
Bourget, da scrittore navigato, realizza, utilizzando pochi elementi, una storia di notevole forza che tocca le grandi profondità delle questioni esistenziali senza per questo risultare complicata. Mette in campo pochi personaggi, esposti in una situazione limite – la guerra incombente – che provvede a esaltarne i tratti fondamentali, dipana tutto l’intreccio intorno all’esistenza di un terribile segreto (il patto tra il chirurgo Ortègue e la giovane moglie), e fa osservare e raccontare il tutto da un personaggio-spettatore (l’assistente di Ortègue) con il quale, di fatto, il lettore si trova a immedesimarsi.
Come sempre, infatti, nei romanzi di Bourget, il vero protagonista della vicenda deve essere il lettore, con la propria coscienza e intelligenza. Quando definiva i suoi come «romanzi di idee», Bourget indicava questa caratteristica: l’essere opere dinanzi alle quali il lettore non può fare solo un’esperienza di intrattenimento letterario, ma nelle quali vibra l’appello a un impegnativo confronto ideale e ideologico. In questo senso, veri e riusciti romanzi sono sempre quelli «di idee». Anche in questo caso il romanzo, pur essendo totalmente immerso nel proprio tempo (lo si vede per esempio nell’uso di una certa terminologia medico-scientifica o anche filosofica oggi superata), risulta non solo comprensibilissimo a chi non abbia familiarità con tale terminologia, ma anche adeguato al tempo nostro.
Le idee, come indica la stessa radice greca della parola, sono modi di guardare, di leggere il reale. Ciò che chiamiamo un’idea è dunque conseguenza di un modo di leggere un aspetto del reale, e la maggiore o minore verità di un’idea risiede nella capacità di leggere più compiutamente quel tale aspetto del reale. Perciò le idee provengono sempre – se non vogliono imporsi come pure astrazioni a mo’ di violenta griglia di lettura del reale – da un’esperienza, cioè da una presa di contatto, da un coinvolgimento tra il soggetto e l’oggetto.
In un reparto di neurochirurgia come quello retto dal brillante professor Ortègue l’oggetto sotto osservazione si chiama uomo. E più precisamente l’uomo colto nel punto (l’assetto neurologico) in cui il mistero della sua interiorità sembra mostrarsi, sembra svelare le sue dinamiche e le sue leggi. Perciò, in quel reparto, chi non abbia abdicato all’uso della ragione è portato a farsi la propria idea intorno alla composizione dell’esperienza umana.
Così all’assistente-lettore (che mostra di non avere ancora idee precise) il brillante e famoso chirurgo Ortègue spiegherà che per lui, splendido nella sua dedizione alla causa scientifica e nella riuscita mondana, coronata dal matrimonio con la molto più giovane Catherine, non esiste nient’altro di reale nell’esperienza umana al di fuori di ciò che può essere scientificamente certificato. Tenendo fede a tale idea, maturata nell’esercizio di una nobile professione e coltivata in un animo generoso, il professore, trovandosi in mezzo al gorgo di eventi rappresentato dal suo amore per la giovane moglie e dall’aggravarsi della sua salute oltre che della situazione dei ricoveri, concepisce un piano terribile e salderà un patto con la sua Catherine, segreto a tutti, eccetto, casualmente, che all’assistente-lettore.
Bourget ci fa precipitare nella storia insieme agli eventi. Assistiamo a un crescendo di pathos ben governato e senza cadute eccessive di tono. Ci sono momenti di intensità quasi dostoevskiana, accanto a performance di introspezione psicologica dei personaggi e della loro epoca che ricordano Stendhal. Non solo nei momenti più «ideologici» del romanzo, ma anche con lievi tratti Bourget ci segnala il mutare dei convincimenti, le contraddizioni, le scoperte: si pensi allo sguardo che il professore riserva alla donna amata, venato da «quasi un senso di crudeltà», o alla fisionomia di Ernest Le Gallic, il soldato-testimone, cugino di Catherine, in cui l’autore, non trovando espressione più adatta, rileva «l’unità di quel viso»; o, ancora, si pensi a quello «stridore di meningitico» che dà, d’un colpo, tutto il senso della grave situazione medica e umana dell’ospedale.
Secondo una concezione espressa nel pragmatismo noto a Bourget, la verità di un’idea sta nel fatto che ne può seguire un’azione. Ma idee sbagliate possono sì condurre all’azione, ma a un’azione sbagliata. Il patto tra Ortègue e sua moglie è un’azione coerente all’idea che lo ha generato ma è un’azione che, per svolgersi, deve negare e censurare molti elementi della realtà. Deve, cioè, dar luogo a un’esperienza umana «autolimitata». Un modo di attuare tale censura è, come fa Ortègue nei confronti dei sentimenti o della stessa fede religiosa, accusare certe cose di essere pure fantasie. Di fronte a Ortègue si erge (ma è un ergersi che non ha nulla di eroico all’apparenza) la figura del giovane cugino della moglie. Al di là degli accenti squisitamente patriottici con cui Bourget tratteggia il personaggio, il dato essenziale di Ernest è nell’aver vinto la sua specialissima partita contro Ortègue non per essere riuscito a spiegare con dei ragionamenti l’esistenza di un «altro» mondo (radice invisibile di quel che è visibile e misurabile) ma per averlo fatto vedere, specialmente nel suo atto di offerta.
In un punto magistrale del romanzo, l’assistente-narratore-lettore, che essendo zoppo è stato scartato dal fronte e pur si trova a dover affrontare il cuore del problema della morte in una inaspettata circostanza, dichiara che «solo la vita lotta contro la vita». Così lascia intendere che un’idea sulla realtà, su Dio, sulla natura umana o su qualsiasi altra questione mostra la sua forza rispetto a un’altra idea in quanto proviene da una esperienza più forte, più vera, in una parola più umana di quella opposta. Dunque, non da un dibattito di idee proviene alla giovane Catherine la forza della sua drammatica scelta, bensì dall’aver «visto» che le idee del cugino erano un’esperienza e che pur risultavano la migliore lettura dell’esperienza umana che lei, suo marito e lui stesso stavano vivendo.
Da questo punto di vista, Bourget è bravo nel costruire quasi in parallelo l’opposizione, lo sviluppo della vicenda umana del soldato Ernest e del chirurgo Ortègue, fino al loro epilogo e all’atteggiamento con cui essi vi giungono. La lettura dell’esperienza umana che emerge nella figura dell’oscuro soldato si dimostra più intelligente e comprensiva, più costruttiva di quella del chirurgo di successo. Nel disegnare tale opposizione, non cade l’ammirazione per la dignità e il valore umani della figura di Ortègue, ma ogni errore della sua lettura della realtà è rilevato con lucidità. Così come, ben oltre i toni di un certo patriottismo tutto francese, l’autentico cuore cattolico della figura di Ernest emerge con nitore e senza enfasi. Dalla lettura, agevole e rapida, di questo romanzo compatto e forte si esce con il turbamento e l’insperata chiarezza intellettuale che sempre accompagna i capolavori.
DAVIDE RONDONI
![]()
I
IL DOVERE
Voglio scrivere le mie memorie, prima che si scoloriscano. Mi resta pochissimo tempo in questa clinica di rue Saint-Guillaume, che la guerra ha trasformato in ambulatorio: quaranta letti, sempre occupati, e da quali feriti! Siamo due medici addetti al servizio: due, per modo di dire... Il chirurgo viene soltanto al mattino per le operazioni: ritorna al pomeriggio, dà un’occhiata, va via; e così resto solo con un misero studentello di second’anno, riformato perché cardiopatico, e tanto inetto, al quale a malapena posso affidare l’incarico d’una iniezione endovenosa. Questa vita dura da nove mesi: agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile; nove mesi dal giorno in cui, ad onta della mia gamba zoppicante, chiesi di partire per un posto di soccorso al fronte. Rivedo ancora quel pomeriggio radioso (e ve ne furono molti, ironia della sorte!, in quella tragica estate del 1914), in cui giunsi dal mio povero maestro, il professor Michel Ortègue, che si era incaricato di perorare la mia istanza.
«Impossibile, caro Marsal! Non la vogliono! Ma ho combinato le cose a modo mio: faccio militarizzare la clinica. Lei è stato mio assistente interno a Beaujon. È vero che da quel tempo ha un po’ tradito la chirurgia; ma essa le perdona. Ho bisogno d’un supplente sul quale possa fare assegnamento. La prendo con me... Siamo intesi?»
Per chiunque avesse lavorato una sola volta al suo servizio, quell’uomo, dotato di una personalità così energica, rimaneva sempre il «Primario», i cui ordini non si discutono. Accettai: dovrò dunque passare l’intero periodo della guerra nel vecchio palazzo che Ortègue ha bizzarramente adattato all’esercizio della sua specialità: la chirurgia nervosa. Andava fiero di quell’edificio costruito nel 1690 dall’architetto Daniel Marot per il primo duca di Colombières. Si compiaceva a enumerarne i fasti e gli inquilini: prima, il duca di Colombières; poi, una nipote del grande Condé; indi, non so qual finanziere, figlio di un barbiere, arricchitosi col sistema di Law. Il palazzo aveva servito da carcere nel periodo del Terrore, per diventare poi la residenza di un maresciallo al tempo di Napoleone e albergare un’ambasciata estera durante la monarchia di Luglio, nonché un senatore sotto il secondo Impero. Nel corso di duecentoventicinque anni, quanti drammi intimi si saranno svolti tra le sue mura, al cospetto del giardino silenzioso i cui vecchi alberi mettono ora le gemme di una nuova primavera! In agosto le foglie verdeggiavano; poi le vidi ingiallire, avvizzire, cadere; adesso le vedo rinverdire. Quanti altri occhi avranno contemplato, in ore d’angoscia, i medesimi alberi, sbigottiti al pari di me dal contrasto fra il lavorìo della natura, che segue con lentezza incessante un ritmo senza scosse, e la frenesia dolorosa delle passioni umane! Ma cos’erano le tragedie in cui si sono trovati coinvolti gli ospiti di questa casa, di fronte all’orrendo cataclisma, il cui funesto richiamo m’investe dovunque, anche mentre contemplo il giardino primaverile? I mutilati si trascinano per i viali, chi amputato d’un braccio, chi d’una gamba: uomini esausti, anelanti alla carezza del primo sole. Se varcassi questa soglia, di camera in camera, vedrei sopra i cuscini facce esangui o tumide di feriti, pupille febbricitanti, narici forate, bocche contorte e, sparsi alla rinfusa sulle coperte, i giornali con intestazioni evocatrici di miserie ancora peggiori: «Furiosi combattimenti a Dixmude... Nuovo bombardamento di Reims... Transatlantico affondato da un sottomarino!...».
Di fronte a questi indizi della vicinissima guerra, quante volte, in autunno e in inverno, fremetti di trovarmi qui, non già inutile, ma lontano dal pericolo! La mia imperfezione fisica mi colmava di vergogna, come se non fossi innocente del destino che, trentadue anni or sono, mi fece nascere con un piede storto inoperabile. Quando i taube e gli zeppelin lasciavano cadere le bombe su Parigi, provavo una sensazione di calma, nonostante i fremiti di ribellione e d’orrore. Senza dubbio il pericolo era insignificante, ma era sempre un pericolo; e mi sembrava di condividere la battaglia solo per il fatto di udire, per un attimo, lo scoppio delle bombe che i nostri eroici soldati odono dalla mattina alla sera. Ma poi m’arrendo alla ragione.
Ho chiamato eroici i soldati: perché? Perché sacrificano coraggiosamente la vita. A che cosa? Al dovere. Ma cos’è il dovere? L’ubbidienza alla legge. Approfondisco quest’idea. Per uno scienziato, cos’è una legge? Una successione costante e necessaria tra due fatti. Se Ortègue fosse ancora al mondo, mi darebbe una definizione semplicissima dell’eroismo: «Supponiamo un fatto: il pericolo; supponiamo un altro gruppo di fatti: un certo temperamento, una certa eredità, una certa educazione; questo temperamento, questa eredità, quest’educazione secerneranno il coraggio, mentre un altro temperamento, un’altra eredità, un’altra educazione secerneranno la viltà, allo stesso modo che al contatto di questa o di quella sostanza lo stomaco secerne il succo gastrico e il fegato la bile».
Lo ascolterei, non oserei rispondere; ma, nondimeno, rimarrei dell’opinione che i fenomeni psichici sono più complessi di quanto ammettano spiegazioni di tal fatta. Noi non giudichiamo uno stomaco che secerna o no il succo gastrico, e un fegato che secerna o no la bile; ma giudichiamo il soldato che mostra del coraggio, e il soldato che mostra della viltà. Non solo accertiamo il loro atto, ma lo qualifichiamo. Per uno, proviamo stima ed entusiasmo; per l’altro, disprezzo. E perché? Perché l’atto non è necessario, non è invariabile: è soltanto doveroso. Ecco la differenza fra le leggi che regolano le energie della volontà e quelle che regolano le energie fisiologiche. Approfondisco ancora quest’idea: l’obbligo ha un limite, che è il limite stesso delle nostre facoltà. Nessun ordine di un comandante può obbligare i soldati a marciare sul mare. Perché? Perché non possono. Dunque, il dovere è proporzionato alla possibilità. Per esempio, data la mia imperfezione fisica non potevo fare il medico in un’infermeria del fronte. Perciò non devo rimproverarmi se sono qui: ho lavorato al mio meglio in quest’ospedale, ho applicato le mie facoltà al servizio della guerra: non ho adempiuto al mio dovere?
![]()
II
L’ESPERIENZA DEI FATTI
Da quale strano recesso scaturisce il filo delle mie riflessioni, data appunto la mia qualità di medico incaricato di ricerche mediche, in un ambiente medico quant’altri mai? La preoccupazione, l’ossessione del problema morale sarà il carattere dominante della mia vita durante la guerra. Per quest’unico motivo, allo scopo di veder chiaro nel mio pensiero, ho preso un quaderno di carta bianca e ho cominciato a redigere questa specie di «memoriale», raggruppando con metodo un’intera serie di fatti, dei quali la sorte mi volle qui testimone. Sulle prime, con l’animo sconvolto dalla loro singolarità, non ho avuto la forza di osservarli intellettualmente; ne sentii soltanto l’efficacia tragica. Ma dopo un lungo intervallo di tempo credo di conoscere il significato astratto e il valore d’argomentazione, a vantaggio di una tesi o, meglio, d’una ipotesi. Quante volte, a Beaujon, mentre uno di noi finiva di anestetizzare il paziente sulla tavola operatoria, ho udito l’eroe di queste scene dolorose, Ortègue in persona, ripeterci: «Per il vero clinico, il malato è un’esperienza istituita dalla natura!».
Gli avvenimenti di cui m’accingo a fissare i particolari costituiscono anch’essi una di queste esperienze; e la narrazione che ne farò sarà una delle tante «osservazioni» che Ortègue ci consigliava sempre di compilare. «Fatti!» insisteva. «Raccogliere fatti, sempre fatti. Il Magendie aveva ragione: lo scienziato è uno straccivendolo, che si aggira per il campo della scienza con la gerla sul dorso e l’arpione in mano, raccattando da terra quel che trova.» Sì, ma se l’infelice maestro si rialzasse dalla tomba sontuosa fattasi preparare nel cimitero di Passy, dove la sua povera carne torturata trovò finalmente, senza morfina, il sonno, non gioirebbe certo della presente «osservazione». I fatti che intendo registrare appartengono all’ordine della psicologia religiosa; e, per quell’idolatra dei fatti, essi non esistevano. Quando gli parlavo del problema religioso rideva d’un riso garrulo e sonoro, ed era impossibile cavargli di bocca una formula diversa da questa, parodiata dal Malato immaginario: «Primo purgari, postea filosofare». Purgarsi? E di che cosa? Dell’idea d’un possibile aldilà: di quel malsano atavismo di misticità, che nei fenomeni della natura ci stimola a ricercare la traccia di un pensiero, di una volontà, di un amore. Non ammetteva che il destino esistesse nel mondo: come, del resto, non l’ammetteva nell’uomo. Pensando in tal modo, credeva di ubbidire al principio del Magendie: la sottomissione dell’intelligenza al fatto bruto. Nemico di tutti i dogmatismi, non si accorgeva di dogmatizzare in un altro senso. Egli non riconosceva per fatti se non i fenomeni, anticipatamente scelti con ortodossia altrettanto sistematica e parziale dell’altra: l’ortodossia scientifica. Gli obiettavo timidamente che il fatto religioso è anch’esso un fatto; dunque, secondo la dottrina sperimentale, sarebbe scientifico il tenerne conto. «Primo purgari» ripeteva. «Il soprannaturale non esiste. Ciò che nell’universo presuppone una intenzione personale, è per definizione nullo. Se lei mi dicesse: "Ho visto un animale, che sentiva e camminava senza sistema nervoso...", non avrei bisogno di verificare la sua testimonianza: so che è falsa...»
Innumerevoli scienziati ragionano come Ortègue. Anch’io, un tempo, ho ragionato così; poiché, per l’addietro, non mi ero mai imbattuto a faccia a faccia in una realtà contro la quale cozzo da molte...