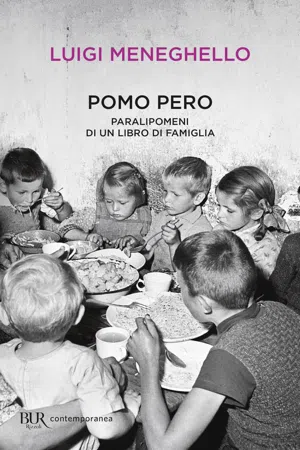Cavar su i morti
Mi sono vestito civilmente, non da festa che non usa quasi più neanche qui in paese, ma di scuro con la cravatta, quella che mi ha comprata mio padre a Treviso tanti anni fa, e ho messo anche il gilè. Anche nel vestire, sto rinnovando la generazione di mio padre, lo ricordo bene quand’era come sono io ora; naturalmente mi sento meno uomo, forse perché non faccio un lavoro manuale.
Sono arrivato con la nuova automobile per young executives, mezza sportiva, che ha più cavalli dei torpedoni che guidava lui. Con me è venuta mia moglie che verrebbe ad essere la young executive’s wife e che avendo adottato i miei genitori come suoi viene anche ad essere una specie di sorella: i suoi li ha persi di vista in tempo di guerra, in quella stazione all’aperto, al confine tra la Polonia e la Cecoslovacchia, Oswiecim. Mi ha detto che a sud si vedevano dei monti lontani, la catena dei Tatra.
Ho parcheggiato la macchina tra gli olmi davanti al cancello. Era chiuso, ma come ci avevano detto bastava spingere. Dentro, pareva che non ci fosse nessuno; poi abbiamo visto in un cantone Emilio campanaro che stava scavando. Emilio è un coetaneo, eravamo a scuola insieme; è un uomo grande e grosso, molto schivo.
Siamo andati a parlargli; si è tolto il berretto, e mi ha dato del lei, mi ha chiamato professore. Gli ho fatto un po’ di rimostranze, e lui ha smesso di darmi del lei, senza però darmi del tu, solo evitava i pronomi personali. È evidente che non è molto abituato a parlare, e l’ha detto anche lui, quando gli ho domandato come va: «Sto sempre qua coi morti. C’è silenzio».
Mi ha fatto la sua relazione: tutte due le casse erano ancora in buono stato, salvo qualche crepo, ora le ha fatte rivestire di zinco e siamo apostissimo; anche per i nonni molto bene, naturalmente le casse non c’erano più, hanno messo gli ossi in due cassettine. Ha detto che la nonna che era così minuta pesa ora come il nonno che era un quintale. Avrebbero cent’anni proprio adesso, lei appena compiuti, lui tra poco. È passato un secolo da quando il paese è diventato Italia.
Sono arrivati gli uomini per sistemare le casse nella nuova tomba di cemento dove staranno, ha spiegato Emilio, in perpetuo. È un termine tecnico. Strano mestiere fare il campanaro, cioè quello che seppellisce i morti. Nascere, vivere, seppellire, morire nello stesso posto. Non usa quasi più.
È arrivato anche l’ufficiale sanitario, che si era fatto un po’ aspettare; mentre gli uomini sollevavano le casse, si è messo a farmi citazioni nell’orecchio, coi cipressi e le urne e altre delicatezze. Mi è venuto un impulso molto forte di dargli uno spintone. La tomba è profonda e cavernosa, quattro ripiani di cemento, un pozzo di cinque o sei metri. La sua di famiglia è due campate più in là.
Ma sì forse abbiamo fatto male a far fare questa tomba di lusso, questa tardiva “cappella gentilizia”. Anche i vicini sono lì in perpetuo. Non sarebbe stato meglio stare in terra, allo scoperto, dove stanno i pari dei nostri nonni e degli zii? L’idea era di far contento il papà, a cui piaceva tanto di sembrare un signòr; ma non siamo arrivati in tempo.
Emilio dirigeva il lavoro, prendendosi di persona la parte più pesante e rischiosa. Sono restato sorpreso delle fatiche che ci sono volute. Gli aiuti erano vecchi compaesani, dal più al meno miei coetanei, timidi, malmessi, con la barba non fatta: a mano a mano riconoscevo, stravolte, le personalità che splendevano in paese trent’anni fa. M’innervosiva quel lavoro con le corde, per bilanciare le casse, col rischio continuo di mettere un piede in fallo. Ho domandato se almeno sono assicurati, ma naturalmente è una domanda assurda. Una delle casse, più grande, ha stentato parecchio a passare per l’apertura, l’hanno dovuta spingere coi piedi. Emilio in equilibrio su un’asse ha sistemato qua la mamma e la cassettina della nonna, là il papà e la cassettina del nonno, e mi ha detto di ricordarmi, ma poi uno se ne scorda.
Gli ho dato un po’ di soldi per gli uomini; ha detto che erano troppi.
Prima che richiudessero è arrivato mio fratello più giovane coi suoi bambini, i futuri clienti della cappella gentilizia. Il piccolo Bepi correva lietamente attorno all’apertura, e pretendeva di andar giù subito. Gli abbiamo letti sulla lapide i nomi incisi dei suoi nonni e bisnonni; si è messo a fare delle aggiunte, sillabava scrivendo col ditino.
Abbiamo salutato gli uomini, evitando i pronomi. C’era un bel sole, e coi bambini siamo andati al Ponte a bere un bicchiere di bianco.
Capisco bene che non avendo conosciuto la rancura che ogni figliolo ha, mare, per il padre, non posso considerarmi un uomo completo. Io rancura non ne avevo, mare. Venuti i tempi in cui avrei dovuto cominciare almeno a seccarmi con lui, non cominciai. È vero che in una certa occasione avevo stabilito di ucciderlo, e per una faccenda di donne, ma sempre con stima e simpatia. Questo è il grave: mio padre mi era simpatico.
Forse c’entra il fatto che non ho mai chiamato i miei genitori pare e mare secondo l’uso dei vecchi. Appena finita la guerra una sera mio zio Dino passeggiando con me verso il Castello, si mise a dir male di mio nonno, in modo pacato, riflessivo, profondamente scandaloso – e lo chiamò me pare. Sentii che tra le nostre moderne abitudini verbali sormontava un modo antico e solenne, parlava per lui, caduti i veli, la lingua stessa: e mostrava mio nonno in una luce molto cruda, una maschera, un padre, da detestare per definizione.
Il giorno della soétta
Dopo il funerale di mio papà, siamo andati tutto il giorno in giro con le macchine un po’ a caso sui colli a Monte di Malo, a San Vito, a Priabona. Ci fermavamo qua e là per guardare dall’alto la pianura colle strisce di ghiaccio che scintillavano; ogni tanto si scendeva in una delle nostre case, e si stava insieme molto amichevolmente a chiacchierare del più e del meno. Era un pezzo che non passavo una giornata così bella. Ogni tanto andavo via, in qualche stanza vuota, dove ci fosse un letto o un divano, a singhiozzare un po’ di minuti; poi tornavo eagerly a chiacchierare con gli altri. Mio fratello più giovane sentiva più di tutti il sollievo che finalmente la cosa fosse accaduta. Ha sempre avuto in forma grave il complesso della neve fresca, quello sconforto che avvelena le ore in cui la neve sta fioccando, quando uno sa come va poi a finire. Gaetano si è sentito libero da questo rovello una volta sola, in alta montagna, per poche ore. Ha detto che da oggi comincerà per lui una nuova fase, l’attesa che muoia io che sono next. Ha detto che purtroppo è già cominciata. Ho raccontato le scene che ha fatto la zia Nina, che era next quando è morto il nonno; era uno spasso, spargeva quei lagrimoni di famiglia e gemeva «ora tocca a me», e ogni tanto faceva uno speciale strillo funebre che un inesperto avrebbe creduto espressivo soltanto di sé e invece voleva dire, letteralmente: “in questo preciso istante ho sentito la soétta: ahi che è venuta anche lei! è lì sul balcone! non c’è più niente da fare!”.
È un po’ assurdo in this day and age, ma la voglia di fare bella figura coi miei di famiglia è uno dei sentimenti più profondi che mi trovo ad avere. Perché mio padre non mi dicesse «va-là, insulso» (il più grave dei suoi rimproveri) mi sarei rassegnato a farmi deridere in prosa moderna da... No, aspetta, da lui no.
Mi sarebbe soprattutto piaciuto far bella figura in ciò che riguarda “i soldi”. In antico stavano nel cassettino della credenza, che non si teneva chiuso a chiave, ma era sacro e solo la mamma lo apriva. Alla fine del mese ci metteva il suo stipendio, e il sabato la settimana del papà; e anche ciò che le davano quando impegnava gli ori. C’era in famiglia una certa paura del danaro, inespressa.
In questi ultimi anni ho sentito di nuovo quanto era potente in un’occasione in cui volli strafare. S’avvicinava il momento dei conti estivi di fine-mese col papà: e mi venne in mente che con un po’ di sacrificio potevamo dargli alla fine una piccola somma in più per lui personalmente – e mi sentii assurdamente emozionato. Sono passati appena tre o quattro anni e già riesce incredibile che una somma quasi ridicola (mi pare che fossero cinquemila lire) potesse generare tale emozione. Quando venne il giorno, e venne l’ora – eravamo seduti intorno alla tavola dalle belle superfici di noce – le mie mani si misero a tremare con tanta violenza che il papà molto seccato mi domandò come mai. Venne una nota di disagio, si guastò tutto.
Di mia madre restano alcune cianfrusaglie; un libretto di devozioni in francese; una filotea italiana per la pia giovinetta, raccapricciante; l’opera omnia (o poco ci mancherà) di un dottore (...) che avevamo in paese, e che (...) a suo tempo anche lei; e tra poche altre cosucce, un sasso di media grandezza. Altro medical man: un chirurgo che si chiamava Patosni, l’uomo dai guanti bianchi. Il papà era in Africa.
Intravvedo il sasso e lo riconosco in mezzo ai pezzetti di merletto, le ricevute, le catenine spezzate, mentre sbrighiamo cassetti scatole di cartone pacchetti legati con spaghi; taccio a K. che non sa niente, destramente sottraggo il sasso di mia madre dal suo mucchietto di roba, lo metto nel mucchio dei rifiuti.
Per la nascita della sorella Elisa Esterina
Illustrissimo sig. Direttore, mia sorella nacque minuta, moretta, molto somigliante a me, e morta. Nella camera grande c’era la stufa a segatura: quando nasceva uno di noi papà la portava su e l’accendeva, siamo nati tutti d’inverno. La bambina era nella cuna di ferro smaltato, le sparangole abbassate. Le avevano messo una scuffietta coi ricami, sotto spuntavano i capelli lisci, umidi e mori.
Scrivevo sulla tualè, la mamma dettava, la carta da lettere sul foglio di carta sugante a righe, per guidare la mano, la Montegrappa col pennino di vetro arancione a spirale, mi pregio di informarLa che mia moglie, insegnante elementare nel circolo didattico di Malo, è costretta ad assentarsi dal lavoro per puerperio...
Il papà avrebbe potuto scriverla lui la lettera, ma io ero già più letterato; mentre solo la mamma padroneggiava quello stile ed era in grado di centrare le cose con una parola come puerperio.
Andai a guardare la bambina. Era graziosa e serena ed era impressionante quanto mi somigliava. La mamma aveva sul viso due lagrime fredde, deformi, che si erano raccolte sotto gli occhi. Eravamo stati tutti maschi finora, e l’idea che al mondo ci sono anche le bambine restava strana. Fu seppellita coi nomi di Ester Elisa, il papà le fece fare una piccola lapide, ma più tardi durante la guerra la cavarono su mentre noi si era a Vicenza e la buttarono via. Con dovuta osservanza.
Sopra un ritratto della madre seduta
Da giovane la mamma era snella ma prima di essere vecchia s’appesantì e camminava e si moveva con impaccio.
Prendeva un treno a Vicenza alle sei e mezza per andare a insegnare a Valdagno; una volta d’inverno che era tutto ghiacciato, all’imbocco del viale della stazione scivolò e si trovò seduta per terra. Non provò nemmeno a rialzarsi da sola. Era ancora buio, non passava nessuno; stava seduta in mezzo alla strada, in cappellino; i lampioni, be’, ardevano, noi a casa dormivamo, i chirurghi all’ospedale non facevano un bel niente, non c’erano nemmeno, a Monte Berico i frati stavano aprendo bottega con grandi sbadigli, la città rabbrividiva, era l’ora rosa e verde, salvo che era color pomice e ghiaccio; la mamma restò lì un gran pezzo finché arrivarono due operai che la tirarono su.
Quando tornò alla sera ce lo raccontò come un incidente un po’ fuori dell’ordinario, imbarazzante, ma in sostanza da ridere: già, questo è il punto dove uno potrebbe arrabbiarsi, al pensiero di quanto è inetta la nostra presente cultura a intendere le implicazioni di un dettaglio come questo. Occorre invece simpatizzare con le aspirazioni didattiche e sindacali delle nostre maestre più coscienti e impegnate – la Gabriella di Bruno, che è una maestra assai brava e (oltre a criticare il Risorgimento con più entusiasmo che mordente) si consuma a criticare se stessa, a torto; e d’inverno ha anche lei le sue difficoltà per andare a far scuola – quando va con la Mercedes parte male, e quando va con la spider slitta sul ghiaccio e fa un testa-coda.
Il papà che a quel tempo veniva a lavorare a Malo in bicicletta, partiva anche lui alla mattina presto, ma le cadute sul ghiaccio che raccontava erano solo quelle che faceva fare agli altri, i soliti insulsi che si mettono a ruota per farsi tagliare l’aria, punibili mediante l’uso sapiente e improvviso dei freni.
Sopra un altro della stessa con la gatta Plombe
Il papà lavorava in officina non molto volentieri ma senza lagnarsi; la mamma a scuola ancor meno volentieri, e naturalmente senza lagnarsi. Avrebbero ritenuto indecente fare commenti sulla vita che vivevano.
La mamma qualche volta diceva «Se ’l Signor me tolesse!» come per dire che sarebbe stato un grande favore; ma era detto in modo del tutto matter-of-fact (e mi accorgo scrivendo che c’era un idiotismo foresto in quel “Signor” senza la e finale: forse per questo la frase mi sembra così sua). Alla sera nella stagione buona, avanzavano alla mamma alcune ore senza occupazioni pressanti, mentre il papà era all’osteria, e noi figli al caffè o al passeggio. Si metteva a sedere sul portone della casa, che era l’ultima del paese; si portava lì una seggiolina bassa e stava a prendere il fresco (che in quel punto non è freschissimo ma non è male). Che pensieri le passavano per la testa? Ah, questo è il bello. Quei pensieri la mamma non li disse mai a nessuno, sarebbe stato inconcepibile...
Il gesto che disegnano sul muro le dita affusolate abolisce le bande dei gialli in cucina. Svaniscono in aria le smorzate candele. Il portico è buio, nel vano delle scale sono appese le pecchie rossicce, di nuovo il piccolo giro delle dita le cancella, le rigenera un istante trascorrendo, le annulla. La giornata è finita.
La bambina Lisetta ridice nel suo furlano che è venuta la sirene, è morta la pampadine. Parole dell’altra guerra, nuove allora, i piccoli le sbagliavano. Cose vecchie. Posare la seggiola nell’apertura del portone, mettersi un po’ a sedere. È più fresco qui, si riposa. Davanti arde l’ultima lampadina del centro, in su non ce n’è altre fino al bivio là in cima; in giù fanno un magro arco, scompaiono dove il Liston s’incurva. Passa poca gente, qualcuno saluta incerto, non ci si vede bene. Dietro è tutto buio.
Come siede sola la casa! Erano vivi poco fa il portico, la corte, le stanze, un recinto abitato, ora è come se da secoli non ci stesse più nessuno. Si spengono di colpo, questi luoghi murati in cui stiamo, non appena si cessa di animarli – là in cima alla corte costeggiando gli schermi che escludono gli orti e i campi, zona dei catenacci e degli scrocchi, portone scorribile dell’officina, se fuori splende la notte e s’intravvede per spiragli, il pensiero prende timidamente il volo e va a smarrirsi un momento là fuori, tra i gesti dei gelsi e i fiocchi notturni...
I ragazzi sono giovanotti, anche il piccolo non è più un bambino. Non si può aspettarsi che stiano qui a far compagnia, sarebbe imbarazzante. Si è fatta la propria parte, non resta quasi niente, non c’è molta soddisfazione personale. Certo era quello che si credeva di cercare, ma non è così che funziona. Si crede di vivere per scelte individuali – ora io vivrò così e adesso che sei vedova, alla mamma tornando dal funerale, l’Angelino puoi sposartelo tu. Pareva audacia inebriante, ma in fondo era solo per la libertà di rifare dal più al meno le stesse esperienze, il meccanismo era sempre lo stesso. Com’era quello scherzo scritto sul margine di un libro di scuola, per far invidia alla compagna del banco davanti, che diceva di volere andar suora? quasi per mostrarle che intensa vita e che scandaloso epitaffio preparava per sé l’autrice – Qui giace / Pia Canciani / uccisa da un infelice amore.
È curioso, queste cose non sono accadute a persone diverse, ma (siamo abituati a dire) alla stessa persona. Naturalmente si va a finire con la bambinetta su una terrazza che ha imparato a fare una frase, a-Pia-mumòn, il suo primo messaggio articolato alla patria del Friuli e al mondo.
Un disegno c’era, ma impersonale – è stato tracciato migliaia di anni fa, c’entra col fare le famiglie, il sogno è di farle adorne, coi vestiti dei balli che al mattino fanno sgranare gli occhi dei piccoli, un’armonia di cose gioconde e pensieri gentili – la vera realtà è tutt’altra, qui in paese quando dicono pensieri intendono dal più al meno dolori; dolori attivi, fondati sul dover fare le cose, una serie incessante di cose difficili, è stata una specie di guerra privata senza licenze. E del resto lo sapeva, la ragazza in piedi in fondo al cortile, dove stava l’albero che poi hanno tagliato; si stringe nel cappottino elegante (era inverno) guarda con espressione grave ed energica, e si vede che già sa come andranno le cose. Cap...