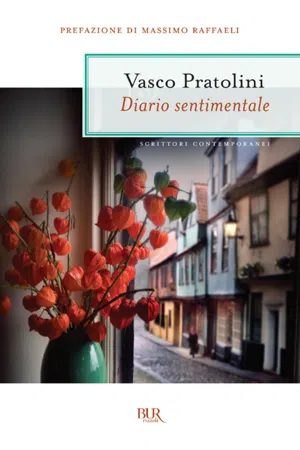![]()
Via de’ Magazzini
A Sandro Parronchi
![]()
Parte prima
Ho imparato a distinguere gli uomini l’uno dall’altro guardando dagli interstizi di una balaustra dentro una camerata di soldati. La scuola dirimpetto alla mia casa era trasformata in caserma, e siccome la strada era stretta – una delle strade medievali di Firenze che al centro della città formano come un’isola di silenzio – e i palazzi dirimpettai sembravano piegarsi l’un l’altro via via che ascendevano a tentare il cielo, i terzi piani della mia casa e della scuola diventavano come un unico appartamento: si sarebbe potuto, volendo, accedere da una stanza all’altra senza fatica. La mamma e la nonna indaffarate di primo mattino nelle faccende domestiche mi conducevano alla finestra, la cui balaustra era alta e invalicabile, dicendo: «Guarda i soldati e stai buono». Dal mio osservatorio vedevo una lista di camerata e in essa andavano e venivano soldati, si sedevano sulle brande, giocavano a carte, mangiavano in lucide gavette, parlavano ad alta voce in dialetti sconosciuti. Li credevo soldati diversi da quelli che vedevo per le strade, soldati in penitenza, e speravo di coglierli in misteriosi atteggiamenti di ribellione, invano. Qualcuno si affacciava alla finestra per osservare sulla strada, e subito si ritirava tra le grida dei compagni. Immancabilmente venivo scoperto dietro la balaustra; era un accorrere di soldati da più parti della camerata nel vano della finestra, come per una fotografia. Mettendosi le mani addosso, parlando a più voci si chiamavano: «C’è il bambino» diceva uno dapprima; e un altro: «Di già?», anche lui si presentava nel vano della finestra. Mi rivolgevano tutti i giorni le stesse domande se ora ricordo, ma io ero contento di loro come di un divertimento fuori dell’ordinario. Mi invitavano a cantare una canzone, e siccome era una canzone poco pulita io prima mi accertavo se la mamma e la nonna fossero veramente in cucina, e li accontentavo. Applausi sguaiati coronavano la mia prodezza; a compenso i soldati lanciavano dalla camerata nella mia stanza sacchetti di caramelle che immaginavo si procurassero apposta per me. Accadeva anche che la mamma mi sorprendesse a cantare e mi ritirasse per mano dentro casa, rimproverandomi. Ma dalla finestra grida di: «Viva la signora!» la richiamavano al balcone. Io debbo a quei miei amici soldati se posso ricordare la mamma che sorride. «Me lo abituate male» diceva. Il suo volto pallido, i lunghi capelli neri raccolti sulle spalle, gli occhi neri e verdi come perpetuamente attoniti – tutto il suo corpo di solito come chiuso in un’attesa, il suo naturale atteggiamento di donna giovane e stanca, si scioglieva dall’immobilità consueta in cui credo fosse impossibile sorprendere un qualsiasi proposito o muovere una cordialità. Era come se la mamma per un momento si liberasse da un’abitudine diventata natura per illuminarsi di una luce nuova: sembrava che quelle voci feste e volti di uomini soldati, giovani quanto lei o poco più, vent’anni, rimovessero la mamma dal fondo di una vasca in cui era adagiata supina, le si scomponevano le vesti in un alone emergendo: come nell’increspatura dell’acqua, le si disegnavano sul volto un sorriso, nel corpo un movimento a lei ignoti o dimenticati. I soldati parlavano a lungo con la mamma, io venivo trascurato, la costringevano a sollevarmi sulle sue braccia e dal suo sorriso mi nasceva una grande gioia. In un secondo momento, alcuni, forse consegnati, chiedevano alla mamma di comperare loro sigarette cartoline giornali, che so: prima e dopo gli acquisti, che la mamma faceva recandosi al mercato per la spesa, volavano da una finestra all’altra i denari, le sigarette, i giornali rinvoltati e legati con uno spago perché col peso sopportassero la distanza che ci separava traverso la strada. Intanto io imparavo a distinguerli l’uno dall’altro. Se qualche mattina tardavano ad accorgersi di me dietro la balaustra li chiamavo per nome, forse storpiandoli quei nomi, o salivo su una sedia e venivo fuori di tutta la testa gridando: Mensuali, o Palanti, o Celentano, o Nigri; ma colui che riconoscevo meglio degli altri era Cadorin, grasso e biondo, che sapeva fare il verso degli uccelli. Finché qualcuno partiva; io mi mettevo la mano sulle labbra imprimendovi un bacio e soffiando poi sulla palma perché il bacio gli giungesse: anche questo me lo aveva insegnato qualcuno di loro. Alla mamma promettevano di scrivere ed esigevano da lei la promessa di una risposta: a tutti la mamma faceva trascrivere il numero del reparto in cui il babbo, fante pure lui, era arruolato, e già al fronte, qualora lo avessero incontrato: «Ditegli che noi si sta bene, il bambino cresce. Che gli scriviamo». Nuovi amici apparivano la mattina dopo nella camerata.
Passarono due anni sulla guerra, i miei amici erano diventati tanti, qualcuno di loro tornava, a distanza di mesi, si dispiaceva se io non lo riconoscevo. Ma erano sempre più tristi i miei amici soldati, qualcuno scriveva veramente alla mamma come aveva promesso, e diceva che Mensuali era morto, che Celentano era ferito. La nonna cercava di ricordarsi precisamente di costoro feriti o morti, incitava la mamma al ricordo. La mamma era sempre più assente e distratta, rispondeva: «Sì, mi ricordo, certo»: aspettava tutti i giorni posta dal babbo, leggeva nervosamente una due volte la lettera che riceveva, sola nella sua camera forse la leggeva ancora, poi rientrava in salotto gettando la lettera sul tavolo, diceva: «Ha scritto»; ma non piangeva. Dalla finestra della camerata i nuovi amici lanciavano ora nella nostra stanza pagnotte e scatole di carne in conserva. Era la nonna che riceveva i doni. I soldati dicevano: «Fate la zuppa al bambino, noi ne abbiamo, non dubitate». (Due anni contano per un bambino, è cresciuto, capisce. Sa veramente cosa sia la guerra, ha imparato a fare a meno di molte cose che lo facevano contento. La mamma non esce più la mattina per la spesa, è la nonna che si alza presto e fa le «code». E un giorno, non più come un divertimento fuori dell’ordinario, dopo che la nonna ha parlato traverso il balcone con uno dei soldati dirimpetto, gli viene messa in mano, al bambino, una pentola di coccio, e lui sa già tutto: scende le scale, traversa la strada, si mette in fila con gli altri ragazzi e donne, alla porta della scuola-caserma, dalla parte opposta della sentinella, e aspetta. Compare uno dei suoi amici soldati, lo toglie dalla fila, gli prende la pentola, se ne va, ritorna, e nel recipiente c’è una minestra rassodata, forte di odore. Qualcuno dalla fila protesta, dice: «Ha il ciondolo d’oro quel ragazzo?»; un altro risponde: «Ha la mamma bella, ecco cos’ha!». La mamma è chiusa nella sua stanza, è stata malata la mamma, eppure la sera appare in salotto, dice alla nonna: «Febbre o non febbre, domani torno al laboratorio».) Ora stavo lunghe ore inginocchiato su una sedia a guardare dal balcone sulla strada l’andirivieni dei soldati, e a certe ore la coda dei poveri che aspettavano il rancio anche loro, in elemosina. Nella camerata i soldati apparivano e sparivano; qualcuno indugiava alla finestra, mi faceva appena un saluto con la mano, o diceva: «Come va oggi?» oppure: «Ha scritto il babbo?» o anche: «Vai a scuola?», e domande che esigevano un sì o un no in risposta: io avevo due anni di più e mi vergognavo dirgli che conoscevo una canzonetta poco pulita o chiedergli se lui sapesse fare il verso degli uccelli: non che non desiderassi più tutto questo, sentivo che sarei stato deluso se l’avessi chiesto. Un giorno riapparve Cadorin, salì in casa nostra, raccontò molte cose della guerra, rimase a cena con noi. Disse che era soltanto di passaggio e che sarebbe ripartito la notte stessa. Era dimagrito molto e così mi sembrava più bello. Disse anche di aver cercato il babbo e di essere arrivato in un certo paese poche ore dopo che il reggimento del babbo era ripartito per la prima linea. In suo onore fu riacceso il lume a petrolio che pendeva a metà del salotto, la casa sembrò per un attimo diversa da quella che mi ero abituato a conoscere di sera. Dissi: «Ecco che si distinguono i colori anche di sera», mi pareva di avere fatto una grande scoperta. Cenammo in salotto, al tavolo rotondo, sotto il lume a petrolio che mediante una catenella scorrevole si alzava e abbassava a piacimento. Cadorin era seduto fra me e la mamma: essa si provò ancora nel suo sorriso, ma fu come il sorriso di un malato che sa e cerca di illudere i suoi cari che non sia niente, e anche quello di compassione e pietà verso gli altri di una persona che ha sofferto e sofferto senza raggiungere la disperazione. La nonna andava e veniva dalla cucina; durante una di queste sue assenze il soldato disse alla mamma: «Perché non mi ha risposto?». La mamma indugiava con le dita sulle posate, alzando gli occhi disse: «Perché non c’era risposta» e sorrise alla sua maniera. Quando la nonna si assentò ancora per andare a prendere la pietanza, Cadorin disse: «La guerra a volte fa di questi scherzi. Si pensa a una cosa fissa lassù. E quando per gli altri, magari, si diventa degli eroi, ci si scopre in noi stessi più miserabili che mai. Ma basta un nulla a destarci».
Durante la malattia della mamma fui esiliato presso i parenti della periferia che avevano preso in affitto da poco tempo un appartamento delle case statali. Era una delle prime costruzioni del genere, ideata avanti guerra e portata a termine nei primi due anni di essa: due grandi caseggiati divisi da un cortile d’ingresso, di fronte al quale era posto il lavatoio comune; dirimpetto alle abitazioni, v’era una fila di piccoli orti, separati l’un l’altro da una rete metallica, e di spettanza dei singoli inquilini. Orti ben curati, come si conveniva, per una tacita gara che i coltivatori dilettanti avevano indetto fra di loro. Coltivavano pomodori insalate zucchine, e un angolo era riservato ai fiori. Nell’orto dello zio fiorivano in autunno alcuni crisantemi gialli. Era una comunità di un centinaio di famiglie. L’appartamento dello zio si trovava all’ultimo piano dell’estrema ala destra: una terrazza sugli orti, le finestre del salotto sul Mugnone, mentre le camere davano sulla strada, ancora acciottolata e deserta di case, sul lato opposto. All’orizzonte si vedeva di tanto in tanto passare l’unico tram che raggiungeva la zona rasente il Mattatoio. Di fianco a quest’ultimo, un sottopassaggio. Ogni casa ospitava dei bambini, ed io li raggiungevo nel viale degli orti e sulla strada. Era ancora guerra nel mondo, e ciascuno di noi aveva un uomo alla guerra che in casa ci additavano sulle fotografie perché imparassimo a volergli bene. Ebbi costì i miei primi amici che si chiamarono Mario, Renzo, Vanda, Corinna e Gualtiero. Un altro che fu molto intimo con noi in quel tempo si chiamava Giulio, ed era un bambino bruno ed esilissimo, credo di otto anni allora, che un giorno non scese sulla strada e negli orti: lo vedemmo circa un mese dopo sulle braccia della sua mamma, serrato dentro un’armatura tutta bianca, col collo eretto e il ciuffo nero dei capelli sulla fronte. Non so come ci scordammo di lui. Vanda e Corinna venivano con noi ragazzi disertando la compagnia delle bambine e trasgredendo alle raccomandazioni materne. Io sposai Vanda una mattina: era vestita di un grembiulino rosso a pallini bianchi e un grande fiocco celeste a farfalla sulla zazzera bruna; mettemmo casa in una buca del terreno sulla strada, e con stoviglie e posateria di stagno comperate in un bazar mangiammo molto spesso fili d’erba per pastasciutta e sassi bianchi come polpette, pane autentico e autentica frutta che portavamo da casa. Corinna e Gualtiero, che avevano sistemato il loro nido su un panchetto a ridosso del muro, venivano a farci visita dieci volte in un’ora, mentre gli altri amici, soldati ormai, perlustravano il terreno, vigilando sulla nostra felicità. Ma le donne rimanevano spesso sole, noi quattro ragazzi facevamo irruzione sugli argini del Mugnone in corse sfrenate verso qualcosa di preciso e di irraggiungibile. Le sere d’estate, con lo zio e le cugine, indugiavamo sul torrente guadabile senza paura, acchiappavo le lucciole che occhieggiavano a centinaia come in una festa, le cacciavo dentro un fazzoletto e appena a casa le imprigionavo sotto un bicchiere capovolto, sul comodino. La mattina dopo, secondo la leggenda, accanto ai loro poveri corpi spenti scoprivo alcune monete. Per acchiapparle correvamo loro incontro a mani tese, cantando:
Lucciola lucciola vien da me
ti darò il pan del re,
il pan del re della regina
lucciola lucciola fiorentina…
e serravamo la mano su una stilla di luce che allora allora s’era accesa nell’aria. Abitavamo quattro stanze: un salotto, la cucina e due camere. In una di queste dormiva solo lo zio nel suo letto di vedovo; nell’altra, la più spaziosa, le tre ragazze e io. Io dormivo con Abe che era tutta bianca nella gola, ed aveva i piedi sempre freddi, anche d’estate: fra gli scherni delle sorelle, coricate nel letto accanto, li rifugiava per riscaldarsi fra le mie cosce, raggomitolandosi fino a diventare lunga quanto me. Era una casa «moderna», e questo veniva vantato nei discorsi delle sorelle; la sera del mio arrivo mi sorprese il gabinetto con lo sciacquone, che nella nostra casa di città la nonna ricordava come un lusso e una meraviglia. C’era anche la cucina a gas che io non conoscevo. E nel salotto, che fu per molto tempo la mia corte dei miracoli, un grammofono con una tromba dorata nell’interno e celestina di fuori, come laccata. Nei pomeriggi, ma soprattutto in quelli della domenica, il grammofono era il deus ex machina della casa: persone, e cose anche, sembravano muoversi intorno a lui, tanta era l’agitazione che quella voce roca e quasi di bambino sperduto in una grotta, metteva addosso alle ragazze. Su una consolle era disposto un presepio, con le rocce i pastori le portatrici d’acqua e di pane, pecore cammelli, e i magi in adorazione della sacra famiglia raccolta presso una capanna, col bove l’asino e la mangiatoia: il Gesù sembrava la sola cosa finta, così nudo e roseo da farlo subito pensare di celluloide; e anche il cielo era azzurro, come fondale, con la cometa. In più, una sedia a sdraio che cullava allegramente. Il pianoforte da bambini, con due ottave di tasti, era in un angolo presso la fine-stra; e dappertutto, sui mobili sulle sedie sul pianoforte, cinque sei dieci bambolotti di pezza e di biscuit, acconciati da campagnole da soldati da apaches da napoletani: a cavalcioni sulla tromba del grammofono, una bambola più piccola dai capelli di canapa e la sottanina di danzatrice; una serie di gomitoli di lana, e in mezzo alla stanza un tavolo rotondo, con al centro disegnati i quadretti bianchi e neri per il gioco della dama.
Io venivo dal buio della mia casa di città, le nostre camere con l’alcova dietro le cortine verdi, pesanti, i nostri mobili invecchiati coi nonni, la nostra cucina fuligginosa per raggiungere la quale dovevamo scendere cinque gradini nel buio più profondo. La scialba luce del gabinetto di marmo giallo, con la ciambella di paglia appesa al muro e la sola presa d’acqua in tutta la casa nella parete, illuminava di giorno la cucina: di sera il lume a petrolio portatile, che la nonna collocava sul camino. (O nonna, quanti scartocci s’incrinarono per il calore dei fornelli, e tu li rivestivi di mastice, e poi andavamo a comperarli in quella lunga e fantastica bottega sul Corso, dalle interminabili vetrine ripiene di lumi di vetro istoriati e trasparenti: la calza era bagnata nel petrolio sempre meno, si alzava il lume in alto per accertarsi con sconforto del consumo della giornata, prima di coricarsi.) Nella sola stanza luminosa era la camera della mamma. In quegli anni della guerra (e il mondo era stanco e intontito di guerra, gli adulti avevano negli occhi un dolore che noi bambini non capivamo, eravamo sempre più trascurati, lasciati liberi di noi stessi, e per un nonnulla redarguiti come con odio da coloro a cui volevamo più bene; sentivamo dire, «ora o mai», «ora o è la fine»); in quelli che dovevano essere gli ultimi mesi della guerra, la mamma si spengeva nel suo letto di sposa: il babbo era alla guerra e io sentivo dire della mamma: «Già la gravidanza è disgraziata, che non le si aggiunga la spagnola, poveretta» quando la nonna accompagnava certe amiche alla porta, con gli occhi rossi di sempre, in un modo che nel buio della casa non distinguevo più le sue pupille ma due occhiaie rosse. E mai una lacrima, un momento di debolezza di pianto, che era ciò che aspettavo per dirle che avevo capito: la mamma moriva del bambino che stava per nascere. Vedevo la mamma pochi minuti nella giornata, al mattino e alla sera per darle il buongiorno e la buonanotte. La trovavo quasi sempre seduta nel suo letto di sposa, con i lunghi capelli neri disciolti sui guanciali che la sorreggevano. Si portava presso la sponda del letto per carezzarmi, mi baciava sulla fronte, poi io trovavo la sua guancia fredda e come opaca sotto le labbra. Siccome io e la nonna indugiavamo nella camera, e la nonna cercava di interessarla sulla mia giornata, essa si voltava di fianco, porgendomi la schiena, nascondendo così l’ammasso del ventre sotto le coperte (che era dove io mi proibivo di guardare vincendo ferocemente in me l’attrattiva che mi procurava) dicendo annoiata e stranamente implorante: «Sì sì mamma, ma portalo via». Una mattina la trovammo seduta vicino alla finestra. La nonna si preoccupò di lei ma essa rispose: «Sto meglio stamani. Anzi, lasciami il bambino mentre vai a fare la spesa». Mi fece sedere su un tappeto ai suoi piedi. Era seduta in angolo e guardava oltre i vetri del balcone che rendevano allo sguardo uno spicchio di cielo, la scuola-caserma di fronte, e fra le due facciate, in alto, i fili della luce elettrica. Assisa e come drappeggiata in un’ampia vestaglia bianca su cui il pallore del viso acquistava un che di creolo e di verde; luminoso e incorporeo il volto, eppure denso di sensi irresoluti e vinti, com’è di certe statue levigate dal tempo e dalla luce. Aveva mani lunghe ed esangui, l’ossatura appena accennata e le unghie spente come può essere spento un diamante, gocciate. Portò su di me lo sguardo, disse: «Perché mi assomigli così?». E poi: «Perché sei biondo allora?». Io non sapevo cosa rispondere, dissi: «Non so». Fu un lungo silenzio, passò un carro sulla strada, un robivecchi che gridava la sua presenza, un coro di soldati. La mamma chiese: «Ti hanno detto che avrai un fratellino? Gli vorrai bene?»; e siccome non rispondevo, disse: «Non volerglielo. Io non glielo voglio». S’era creata fra la mamma e il suo bambino una complicità assurda, della quale il bambino aveva paura. Essa mi carezzò sui capelli: «Eppure si fanno sempre più scuri. Forse la nonna ti mette l’acqua per pettinarti». Era una giornata di primavera, il sole appariva e spariva sul balcone, di tanto in tanto illuminava il grembo della mamma. Alle nostre spalle la camera appariva nell’oscurità, il letto, la specchiera; e dietro le cortine verdi, pesanti, dell’alcova indovinavo il mio lettino ove non mi coricavo ormai da alcuni mesi. Dormivo coi nonni, dietro l’alcova dell’altra stanza ov’era il salotto. La mamma mi domandò: «Cosa dicono i nonni la sera? Dicono che morirò?». Io avevo sempre più paura, non so di cosa, forse della mamma i cui occhi erano duri estatici, neri e verdi, fissi sui fili della luce elettrica. Ogni volta che una lingua di sole illuminava il grembo della mamma per sparire dietro la nuvola successiva, un brivido di freddo mi ghiacciava la schiena; se posavo distrattamente una mano sul piancito, al di fuori del tappeto dove sedevo, una nuova ventata fredda mi saliva dal ventre alle spalle, al cuore. Poi la mamma mi ordinò di sedermi sulle sue ginocchia, rivolto anch’io verso la strada: con un braccio mi cinse alla vita, disse: «Vedi il cielo lassù? Quando sarò morta sarò in quello spicchio di cielo lassù, e ti guarderò». Allora per la prima volta, e mai più, mi accorsi che piangeva. Piangeva come se parlasse, e le sue lacrime erano come la sua voce: lente, disperate ma senza violenza. E la sua voce, parlando, nelle lacrime, era ancora limpida e assorta. «Tu devi crescere, non devi pensare alla tua mamma» disse. Non avevo più paura in quel momento, abbracciai la mia mamma, baciandole piano e fitto fitto il pizzo della vestaglia sul petto. Un’altra mattina, entrando nella sua stanza, con la nonna, a portarle la colazione, la trovammo per terra svenuta. La nonna pose nelle mie mani il vassoio della colazione, si chinò sulla mamma e faticosamente la ricompose nel letto. Il volto della mamma era livido, gli occhi chiusi. Io che ero rimasto ai piedi del letto, con in mano il vassoio della colazione, intimidito e incapace di un gesto, vidi il suo collo stirato sul mento, il ventre enorme, il petto che sobbalzava precipitosamente via via che la nonna le sfregava le tempie ed essa riprendeva conoscenza. Finché un mezzogiorno pranzò con noi in salotto, indossava il tre quarti marrone, con la giacca aperta, s’era pettinata con le trecce a cercine sulla nuca, sembrò allegra perfino, si proponeva di uscire. La nonna aveva appena finito di sparecchiare che la mamma accusò brividi di freddo, si portò al balcone, al sole, ma non resse alla fatica di tenersi all’impiedi. Tornò a letto, dal quale non doveva alzarsi mai più: il parto di per sé infelice, il bambino nato morto, il male al seno, infine un attacco più forte e decisivo della febbre spagnola, il delirio nel quale invocava disperatamente mio padre e me, la morte. Ma già da quel giorno era stato deciso che io sarei andato ad abitare con lo zio e le cugine nella casa della periferia.
(So che la mia balia stava sulle montagne, in un paese sperduto degli Appennini, Rincine di nome. Mi era toccata in sorte una nutrice poco coscienziosa, che aveva anch’essa il marito alla guerra e l’ultimo nato di sei figli col quale dividevo il suo latte. Essa doveva badare alla sua poca terra, che non andasse in malora. Una notte la mamma sognò di essere venuta a visitarmi e di avermi trovato solo e piangente, nella casa di contadini, dimagrito, affebbrato, su un immondo letto entro il quale sguazzavo nei miei escrementi. Al risveglio il sogno la perseguitava, ne fece partecipe la nonna e con essa decisero di recarsi la mattina stessa al paese degli Appennini. La casa della mia balia era distante una diecina di chilometri dalla ferrovia e ci si arrivava percorrendo per metà cammino una mulattiera. Via via che si avvicinava alla casa la mamma era sempre più irrequieta e il sogno le appariva sempre più lucidamente come una realtà. La nonna faticava a starle dietro, nell’ultimo tratto la mamma la lasciò, affrettandosi da sola verso la casa. La nonna aveva da poco ripreso il cammino dopo essersi concessa un breve riposo al margine della mulattiera, quando vide la mamma di ritorno con in braccio il suo bambino che disse di aver trovato incustodito, lercio e sgomento come aveva sognato. Mi aveva preso con sé, respingendo a sassate la balia che le si faceva incontro dai campi. Il medico di città diagnosticò come grave la mia condizione. Pochi giorni dopo il babbo fu chiamato alle armi, io avevo il ghiaccio sulla testa e sul ventre, la mamma era addossata a una soglia come impietrita, la nonna piangeva su una sedia vicino al mio letto. Fu questa una scena dolorosa, vissuta e sofferta da quelle povere creature a cui debbo la vita, e rimasta come il momento esatto – lo schianto di una diga, il primo sasso che ruzzola dalla cima del monte e fa valanga – dello schianto e la dispersione della nostra famiglia. Il nonno mise le braccia attorno alle spalle del babbo, lo accompagnò fino al Distretto. La mamma dovette riprendere la direzione del laboratorio che aveva lasciato soltanto da pochi mesi allorché il babbo aveva trovato un’occupazione migliore. Essa si disinteressò a me affidandomi completamente alla nonna. Furono le cure tenaci della nonna che mi restituirono alla vita. A due anni ero tenero e flaccido come un neonato. Con una costanza che il suo affetto dipoi mi fa capire quanto tenace e caparbia, e quanto disperata, essa mi assisteva notte e giorno: mi coricava su una tavola di legno perché le ossa mi si irrobustissero, mi faceva massaggi di vino in tutto il corpo: si empiva la bocca di vino versandolo lentamente sulle mie membra e strofinandole. Da allora, quando io avrei incominciato a riconoscere la mia mamma, a dirle: «Mamma» e a sorriderle, data la sua avversione, il suo affetto disperato e inespresso per me: dalla partenza del babbo e dalla mia guarigione. Negli anni dipoi, fino alla sua morte, alla vigilia della quale essa sognò di uccidermi perché un’altra donna non avesse su di me i suoi diritti di madre, i miei rapporti con la mamma furono rapporti di convenienza e d’ossequio. Dormivo nel letto dietro l’alcova, e per lu...