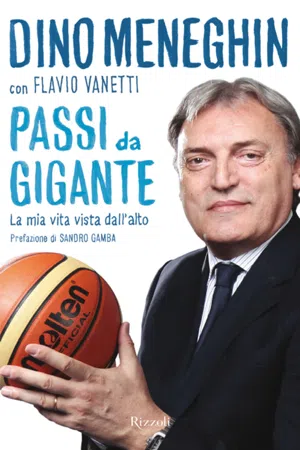![]()
1
Il discobolo cestista
Dieci. Venti. Trenta. Che palle… Sì, sì, pensate pure che per diventare un cestista di successo sia necessario essere alti, ben piazzati e, possibilmente, predisposti nella tecnica… A giudicare da quanto è capitato a me, occorre piuttosto dedicarsi all’atletica leggera. Specialità: getto del peso o lancio del disco. Poi succede che ti viene la nausea di quei gesti ripetitivi, che cerchi di fregare l’allenatore e che hai la fortuna, grazie anche alle combinazioni del caso, di imbatterti in un altro sport. Il tuo sport. Così la vita cambia, e scopri quello che nemmeno sapevi che esistesse.
Dieci, venti, trenta erano i lanci che riuscivo a completare allo stadio di Varese prima che non ne potessi più di quella sfera tanto pesante e di quell’altro aggeggio che mi faceva assomigliare a un atleta dell’antica Grecia. Lanciando il disco mi sembrava al massimo di appartenere a una scena ginnica illustrata su un vaso di terracotta: passione zero, divertimento idem, “mazzo” tanto, altro che storie. Però non c’era stato verso di sfuggire a quelle due discipline “ascetiche” e – così mi raccontavano – nobili.
Non c’era stato verso perché alle scuole medie avevo un insegnante di educazione fisica, il mitico professor Bellorini, una specie di istituzione per lo sport cittadino, autentico fanatico dell’atletica leggera. In prima media aveva cominciato a insegnarmi sia il getto del peso sia il lancio del disco. In seconda media, invece, la faccenda si era fatta seria perché ai campionati provinciali ero stato adocchiato dal professor Bresciani della Ginnastica Gallaratese. Preso e arruolato, assieme a mio fratello Renzo, che però era mezzofondista: da qualche parte, a casa, ho ancora la bellissima maglietta da gara, azzurra con un’aquila stilizzata e nel mezzo il marchio dell’Agusta, l’azienda sponsor.
Ecco, Bresciani è il responsabile delle mie tormentate sedute all’insegna di un continuo “lancia e raccogli”. Evidentemente sicuro di trasformarmi in un asso di entrambe le specialità, mi aveva preparato un menu di lavoro che avrebbe stroncato perfino un somaro: «Adesso andiamo allo stadio, ci piazziamo nella zona riservata a peso e disco e tu fai mille lanci». Però, una volta impartito l’ordine, il “prof” se ne andava via. E io mi impegnavo a fare il suo bravo allievo. Durava poco, come vi ho già detto. Ma come fare per salvare capra e cavoli ed evitare una sfuriata? Semplice: bastava usare un po’ di fantasia e di quell’estro che a Napoli hanno da vendere. Così, dopo trenta, massimo quaranta lanci, prendevo il “boccione” e, più o meno dove c’erano i vari punti di caduta, facevo tanti buchi nella sabbia. Io, uno stakanovista dei lanci… Ma in quale film? Però l’inganno era ben orchestrato e l’assenza del prof era fondamentale perché riuscissi a fregarlo senza che se ne accorgesse. «Ecco, ho finito…» E lui: «Va bene, bravissimo; ci rivediamo tra un paio di giorni». Non mi andava a genio l’atletica, si è capito?
Però peso e disco, se non altro, un merito l’hanno avuto: mi hanno aperto le porte dello sport, fino a quel momento a me del tutto sconosciuto. Sono nato ad Alano di Piave, in provincia di Belluno, e sono cresciuto nella frazione di Fener. A Varese giunsi nel 1958 quando mio padre, che lavorava nel settore degli occhiali, accettò la proposta di un’azienda di Besozzo. Ebbene, a Fener il massimo dello svago era giocare con gli amici in riva al fiume, suddivisi in bande per età. Il divertimento era costruire capanne con rami e foglie, l’una diversa dall’altra. Noi, più piccoli, riuscivamo a costruirne solo di quadrate, mentre i grandi, tra i quali c’era mio fratello, arrivavano a realizzarne pure di rotonde, con il basamento ben scavato: erano bellissime e invidiate da tutti. Una vita genuina ma semplice e circoscritta: quando la memoria me la ripropone, riesco ad apprezzare il grande dono fattomi dalla pallacanestro. E non parlo solo delle vittorie e dei grandi risultati.
Un esempio? A Fener c’era un bambino ritardato. Senza mezzi termini, per tutti era lo stupido del paese. Un giorno del 1956, mentre i carri armati sovietici facevano il loro ingresso a Budapest per soffocare nel sangue la rivoluzione ungherese, sua madre aveva messo delle zucche ad asciugare al sole. Noi stavamo giocando lungo il Piave, quando il ragazzo uscì di casa strepitando e prendendo a calci gli ortaggi: «Ecco, sono arrivati i sovietici…». Un disastro. Per le zucche e per se stesso: la madre lo riempì di botte. Lì per lì, data l’età, non riuscivo a correlare bene le zucche, l’Urss e la storia. Ma ogni volta che il basket mi ha portato in Unione Sovietica, quell’episodio mi è tornato in mente. La pallacanestro mi ha costretto a girare per l’Europa e per il mondo già all’età di sedici anni, dandomi la possibilità di conoscere popoli, tradizioni, problemi e guasti della politica, scenari e situazioni che, se non mi fossi recato sul posto, magari mi sarebbero scivolati via con superficialità. Non smetterò mai di pensarlo e di dirlo: il basket, prima di tutto, mi ha arricchito come uomo.
È giunto così il momento di raccontare l’incontro fatale. Era l’inverno a cavallo tra il 1962 e il 1963, a Varese c’erano i campionati studenteschi di pallacanestro. Anche la mia scuola vi partecipava e l’allenatore dei cestisti era il professor Nicola “Nico” Messina, che lavorava anche per la Ignis Varese. Andai a tifare assieme a un caro amico, Giancarlo Spissu: mio padre, per incentivarci a fare chiasso, ci dotò di quei campanacci che si mettono al collo delle mucche. La palestra della scuola “Giovanni Pascoli”, sede degli incontri, mi pareva un’arena da ventimila posti. Trent’anni dopo, capitando lì di nuovo, mi resi conto che si trattava di un “buco” terribile. Emozioni e suggestioni di un novizio e aspirante tifoso… Bene, eravamo lì a fare macello e dal momento che ero già un metro abbondante più alto degli altri, Messina non mancò di notarmi. «Ehi, ma tu hai mai giocato a basket?» mi domandò a bruciapelo. Risposi balbettando un «No, non ho mai provato…». Neppure il tempo di biascicarlo ed ecco l’ordine: «Allora, prova a correre. Sì, fammi vedere come corri. Tieni pure addosso il cappotto…». Non mi misurò nemmeno, però voleva che corressi con il cappotto! Feci due o tre volte l’avanti-indietro per la palestra, quindi emise il verdetto: «Va bene, basta così. Torna domani pomeriggio con le scarpe da basket: comincerai subito gli allenamenti».
Adesso mettetevi un attimo nei miei panni: riuscite a capire quanto fossi stralunato? Io non sapevo nemmeno che cosa fosse la pallacanestro e l’indomani avrei dovuto iniziare a giocarla… E che dire ai miei? Come avrebbero accolto la novità? Avevo la mente che turbinava, la testa mi girava come se fossi su una giostra. Arrivai a casa: dalla “Pascoli” c’era un bel pezzo di strada e non mi era mancato il tempo per gustare, da un lato, la soddisfazione di aver superato quel provino estemporaneo e per vivere, dall’altro, le apprensioni dell’ignoto da affrontare. «Ciao mamma, mi serve subito un paio di scarpe da basket…» «Dino, che cos’è il basket?…» Pensai: siamo a posto, cominciamo bene. Però la povera donna non fece altre domande, salì sul primo autobus – averne, di madri così… –, andò in centro, comperò le scarpe e tornò a casa. Erano delle splendide Superga… rosse. Cioè il colore del Simmenthal Milano, che ancora ignoravo fosse lo storico avversario della Ignis.
Così il giorno successivo, quando mi presentai tutto baldanzoso all’allenamento delle giovanili della Ignis con quelle “armi” che ricordavano il nemico, Messina mi scrutò dalla testa ai piedi, anzi al contrario, e con molta calma disse: «Ok, la prima cosa da fare è cambiare le scarpe». Fu così gentile da spiegarmi le ragioni… Consapevole della figuraccia e grato perché non c’erano state conseguenze, affrontai con animo sollevato il momento successivo: quello delle presentazioni ai compagni. Nico decise di assegnarmi, con mentalità un po’ militaresca (e lui soldato lo era stato per convinzione e cocciutaggine, essendo scappato ben sette volte da casa prima di riuscire a farsi arruolare nel Regio Esercito), a una sorta di tutore, Momi Bozzolo, che sarebbe diventato il mio miglior amico di quell’epoca. «Questo è Dino: dovete socializzare e giocare assieme.»
Perché proprio lui? Perché Momi era alto quasi come me e quindi si accompagnava bene negli esercizi a due. Il problema fu che, alla faccia della neonata quanto forzata amicizia, non appena Messina voltò le spalle, Bozzolo se ne tornò dagli altri. Io rimasi lì come un interdetto, senza sapere che cosa fare. Sospinto da un briciolo di intraprendenza, afferrai un pallone e provai a palleggiare. Ma ero grezzo e grossolano. Palleggi? Parola grossa. Semmai erano “stantuffate” di un pistone dentro un motore. Nico se ne accorse, mi fermò e mi disse una frase tanto semplice quanto inequivocabile: «No, non si fa così». Prese la palla e mi illustrò la tecnica corretta.
Il mio corso accelerato di basket – gli altri erano ben più avanti di me; anzi, loro sapevano già gioca-
re – cominciò in questo modo, sotto l’amorevole ala di un allenatore che dava l’impressione di coccolarmi e di volere solo il mio bene. Il bello del suo insegnamento stava nella capacità di non forzare nulla. Se aveva un progetto su di me, era stato bravo a celarmelo e a portarlo avanti sotto traccia. Capivo però che aveva intuito le mie potenzialità di atleta: era colpito in particolare dal mio equilibrio corporeo. Tant’è che in breve mi convinse a frequentare, extra allenamenti, la piccola palestra in città in cui dava lezioni di ginnastica un po’ a tutti, anziani inclusi. Essendo stato in precedenza completamente digiuno di sport, avevo spesso i crampi: allora lui mi massaggiava le gambe con l’acqua saponata per sciogliere i muscoli. Pian piano mi introdusse agli esercizi di rafforzamento, usando i pesi: insomma, avevo imboccato la strada giusta per diventare un vero giocatore.
Dopo un anno intero passato a digerire i “fondamentali”, ero più o meno alla pari dei compagni. In una delle mie prime partite giocammo a Cairate contro la squadra della locale cartiera. Ambientazione indimenticabile. Era gennaio, il campo era all’aperto. Mio padre era venuto a vedermi con la sua Fiat 124 familiare, che fungeva anche da pullman sociale aggiunto (quello ufficiale, si fa per dire, era l’auto del prof Messina) e da “panchina” di rimedio. Funzionava così: il quintetto titolare stava ovviamente in campo, e fuori faceva un freddo becco. Le riserve, invece, erano sedute in macchina e tenevano il mangiadischi a tutto volume. Quando il coach urlava “cambio”, si saltava fuori e si prendeva il posto del poveraccio, che intirizzito tornava a riscaldarsi.
Devo ammettere che il mio inserimento in squadra non era stato affatto difficoltoso. E neppure la mia altezza, per l’epoca davvero fuori del comune, aveva costituito un ostacolo o un motivo di sfottò. Anzi, semmai un problema lo era stato da bambino. Sono sempre stato il più alto della brigata degli amici e anche della classe, ai tempi della scuola. La regola per l’abbigliamento era la stessa in voga anche oggi in tante famiglie: il figlio minore rileva gli abiti dismessi dal fratello maggiore. Ben presto, però, fu Renzo a indossare i miei: quando avevo i picchi di febbre, io crescevo addirittura di cinque centimetri per volta. Vestire il fratellone era motivo di orgoglio, almeno fino al momento in cui nostra madre ci portava al cinema: Renzo pagava il ridotto, io il biglietto intero. Mi arrabbiavo e piangevo. Ripensando al mio rapporto con una statura ben oltre la media, era quello l’unico momento di crisi.
Non sono mai stato come Massimo Lucarelli, mio grande amico e compagno di tante partite nella Ignis. Lui sì era suscettibile e, nelle risposte, a volte poco diplomatico. Per esempio, accadeva che qualcuno se ne uscisse con la frase scontata: «Che aria tira lassù?». Io non ci facevo caso, anche perché ero sicuro che non ci fosse mai cattiveria in quelle battute: per dirla tutta, non ho mai avuto la sensazione che qualcuno volesse prendermi per i fondelli. Lucky, invece, s’innervosiva. Una volta sbottò: «Qui l’aria è ottima e fresca. Sotto, invece, non so: ho appena scoreggiato…». Il malcapitato girò i tacchi non per la puzza (che non c’era, perché Massimo s’era inventato tutto), ma per la risposta brusca.
A ben vedere, sono solo due gli episodi nei quali i miei due-metri-e-zero-quattro sono stati presi di mira. Il primo durante un allenamento, quando Franco Passera, coach delle giovanili della Ignis, una volta mi chiamò in questo modo: «Ehi, lungo, vieni qui». Gli saltai in testa («Guarda che mi chiamo Dino!») e lui abbassò le orecchie: «Ah, sì, bene…». Il secondo risale alla frequentazione dell’istituto per geometri. Giocavo già a basket, ma non avevo ancora lasciato l’atletica leggera. Risultato: troppe assenze a scuola, soprattutto a causa delle trasferte imposte dalla pallacanestro. Alla fine persi quell’anno, ma prima che accadesse l’irreparabile fui convocato spesso dal preside. La prima volta lasciai di stucco la segretaria. E lei, obiettivamente, lasciò di stucco me. «Caspita, lo sai che sei alto come gli extraterrestri che di tanto in tanto incontro?» Avevo capito bene, oppure sognavo? Extraterrestri, incontri con loro?… Non ebbi modo nemmeno di allibire: «Sì, sono in contatto con loro: arrivano, mi trasferiscono su un’astronave e infine mi riportano sulla Terra. Sono alti come te, anzi, perfino più alti: sono dei gigantoni…». All’epoca un po’ mi spaventai e credetti che fosse matta. Oggi, invece, approfondirei la questione…
Comunque sia, avrete capito che il mio incontro ravvicinato con il basket – tanto per restare in tema di alieni – è stato piuttosto vario e movimentato. A questo proposito vi devo anche raccontare come andò la prima volta che mi imbattei nei giocatori della prima squadra della Ignis, quella che disputava il campionato di serie A. Io ero un ragazzotto, loro erano già affermati e famosi: era inevitabile che fossi intimorito. Mi cambiai in bagno, di nascosto: non volevo farmi vedere nudo o con le mutande in mano. Quando uscii, tutto silenzioso e timido, mi ritrovai nello spogliatoio mentre uno grande e grosso, tale Sarti, faceva l’elicottero con il suo uccello, urlando a squarciagola. Confesso: fu un trauma.
Però ci voleva ben altro, a quel punto, per fermarmi. Il basket mi aveva già stregato, e vi assicuro che all’inizio non fu per il gioco in sé. Mi aveva affascinato semmai la meravigliosa confusione di quel primo allenamento alla “Pascoli”: caos, rumore, casino collettivo. Mi aveva colpito il sistema: venivo dalla “rottura di palle” del peso e del disco, lì invece mi sembrava di stare dentro una festa. Ero tornato al clima dell’oratorio, e poi c’era Nico Messina che mi motivava: mai un rimbrotto, solo tanti consigli e pacche sul sedere a mo’ di incoraggiamento. Ore e ore a insegnarmi come fare canestro, come giocare in modo dinamico e plastico: anche adesso che purtroppo non c’è più, in cuor mio continuo a ringraziarlo.
Tutto è partito da un pavimento di linoleum verde, dal “profumo” dell’allenamento e da un senso di gioia pura. Da quel momento in poi, ogni cosa si sarebbe rivelata una novità pazzesca: vivevo ogni istante come un’opportunità per aprire una finestra su qualcosa di mai provato prima. Ed ero consapevole di essere diventato un atleta, dopo il “livello zero” di sport praticato alle elementari e dopo un’educazione fisica, alle scuole medie, fatta solo di marce ed esercizi alla spalliera e alla cavallina. Pensate che la palestra di quella scuola era la “XXV Aprile”, cioè l’impianto in cui all’epoca giocava la Ignis. Ecco, nel tempio della pallacanestro varesina nessuno mi aveva mai detto: prova con il basket. Quando ci ripenso, non ci credo.
* * *
Questo è stato il mio inizio. Da allora la pallacanestro è diventata un’esperienza sempre più coinvolgente, anche se non avrei mai immaginato di avere una carriera così ricca di soddisfazioni e, soprattutto, così lunga: ho smesso a quarantaquattro anni, nel basket ad alto livello credo di essere stato un primatista. Di sicuro ho superato Kareem Abdul-Jabbar, uno dei più grandi cestisti della storia: lui ha lasciato a quarantadue, dunque l’orgoglio supplementare della mia storia sportiva è di aver tenuto duro più di un collega leggendario. Anzi, in verità i motivi per essere fiero sono due. L’altro è l’essere riuscito a giocare contro mio figlio Andrea, a sua volta diventato un nome importante della nostra pallacanestro: è accaduto nella stagione 1990-91, quando io vestivo la maglia di Trieste e lui era alle prime armi con quella di Varese.
Giocavamo in ruoli diversi – io sono alto 2 metri e 4 centimetri ed ero “centro”, cioè l’uomo di punta nella lotta sotto canestro; Andrea, invece, è 2 metri ed è stato un esterno, posizione guardia o ala a seconda delle esigenze, dalla grande reattività atletica –,
ma le emozioni furono forti. Che cosa ho provato quel giorno? Le sensazioni sono state due. La prima: forse per la prima volta mi sono sentito vecchio. La seconda: avevo paura che gli potesse accadere qualcosa, magari che incassasse un brutto colpo; per questo motivo non riuscivo a staccare gli occhi da lui. Non ero un avversario, ma, appunto, suo padre. Solo suo padre. Alla fine vinse la mia Stefanel, ma del risultato non m’importava nulla: corsi da Andrea, lo abbracciai e lo strinsi a me.
Di solito le autobiografie partono da ricordi indimenticabili e questo lo è senza ombra di dubbio. Tuttavia non voglio correre il rischio di apparire scontato e un po’ trombone, e così in questo libro mi racconterò in modo inedito: lo sapevate ad esempio che la Ignis Varese degli anni Settanta era uno squadrone non solo nel conquistare scudetti e coppe ma anche nel combinare scherzi grazie ai suoi “ragazzacci”? E nessuno vi ha mai detto che lo stesso spirito ha animato, in modo insospettabile, la Nazionale in cui ho avuto la fortuna di giocare per ben quindici anni? Sono solo due dei tanti episodi che vi racconterò.
Dunque un Dino Meneghin “segreto”? Sotto un certo aspetto, sì. Diciamo che voglio narrare quanto ho vissuto da un punto di osservazione privilegiato: il mio. Saprete tutto (o quasi) dell’atmosfera dello spogliatoio, degli allenamenti, di che cosa c’è dietro una partita sul piano emotivo, delle trasferte grazie alle quali ho visitato il mondo, del rapporto con i compagni e con gli avversari, delle grandi vittorie e delle cocenti sconfitte. E in più vi presenterò personaggi che sono sconosciuti al grande pubblico ma che hanno avuto un ruolo chiave nella mia avventura: uomini semplici e al contempo carismatici, oltre che amici autentici. Anzi, quasi dei genitori aggiunti, se devo pensare a Marino Cappellini e Sandro Galleani: si sono occupati dei miei muscoli a Varese e, nel caso di Sandro, anche in Nazionale; ma da loro ho avuto spesso anche consigli paterni e straordinarie testimonianze sul piano umano.
Prometto, nei limiti concessi dalla memoria (non è colpa dell’età che avanza: la verità è che ne abbiamo combinate di tutti i colori e nessuno ne ha tenuto il conto!), di narrare tutto e senza reticenze: farò in modo che possiate entrare nel mio passato e nel mio presente, diventato molto importante perché il 7 febbraio 2009 sono diventato presidente della Federbasket, esperienza che da un lato rappresenta una responsabilità enorme – il movimento conta migliaia e migliaia di tesserati ed è fondato su una “piramide” a più livelli; inoltre ci sono tanti adempimenti burocratici da assecondare – ma che dall’altro chiude e completa un percorso.
Prima di sciogliermi in ricordi e aneddoti e, mi auguro, prima di regalarvi qualche risata, devo essere serio. E diventare, soprattutto, una specie di Wikipedia di me stesso. Se guardo ai numeri che certificano quanto ho combinato sul parquet, mi impressiono e un po’ mi vengono i brividi. Dunque: tra campionato e Coppa Italia ho giocato 836 partite, segnando 8580 punti. In maglia azzurra, invece, conto 271 presenze e 2847 punti. Per due volte, nel 1980 e nel 1983, sono stato eletto Mister Europa da vari referendum, e mi dicono di essere anche stato, in assoluto, il secondo cestista del Vecchio Continente a interessare i professionisti della Nba.
Erano anni nei quali la separazione tra la pallacanestro dilettantistica e quella “pro” era netta, per cui posso dire di essere stato in qualche modo un precursore di quanto sarebbe accaduto dopo il passaggio ai Phoenix Suns del bulgaro Georgi Glouchkov, mio avversario quando giocava a Caserta: ovvero, l’abbattimento definitivo del muro che divideva le due anime del basket mondiale. Il primo europeo a giocare nella Nba fu, nel 1981, a Portland, l’islandese Gudmundsson; il buon “Giorgio” fu il secondo. Ma io sono felice di aver aperto la strada a entrambi e a tanti altri che li hanno seguiti.
Dicevo, l’occasione (più teorica che pratica e poi mai concretizzatasi) prese corpo nel 1970: l’allora manager degli Atlanta Hawks mi scelse in quelle selezioni. Ero una delle ultime scelte, forse del quarto o del quinto ordine di chiamata – oggi, invece, ci si ferma a due – ed era evidente che sarebbe morta lì. Ma dopo quelle avvisaglie di interesse, qualcosa di più c’è stato: nel 1974 sono stato a New York, interpellato dai famosi Knicks. Colloquio cordiale con il general manager Red Holzman e con i dirigenti, ma nessuna illusione: non avevo una vera chance. Peraltro, per lanciarmi nell’avventura americana avrei dovuto dire addio alla Nazionale: secondo le regole dell’epoca, infatti, il salto nei pro non prevedeva ritorno, dunque non avrei mai più indossato l’azzurro. Un ulteriore scrupolo che avevo era quello di dover lasciare Varese: si era nel momento d’oro della Ignis e la città era in subbuglio di fronte alla possibilità che abbandonassi la squadra. Meglio così, insomma, anche se un po’ di rimpianto, nel profondo, mi è rimasto. Ero stato inviato dai Knicks a partecipare con loro almeno alla Summer League di quell’anno, ma dovetti rinunciare anche a quello perché, come racconterò meglio più avanti, mi ruppi il menisco all’ultima di campionato.
Però l’America me la sono ripresa con gli interessi il 5 settembre 2003: quel giorno sono stato ammesso alla Hall of Fame di Springfield, nel Massachusetts, l’arca della gloria del basket: in quel museo sono ricordati i più grandi di sempre, con tanto di esposizione delle rispettive “memorabilia”. Nella Hall of Fame ho seguito Cesare Rubini, cestista di valore (ma anche eccellente pallanuotista e olimpionico nel 1948 con il “Settebello”), allenatore e manager del Simmenthal Milano degli anni Cinquanta e Sessanta e poi grande dirigente anche della Nazionale, e ho preceduto l’ex commissario tecnico Sandro Gamba, uomo a sua volta del “Simm” che è poi venuto a Varese e mi ha allenato nelle sue qua...