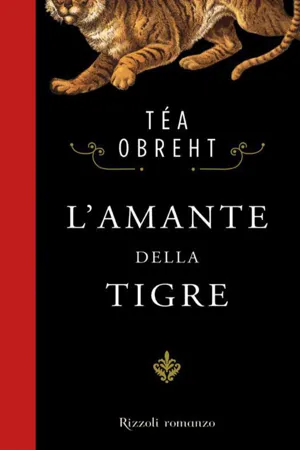![]()
Capitolo uno
La costa
I quaranta giorni dell’anima iniziano il mattino dopo la morte. La prima notte, quando i quaranta giorni non sono ancora iniziati, l’anima giace sui guanciali sudati e osserva i vivi che intrecciano le mani e chiudono gli occhi, inondano la stanza di fumo e di silenzio per tenere la nuova anima lontano dalle porte, dalle finestre e dalle fessure del pavimento, perché non scappi via. I vivi lo sanno, all’alba l’anima li lascerà e si dirigerà verso i luoghi del suo passato – scuole e dormitori della giovinezza, caserme e appartamenti, case rase al suolo e ricostruite, luoghi che sanno di amore e di colpa, disgrazie e felicità, ottimismo ed estasi, bei ricordi di fortune trascorse privi di senso per chiunque altro, e talvolta questo viaggio porterà l’anima tanto lontano, per così tanto tempo, che essa dimenticherà di fare ritorno. Per questa ragione i vivi sospendono le loro abitudini: per dare il benvenuto allo spirito appena staccatosi dal corpo non faranno le pulizie né il bucato, non riordineranno e non sposteranno le cose appartenute all’anima per quaranta giorni, sperando che la nostalgia la riporti a casa e la solleciti anzi a tornare con un messaggio, un segno. Con il perdono.
Se l’anima sarà evocata nel modo giusto, con il trascorrere dei giorni tornerà a frugare nei cassetti, a sbirciare nelle credenze, a cercare il piacere tattile dell’identità che aveva in vita, sfiorando lo scolapiatti, il campanello, il telefono, ricordando a se stessa la loro funzione, toccando gli oggetti per produrre un rumore e rendere nota la sua presenza agli abitanti della casa.
Parlando sottovoce al telefono, la nonna mi ricordò tutto questo dopo avermi informato della morte del nonno. Per lei i quaranta giorni erano un fatto scontato, una conoscenza acquisita dall’aver sepolto due genitori e una sorella più grande, vari cugini e sconosciuti della sua città natale, una formula che aveva recitato per consolare il nonno ogniqualvolta lui perdeva un paziente cui si era dedicato in modo particolare – una superstizione, secondo il nonno, eppure vi aveva ceduto protestando sempre più debolmente, man mano che la vecchiaia rafforzava le convinzioni della nonna.
Era sconvolta, la nonna, perché eravamo state derubate dei quaranta giorni del nonno, ridotti a trentasette o trentotto dalle strane circostanze della sua morte. Se n’era andato in solitudine, durante un viaggio lontano da casa; lei non sapeva che era già morto mentre il giorno prima stirava i suoi abiti o lavava i piatti della colazione, e non riusciva ad accettare le possibili conseguenze spirituali di quella sua ignoranza. Era morto nella clinica di un’oscura cittadina chiamata Zdrevkov, dall’altra parte della frontiera. Nessuna delle persone con le quali la nonna aveva parlato sapeva dove fosse Zdrevkov, e quando lo chiese a me, le dissi la verità: non avevo idea di come e perché il nonno fosse capitato là.
«Menti» disse.
«No, Bako.»
«Ci ha detto che stava venendo da te.»
«Impossibile» insistetti.
Mi resi conto che il nonno aveva mentito a tutte e due. Approfittando del mio viaggio attraverso il Paese se l’era svignata – una settimana fa, mi stava raccontando la nonna, in autobus, subito dopo la mia partenza – ed era sparito per qualche ragione che nessuno di noi conosceva. Il personale della clinica di Zdrevkov aveva impiegato ben tre giorni a rintracciare la nonna, ad avvertire lei e mia madre che il nonno era morto e quindi a provvedere alla spedizione del cadavere. Il corpo era arrivato all’obitorio della Città il mattino stesso, ma a quel punto io ero ormai a seicento chilometri da casa, nella toilette pubblica dell’ultima stazione di servizio prima della frontiera, incollata al telefono a gettoni, i calzoni arrotolati, i sandali in mano, i piedi nudi che scivolavano sulle piastrelle verdi sotto il lavandino rotto.
Qualcuno aveva fissato al rubinetto una canna che, appesa ai tubi dello scaldabagno, sputava sottili rigagnoli sul pavimento. Doveva perdere da ore: c’era acqua dappertutto, dalle piastrelle fino ai bordi del gabinetto alla turca, per arrivare alla soglia e al giardino disseccato sul retro della baracca. Niente di tutto questo sembrava turbare minimamente l’addetta alla pulizia dei bagni, una donna di mezza età con un foulard arancio annodato sui capelli, che avevo visto in un angolo appisolata su una sedia. L’avevo allontanata dal locale con una manciata di banconote, spaventata, prima ancora di sollevare la cornetta, dal pensiero di cosa potessero significare quelle sette chiamate della nonna sul cercapersone.
Ero furiosa con lei perché non mi aveva detto che il nonno era partito. Lui aveva raccontato alla nonna e a mia madre di essere preoccupato per la mia missione umanitaria – dovevo praticare le vaccinazioni ai bambini dell’orfanotrofio di Brejevina – e così aveva deciso di venirmi in aiuto. Ma non potevo rimproverare la nonna senza tradirmi, perché se lei avesse saputo della malattia che il nonno e io le avevamo tenuto nascosta di certo mi avrebbe informata della sua improvvisa partenza. Così la lasciai blaterare, senza dirle che tre mesi prima, quando il nonno aveva scoperto di essere ammalato, l’avevo accompagnato all’Accademia Militare di Medicina, e l’oncologo, suo collega da una vita, gli aveva mostrato le radiografie. Il nonno, posando il cappello sulle ginocchia, aveva detto: «Cazzo, cerchi un moscerino e trovi un asino!».
Infilai altre due monete nella fessura e il telefono emise un ronzio. I passeri si tuffavano dalle mensole di mattoni delle pareti del bagno nelle pozzanghere ai miei piedi e si spruzzavano d’acqua agitando le ali. Fuori il sole rovente condannava all’immobilità le prime ore del pomeriggio. L’aria calda e umida mi aveva seguito fin dentro il locale, vibrando sulla soglia della porta che dava sulla strada, dove, al controllo doganale, le auto si accalcavano in una fila compatta sull’asfalto scintillante. Vedevo la nostra macchina, il fianco sinistro ammaccato dal recente scontro con un trattore, e Zóra seduta al volante, la portiera aperta, un piede a terra, lo sguardo che saettava in direzione del bagno sempre più spesso, man mano che la macchina si avvicinava alla guardiola dei doganieri.
«Hanno telefonato ieri sera» stava dicendo la nonna, a voce sempre più alta. «E io ho pensato: si sono sbagliati. Non volevo chiamarti finché non ne fossimo state sicure, non volevamo farti preoccupare nel caso si trattasse di un altro. Ma tua madre questa mattina è andata all’obitorio.» Rimase in silenzio, e poi: «Non capisco, non ci capisco niente».
«Neanch’io, Bako» ammisi.
«Stava venendo da te.»
«Non lo sapevo.»
Poi il tono della sua voce cambiò. Si fece sospettosa, perché non piangevo, perché non ero isterica. Per i primi dieci minuti di conversazione, probabilmente aveva deciso di credere che la mia calma fosse dovuta al fatto che mi trovavo in un ospedale straniero, in servizio, circondata da colleghi. Se avesse saputo che mi nascondevo nel bagno di una località di frontiera per non farmi sentire da Zóra mi avrebbe sfidata dal primo momento.
«Non hai niente da dire?» tuonò.
«Non so proprio, Bako. Perché avrebbe dovuto mentire e dire che veniva a trovare me?»
«Non hai chiesto se è stato un incidente» continuò. «Perché non me l’hai chiesto? Perché non hai chiesto come è morto?»
«Non sapevo neppure che fosse partito» risposi. «Non so niente di tutta questa storia.»
«Tu non piangi.»
«Neppure tu.»
«Tua madre ha il cuore spezzato. Hanno detto che era molto malato… e lui doveva saperlo, perciò deve averlo detto a qualcuno. Ne ha parlato con te?»
«Se l’avesse saputo non si sarebbe mai allontanato da casa» provai a rassicurarla, sperando di sembrare convincente. C’erano degli asciugamani bianchi ordinatamente impilati su uno scaffale metallico sopra lo specchio. Ne presi uno e mi asciugai la faccia e il collo, poi un altro, finché la pelle del viso e del collo non lasciò segni grigi su cinque asciugamani. Non c’era un cesto della biancheria sporca in cui gettarli, così li abbandonai nel lavandino. «Dove l’hanno trovato?» chiesi. «Fin dove è arrivato?»
«Non so» rispose. «Non ce l’hanno detto. Qualche città dall’altra parte.»
«Forse era una clinica specialistica.»
«Te l’ho già detto: veniva a trovare te.»
«Ha lasciato una lettera?»
Nessuna lettera. La mamma e la nonna, pensai, forse avevano attribuito la sua partenza a un impegno di lavoro, ovvero al suo rifiuto ben noto di fare il pensionato, così come il nonno e io ci eravamo inventati un paziente fuori città per nascondere le sue visite all’amico oncologo, dal quale si recava per delle iniezioni con un miscuglio di farmaci che lo avrebbero dovuto aiutare a sopportare il dolore. Formule variopinte, commentava il nonno al ritorno a casa, quasi sospettasse che si trattava soltanto di acqua corretta con coloranti, quasi che ormai non avesse più importanza. All’inizio aveva mantenuto un aspetto più o meno sano, e quindi era più facile nascondere la malattia. Tuttavia, rivedendolo dopo la prima di quelle sedute, avevo minacciato di raccontare tutto alla mamma, ma lui mi aveva gelato: «Non osare neppure pensarlo». E la cosa era finita lì.
La nonna mi stava chiedendo: «Sei già a Brejevina?».
«No, siamo alla frontiera» risposi. «Siamo appena scese dal traghetto.»
Fuori, la fila delle macchine incominciava a muoversi più velocemente. Vidi Zóra spegnere la sigaretta per terra, tirare dentro la gamba e sbattere la portiera. Ci fu un agitarsi di gente che si era radunata sul ciglio ghiaioso della strada per sgranchirsi e fumare, controllare le gomme e riempire bottiglie alla fontanella dell’acqua, per guardare con impazienza la lunga coda, e buttar via dolci e panini che aveva rinunciato a importare illegalmente, oppure per pisciare contro il muro laterale del bagno… tutti si affrettavano a tornare alle loro auto.
La nonna rimase in silenzio per qualche istante. Sentivo il fruscio della linea e poi: «Tua madre vuole fare il funerale tra qualche giorno. Zóra non potrebbe andare a Brejevina da sola?».
Se l’avessi proposto a Zóra, lei mi avrebbe spedito a casa immediatamente. Avrebbe lasciato a me la macchina, preso i contenitori termici con i vaccini e attraversato il confine facendo l’autostop per consegnare i medicinali offerti dall’Università all’orfanotrofio di Brejevina, sulla costa più a nord. Invece dissi: «Siamo quasi arrivate, Bako, e un sacco di bambini aspettano di essere vaccinati».
Non me lo chiese una seconda volta. Si limitò a darmi la data del funerale, l’ora e il luogo, anche se già sapevo dove si sarebbe svolto, su a Strmina, la collina che domina la Città, dove era stata sepolta Mamma Vera, la mia trisavola. Quando riappese aprii il rubinetto dell’acqua con il gomito e riempii le bottiglie che avevo portato con me come pretesto per allontanarmi. Una volta fuori, mi sciacquai i piedi prima di rimettermi le scarpe. Zóra, senza spegnere il motore, saltò giù dall’auto e andò a sua volta in bagno mentre io mi mettevo al posto di guida. Tirai in avanti il sedile perché sono più bassa di lei e verificai che i nostri permessi e i documenti per l’importazione di medicinali fossero allineati nel giusto ordine sul cruscotto. Due macchine davanti a noi, un doganiere, la camicia verde incollata al petto, aveva aperto il portabagagli di una coppia di anziani e strattonava la cerniera lampo delle valigie con la mano guantata.
Quando Zóra tornò non le dissi niente del nonno. Era stato un anno deprimente sia per me sia per lei. Io avevo fatto l’errore di solidarizzare con gli infermieri durante lo sciopero di gennaio. Ricompensata per i miei sforzi con una sospensione a tempo indeterminato dalla clinica di Vojvodja, mi ero chiusa in casa per mesi, una fortuna in un certo senso, perché ero a disposizione quando la diagnosi del nonno arrivò. In un primo momento il nonno parve contento della mia presenza, anche se non si lasciò sfuggire l’occasione di darmi della stupida ingenua per essere incorsa nella sanzione disciplinare. Poi, con il progredire della malattia, incominciò a passare sempre più tempo fuori casa e mi consigliò di fare lo stesso; non gli piaceva che trascorressi giornate intere a ciondolare immusonita per casa, e si spaventava a morte ogni volta che, svegliandosi di soprassalto nel cuore della notte, mi trovava china sul suo letto. Con il mio comportamento, diceva, insospettivo la nonna, che guardava con crescente diffidenza ai nostri silenzi, alle nostre improvvise discussioni e al fatto che apparivamo tanto indaffarati proprio adesso che lui era in pensione e io ero stata allontanata dalla clinica. Il nonno voleva anche che pensassi alla specializzazione, a cosa avrei fatto di me stessa una volta terminato il periodo di sospensione. Non era sorpreso che Srdjan, il professore di ingegneria biochimica con il quale, secondo l’eufemismo del nonno, «mi ero un po’ ingarbugliata», non avesse speso una buona parola in mio favore presso il comitato disciplinare. Così, su suggerimento del nonno, ero tornata a lavorare come volontaria per il programma delle Cliniche Riunite dell’Università, cosa che non facevo dalla fine della guerra.
Zóra, dal canto suo, approfittava della missione umanitaria per prendere le distanze dalla grana scoppiata all’Accademia Militare di Medicina. Quattro anni dopo essersi laureata, Zóra era ancora praticante presso il centro traumatologico, nella speranza che la conoscenza di diverse tecniche chirurgiche l’avrebbe aiutata a scegliere finalmente la specializzazione giusta. Purtroppo aveva passato la maggior parte di quegli anni a lavorare sotto la direzione di un traumatologo conosciuto in tutta la Città come Guanto di Ferro – soprannome che si era guadagnato nel periodo in cui era capo ostetrico e usava visitare le pazienti con il polso coperto di tintinnanti bracciali d’argento. Zóra era una donna di saldi principi, un’atea dichiarata. A tredici anni un prete aveva avuto la pessima idea di raccontarle che gli animali non hanno l’anima e lei per tutta risposta: «Ah, sì? E chi lo dice? Vai a farti fottere, prete dei miei stivali!» ed era uscita dalla chiesa senza voltarsi. Quattro anni di scontri con Guanto di Ferro erano culminati in un episodio di cui, su ordine del pubblico ministero, le era proibito parlare. Il suo silenzio su questo episodio non faceva eccezione neppure per me, ma gli accenni che avevo raccolto nei corridoi dell’ospedale riguardavano un ferroviere, un incidente e l’amputazione di un dito durante la quale Guanto di Ferro, forse ubriaco forse no, si era lasciato sfuggire una frase del tipo: «La pianti di frignare, mio caro. Il secondo dito le farà meno male, se stringerà forte tra i denti il moncherino del primo».
Naturalmente, era in corso un processo, e Zóra era stata convocata a testimoniare contro Guanto di Ferro. Nonostante la cattiva reputazione, il chirurgo continuava ad avere importanti appoggi nella comunità medica, e ora Zóra era combattuta tra farla pagare a un uomo che da anni disprezzava o proteggere la propria carriera e il buon nome che stava cominciando a costruirsi. Per la prima volta nessuno – non io, non la sua famiglia, non l’attuale fidanzato – era in grado di indicarle la giusta direzione.
Dopo aver deciso di accettare l’incarico, avevamo trascorso una settimana alla sede centrale delle Cliniche Riunite ad aggiornare la nostra preparazione, e in tutto quel tempo Zóra aveva risposto con lo stesso ostinato silenzio sia alla mia curiosità sia alle incessanti telefonate del pubblico ministero. Solo qualche giorno prima, inaspettatamente, aveva ammesso di voler chiedere consiglio al nonno non appena fossimo tornate nella Città. Nell’ultimo mese non l’aveva incrociato all’ospedale, non aveva visto la sua faccia grigia, la pelle vuota attorno alle ossa.
Osservammo il doganiere sequestrare due barattoli di ciottoli che l’anziana coppia aveva raccolto sulla spiaggia mentre con la mano faceva cenno di avanzare alla macchina successiva. Quando toccò a noi, l’uomo impiegò venti minuti a esaminare i nostri passaporti, le carte d’identità e i certificati dell’Università. Aprì i contenitori termici con i farmaci e li mise in bell’ordine sull’asfalto. Zóra, guardandolo dal basso in alto a braccia incrociate, ringhiò: «Lei si rende conto, naturalmente, che se il vaccino è tenuto in un frigorifero significa che è sensibile agli sbalzi di temperatura… o alla scuola del villaggio non vi insegnano niente a proposito della “refrigerazione”?» sapendo che era tutto in ordine, sapendo che, in realtà, il doganiere non poteva fare niente contro di noi. L’atteggiamento di sfida di Zóra, però, lo spinse a perquisire l’auto per altri trenta minuti, alla ricerca di armi, clandestini, molluschi, animali da compagnia privi di libretto sanitario.
Dodici anni fa, prima della guerra, la gente di Brejevina era la nostra gente. La frontiera era uno scherzo, una pura formalità, e potevi superarla in macchina, in aereo o a piedi, come preferivi, attraverso i boschi, l’aperta campagna o per mare. Tutt’al più si trattava di offrire ai doganieri un panino o un barattolo di peperoni sott’aceto. Nessuno ti chiedeva il nome, benché, come divenne chiaro in seguito, tutti si preoccupassero da sempre di come cominciava e di come finiva il proprio nome. Lo scopo del nostro intervento a Brejevina era ricostruire qualcosa. La nostra Università voleva collaborare con il governo locale alla costruzione di una rete di orfanotrofi e contribuire a convincere i giovani d’oltre frontiera a tornare nella Città. Questo era l’obiettivo diplomatico a lungo termine del viaggio, in termini più terra-terra Zóra e io eravamo là per vaccinare i bambini resi orfani dai nostri stessi soldati, per visitarli e scoprire se avevano i pidocchi o erano ammalati di polmonite o di tubercolosi, per praticare le vaccinazioni contr...