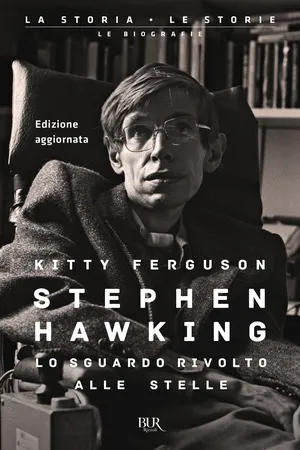![]()
Parte seconda
1970-1990
![]()
7
«Questa gente penserà che siamo abituati a uno standard di vita astronomico»
Alla nascita di Lucy, il 2 novembre del 1970, gli Hawking avevano da poco comprato la casa in Little St Mary’s Lane in cui avevano abitato in affitto per anni. I genitori di Stephen avevano dato loro il denaro per rimodernarla e le garanzie per chiedere un mutuo; i lavori vennero completati quando Jane era ormai incinta di otto mesi.
Stephen continuava a insistere nel voler essere autonomo nelle attività quotidiane: salire e scendere le scale, vestirsi la mattina e svestirsi la sera. Il suo commento sul fatto che, mentre si preparava per andare a letto, aveva molto tempo per riflettere sui fotoni all’orizzonte degli eventi dei buchi neri è una delle sue pochissime ammissioni di quanto tutto ciò fosse estremamente lento e difficile. Alla fine però, camminare era diventato per lui così pericoloso che accettò di usare una sedia a rotelle. Aveva perso la battaglia per restare in piedi; gli amici lo guardavano con tristezza, ma l’umorismo e la determinazione non lo abbandonarono.
La perdita dell’uso delle mani – che significava non poter più scrivere equazioni e tracciare diagrammi – non era avvenuta da un giorno all’altro, ma in modo graduale nel corso degli anni, durante i quali aveva avuto tempo di adattarsi e allenare «la sua mente a pensare in una maniera diversa da quelle degli altri fisici. Stephen pensa attraverso nuovi tipi di rappresentazioni mentali intuitive ed equazioni mentali che, per lui, hanno sostituito le equazioni scritte e i disegni fatti con carta e penna» ha affermato Kip Thorne.1 Ascoltando Hawking si ha l’impressione che egli creda che forse avrebbe scelto questo modo di lavorare anche se avesse avuto il pieno uso delle mani: «Le equazioni sono solo la parte noiosa della matematica. Io preferisco vedere le cose in termini di geometria».2 I calcoli necessari per la scoperta della radiazione di Hawking vennero eseguiti quasi interamente nella sua testa.
Dopo la nascita di Lucy, Jane si stava destreggiando in una serie di impegni quasi impossibile: stava cercando di finire il suo dottorato mentre, al contempo, si prendeva cura di Stephen, del piccolo Robert e ora anche della neonata. Sua madre e la tata di un vicino la aiutavano con i bambini ogni volta che potevano. Il cottage in Little St Mary’s Lane era uno splendore: quando i bambini crebbero e Lucy iniziò a camminare da sola con sicurezza, si unì al fratello nei giochi fra le piante fiorite e le antiche lapidi in pietra del sagrato della chiesa di Little St Mary, dall’altra parte della strada. Jane ricorda ancora le estati con le finestre aperte e le voci festose dei suoi bambini che «strillavano nel sagrato».
Nel gennaio del 1971, quando il saggio di Hawking intitolato Black Holes vinse il primo premio all’annuale concorso della Gravity Research Foundation, il denaro ricavato permise loro di comprare una macchina nuova. Hawking riceveva un salario dal Caius College e un assegno di ricerca dal DAMTP e dall’Istituto di astronomia; tuttavia, il budget familiare era ancora ristretto e, quando Robert raggiunse l’età scolare, non era sufficiente per pagargli la retta di una scuola privata. Il bambino venne quindi iscritto alla scuola elementare locale, la Newnham Croft Primary School, un buon istituto dove quindici anni dopo avrei mandato anche mia figlia. Robert sembrava seguire le orme del padre, eccellendo in matematica e imparando con lentezza a leggere; ormai, però, eravamo in una nuova epoca, quando la «lentezza nell’imparare a leggere» non veniva più accettata passivamente senza prendere delle misure. Jane Hawking sospettava che il bambino potesse essere affetto da una forma di dislessia e, nella speranza che una scuola privata potesse fornire a Robert un aiuto più qualificato, il padre di Stephen venne in loro soccorso acquistando ai coniugi una seconda casa, da affittare per avere una rendita extra. Così, all’età di sette anni, Robert si trasferì alla Perse School di Cambridge.
Gli Hawking continuavano a cercare di tenere in secondo piano la malattia di Stephen, di evitare che diventasse per loro la cosa più importante. Presero l’abitudine di non guardare al futuro. Agli occhi del resto del mondo ci riuscivano talmente bene che fu una sorpresa quando Jane Hawking accennò a quanto, a volte, le difficoltà fossero terribili. In un’intervista, discutendo degli onori tributati al marito, dichiarò: «Non direi che questo straordinario successo valga la pena di tutti questi momenti bui. Penso che non sarò mai in grado di riconciliare nella mia mente le oscillazioni che abbiamo vissuto, passando dagli abissi di un buco nero alle vette di tutti i meravigliosi premi».
Se giudichiamo da tutto ciò che Stephen Hawking ha scritto, sembra che egli si accorgesse a malapena di questi abissi. Parlarne in un modo che non sia quantomeno estemporaneo – il massimo che si concede – rappresenterebbe per lui una forma di resa, di sconfitta, e potrebbe minare la risoluta noncuranza con cui sfida i suoi problemi. La maggior parte delle volte ha continuato a rifiutarsi di discutere della sua malattia anche con Jane; ma ciò, agli occhi della donna, non ha certo reso il problema meno grande o meno evidente.
Jane ricorda che per Stephen era difficile accettare di non essere in grado di assistere i figli o di giocare attivamente con loro. Fu lei a insegnare a Robert, e in seguito a Lucy e Timmy, a giocare a cricket («Io posso portarli fuori!» gongolava), e canzonava suo marito dicendo che, a differenza delle altre mogli, non era sorpresa o delusa quando lui si dimostrava inutile in casa o con i bambini.
Il fatto che per Hawking fosse impossibile dedicarsi a qualsiasi attività pratica divenne uno degli effetti collaterali positivi della sua malattia: poteva anche impiegare un sacco di tempo per alzarsi e andare a letto, ma non doveva correre qua e là per commissioni, fare riparazioni in casa, tagliare l’erba, organizzare i viaggi, fare la valigia, preparare gli orari delle lezioni o perdere tempo in incarichi amministrativi al DAMTP o al Caius, tutte incombenze che venivano lasciate ai colleghi e agli assistenti, o a sua moglie. Poteva dedicare tutto il suo tempo a pensare alla fisica, un lusso che i suoi colleghi gli invidiavano.
Jane aveva previsto che la stragrande maggioranza di queste responsabilità quotidiane sarebbe ricaduta sulle sue spalle. Già prima di sposarsi, negli anni Sessanta, aveva deciso che solo uno di loro due avrebbe potuto avere una carriera, e quello sarebbe stato suo marito. Negli anni Settanta, forse perché le idee riguardo al ruolo delle donne stavano cambiando, quel sacrificio diventò più difficile da accettare. Aveva pensato che il fatto di offrire a Stephen l’assistenza e l’incoraggiamento di cui aveva un tremendo bisogno avrebbe dato uno scopo e un significato alla sua vita; ciò che non le stava dando, però, era un’identità. E neanche la maternità l’aveva aiutata in questo: per riprendere le sue parole, anche se adorava i suoi figli e «non avrebbe mai voluto farli allevare da qualcun altro, Cambridge è un posto molto difficile in cui vivere se l’unica tua identità è quella di essere la madre di bambini piccoli».3
Per correttezza verso la comunità universitaria, bisogna dire che ogniqualvolta a Cambridge si faceva il nome di Hawking, capitava spesso che qualcuno commentasse che Jane Hawking era una persona ancora più ammirevole di Stephen. Tuttavia, Jane non la vedeva così. Ai suoi occhi, a Cambridge «la pressione è perché tu ti faccia strada sul piano accademico».4 Era questa, naturalmente, la ragione per cui aveva deciso di tornare all’università per conseguire un dottorato, ma le bozze della sua tesi restavano troppo spesso a languire sullo scaffale.
Jane aveva molto di cui essere fiera negli anni Settanta: Robert e Lucy crescevano bene, la carriera di fisico del marito schizzava alle stelle (e la sua reputazione di persona tenace e di buonumore, malgrado le avversità, stava diventando leggendaria) e lei iniziava a farsi strada in ambito accademico. Allo stesso tempo, però, aveva sempre più l’impressione che il suo enorme e faticoso ruolo nel successo di Hawking passasse in gran parte inosservato. Il suo era un problema abbastanza comune fra le persone che hanno il talento di far sembrare le cose facili: gli altri iniziano a credere che per loro quelle cose siano davvero facili, e non si rendono conto del sacrificio e degli sforzi che richiedono. Sia Jane che il marito sapevano benissimo che i successi di Stephen – e probabilmente la sua stessa sopravvivenza – non sarebbero stati possibili senza di lei, che però condivideva solo in minima parte i suoi trionfi. Nelle foto di Hawking capitava a volte che la figura di Jane venisse tagliata, come se fosse una semplice infermiera che si limitava a spingere la sua sedia a rotelle. Inoltre, Jane non era in grado di seguire i ragionamenti matematici del marito e condividere questi suoi piaceri. Ciononostante, «la gioia e l’entusiasmo per il successo di Stephen erano straordinari»,5 afferma; non si era pentita della decisione di sposarlo, ma le ricompense «non alleviavano le strazianti difficoltà di far fronte, giorno dopo giorno, alla malattia dei motoneuroni».6
Nonostante le difficoltà, però, gli Hawking condividevano anche molti piaceri: entrambi erano affezionatissimi ai loro bambini, amavano la musica classica e andavano insieme ai concerti e a teatro, a Natale portavano Robert e Lucy alla recita e loro stessi amavano intrattenere la gente. Don Page, un ricercatore che avrebbe vissuto per tre anni a casa degli Hawking in qualità di assistente di Stephen, ricorda che Jane era «molto socievole […] una grande risorsa professionale» per il marito;7 non era raro incontrarla al supermercato mentre faceva la spesa per una festa con sessanta invitati. Gli Hawking divennero famosi per la loro ospitalità.
Inoltre, erano entrambi molto attenti a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle necessità dei disabili e sulla possibilità, per loro, di condurre un’esistenza normale, se non una vita attiva e ricca di successi. Negli anni Settanta queste idee non erano ancora parte integrante della nostra cultura come stanno diventando oggi: la Gran Bretagna aveva approvato una legge sui malati cronici e le persone disabili nel 1970, ma la sua applicazione procedeva con estrema lentezza. Di tanto in tanto l’indignazione di Jane e Hawking cresceva al punto da spingerli a protestare: scrissero una lettera al consiglio del National Trust (l’ente per la salvaguardia dei luoghi di interesse storico o naturalistico) quando la direzione dell’Anglesey Abbey – una magione circondata da giardini nei pressi di Cambridge, aperta al pubblico – insistette perché gli Hawking lasciassero l’auto in un posteggio a quasi un chilometro di distanza anziché vicino alla casa.8 Ben presto Jane aggiunse le campagne per i diritti dei disabili alla sua già lunga lista di attività.
Gli Hawking vinsero alcune battaglie per garantire l’accesso agli edifici pubblici ai disabili su sedia a rotelle. Dopo una lunga disputa burocratica su chi dovesse sobbarcarsene le spese, all’ingresso posteriore dell’edificio del DAMTP venne costruita una rampa. L’Arts Theatre iniziò a riservare spazi per gli spettatori in sedia a rotelle, così come l’Arts Cinema; a Londra, l’English National Opera e il Coliseum resero possibile l’accesso ai disabili. Dove queste rampe non c’erano, chiunque si trovasse a portata di mano veniva di solito reclutato per sollevare Hawking con la sua carrozzina e portarlo su e giù per le scale. Al Clare Hall, un college di specializzandi dell’università di Cambridge, i membri del circolo di astronomia venivano regolarmente chiamati per adempiere a questo compito prima e dopo i loro incontri. La procedura non sempre era sicura: a Covent Garden, mentre lo stavano trasportando su per una rampa di scale fino a dei posti altrimenti inaccessibili, agli addetti della Royal Opera House sfuggì la carrozzina di Stephen, che fece un volo dalle scale.9
La fede in Dio e le leggi della fisica
Verso la fine degli anni Ottanta, guardando al passato, Jane Hawking attribuì la sua capacità di affrontare per così tanti anni la loro insolita e spesso difficile vita – una vita senza la speranza di un lungo o felice futuro – alla propria fede in Dio. Senza di essa, affermò, «Non sarei stata in grado di vivere in quella situazione. Non sarei stata in grado, innanzitutto, di sposare Stephen, perché non avrei avuto l’ottimismo a sostenermi e non sarei riuscita ad andare avanti».10
La fede che la sosteneva con tutta questa forza non era condivisa dal marito (lo era da alcuni dei suoi colleghi fisici, ma di solito Jane non discuteva con loro dell’argomento). Se il confronto di Stephen con la sua malattia e la minaccia di una morte prematura ha avuto anche un aspetto filosofico o religioso, lui non ne ha mai parlato pubblicamente. Tuttavia, leggendo i suoi libri Dal Big Bang ai buchi neri e Il grande disegno, sembra evidente come Dio non sia mai stato lontano dai pensieri di Hawking, che dichiarò a un intervistatore: «È difficile discutere dell’inizio dell’universo senza menzionare il concetto di Dio. Le mie ricerche sull’origine dell’universo si collocano sul confine tra la scienza e la religione, ma io cerco di rimanere sul lato scientifico. È del tutto possibile che Dio agisca in modi che non possono essere descritti dalle leggi scientifiche; in tal caso, però, si tratterebbe di una cosa accettabile solo per fede personale».11 Di fronte alla domanda se pensasse che la sua scienza fosse in competizione con la religione, rispose: «Assumendo questa posizione, Newton [che era un uomo molto religioso] non avrebbe scoperto la legge della gravità».12
Hawking asseriva di non essere ateo, ma che preferiva «usare il termine Dio come la personificazione delle leggi della fisica».13 «Non c’è bisogno di fare appello a Dio per porre le condizioni iniziali dell’universo; ciò però non dimostra che Dio non esiste, ma solo che agisce attraverso le leggi della fisica.»14 Tuttavia, Hawking di certo non credeva in un Dio personale che si prende cura degli esseri umani come singoli individui, instaura con loro un rapporto potente in grado di trasformarli e compie miracoli. «Noi siamo creature del tutto insignificanti che vivono su un pianeta minore di una comunissima stella situata ai margini di una delle centinaia di miliardi di galassie. È quindi difficile credere in un Dio che si prenda cura di noi, o anche solo che si accorga della nostra esistenza.»15 Einstein condivideva la visione di Hawking; altri, fra cui alcuni dei suoi colleghi fisici, sarebbero invece stati d’accordo con Jane e avrebbero detto che questa era una concezione molto limitata di Dio, evidenziando che è altrettanto difficile credere che tutte le persone intelligenti e razionali (tra cui numerosi scienziati), che dicono di avere esperienza di un Dio personale, siano in qualche modo degli illusi. Le visioni di Stephen e Jane Hawking potrebbero essere considerate come uno dei più lampanti esempi di questa enorme differenza di prospettive.
«Ero piuttosto urtata quando Stephen diceva di non credere in un Dio personale» ricorda Jane.16 In un’intervista del 1988 avrebbe dichiarato: «Sta scavando in dimensioni davvero importanti per le persone che ragionano su queste cose, e in un modo che può risultare molto fastidioso alla gente. C’è un aspetto del suo pensiero che trovo sempre più irritante e con cui mi è difficile convivere: è la sensazione che, poiché tutto viene ridotto a una formula matematica, razionale, quella dev’essere la verità».17 Le sembrava che nella mente di suo marito non ci fosse spazio per l’eventualità che la verità trovata nella sua matematica potesse non essere tutta la verità. Un anno dopo, però, aveva leggermente cambiato la sua prospettiva: «Invecchiando ci è più facile allargare le nostre vedute. Penso che il quadro complessivo che ha davanti sia così diverso da quello di chiunque altro in virtù della sua condizione e delle circostanze in cui si trova […] essendo un genio quasi totalmente paralizzato […] nessun altro può comprendere quale possa essere la sua visione di Dio o il suo rapporto con Dio».18
Forse per Hawking la verità doveva essere matematica, ma la fisica non era comunque l’unica cosa nella sua vita: «La fisica» disse in un’intervista «è bellissima, ma è del tutto fredda. Non ce la farei a vivere se avessi soltanto la fisica. Anch’io, come chiunque altro, ho bisogno di calore, amore e affetto».19
Un risorsa fuori dal comune
Alla fine degli anni Sessanta il college e l’università di Hawking erano stati forse generosi a tenere con sé un giovane fisico a cui non restava molto tempo da vivere e che, in termini di lezioni e insegnamento, poteva dare ben poco al proprio dipartimento. Il DAMTP lo aveva esentato fin da subito dagli incarichi di docenza più impegnativi e gli aveva concesso di concentrarsi sulle sue ricerche, tenendo solo qualche seminario per gli specializzandi. Verso la metà degli anni Settanta, però, il Caius College e l’università avevano iniziato a comprendere di aver agito nel loro stesso interesse: Hawking era diventato una notevole risorsa.
A Cambridge, comunque, le personalità e le menti straordinarie non sono affatto rare, e finiscono per emergere regolarmente in un dipartimento o nell’altro. È un ambiente salutare per i geni. Per quanto nel mondo esterno uno possa essere trattato con venerazione, all’interno della comunità universitaria in genere le cose proseguono come al solito. Anche alla fine degli anni Settanta, quando Hawking era ormai diventato quasi una leggenda, lui e tutte le sue particolari attrezzature – strumenti che gli voltavano le pagine, terminali di computer dotati di controlli speciali in modo che potesse usarli come una lavagna – condividevano ancora un piccolo ufficio con un altro ricercatore.
I suoi problemi di comunicazione continuavano ad aggravarsi. Se durante gli anni Settanta era ancora possibile intrattenere con lui una normale conversazione, tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, quando ormai le sue parole erano talmente confuse che solo i familiari e gli amici più intimi riuscivano a capirlo, il lavoro di «interprete» toccava spesso a uno studente ricercatore. Michael Harwood, che in seguito avrebbe intervistato Hawking per il «New York Times», descrisse questo processo: «Don Page, seduto accanto a lui, si avvicina per ascoltare le parole indistinte, pronuncia ogni frase per essere sicuro di averla afferrata, fa delle pause e chiede di ripetere, a volte chiede conferma a Hawking riguardo a una frase, si corregge».20 Un altro intervistatore racconta che spesso pensava che Hawking avesse terminato una frase solo per poi scoprire, grazie all’«interpretazione», che in realtà aveva pronunciato soltanto una parola. Hawking scriveva i suoi articoli scientifici dettandoli alla sua segretaria in questo modo estenuante; tuttavia, stava imparando a formulare le idee nel minor numero possibile di parole e ad arrivare subito al punto nelle conversazioni e nelle pubblicazioni scientifiche.
Ciò che diceva in quelle poche parole veniva accolto con attenzione in tutto il mondo. Poco dopo aver annunciato la sua scoperta dell’esplosione dei buchi neri, la serie di premi e riconoscimenti attribuitigli si era intensificata. Nella primavera del 1974, a soli trentadue anni, gli fu concesso l’onore di entrare nella Royal Society, una delle più prestigiose istituzioni scientifiche del mondo. Durante il rito di investitura, una cerimonia risalente al XVII secolo, i nuovi membri sa...