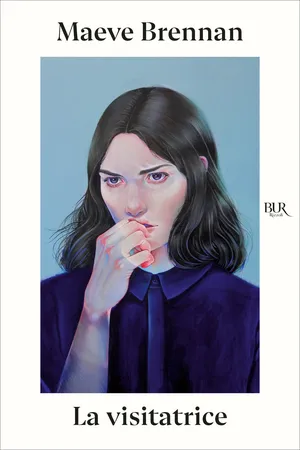Prefazione
di Paula Fox
Sui marciapiedi di Cobble Hill, il quartiere di Brooklyn in cui vivo, a volte mi imbatto in un amico irlandese che con andatura spedita passa davanti a casa nostra diretto al suo studio poco distante. Fa il dottore, è un bell’uomo affabile ed elegante. Nel suo sorriso c’è un’ombra di malizia, un tocco di astuzia. Ci conosciamo da anni e spesso lui si ferma qualche istante a parlare con me. Poco tempo fa mi ha raccontato che una volta la casa accanto alla nostra apparteneva alla sua prozia, che da ragazzino andava sempre a trovare.
Anni fa, però, quella palazzina in arenaria del xix secolo è stata sostituita da un insulso edificio di quattro piani, dall’aria dozzinale, con la facciata composta da schegge di pietra rossastra conficcate nell’intonaco bianco. Le finestre sono ampie ma anonime. L’intera struttura ha un aspetto piatto, come un fondale teatrale, quasi non fosse dotata della profondità di stanze e sale.
Una di queste mattine Michael, il dottore, si è fermato di fronte a quell’edificio e io, che dovevo fare una commissione nel quartiere, l’ho raggiunto. Mi ha detto: «Mi ricordo che anni fa era una casa grande e antica».
Quand’era bambino abitava in un’altra palazzina di arenaria, tuttora di sua proprietà. Si trova nello stesso isolato e adesso ci vive sua figlia.
In passato, nei pomeriggi d’inverno in cui tornava da scuola, passava spesso a salutare la prozia.
«La trovavo seduta nella sua imponente poltrona sdrucita, intenta a bere la prima tazza di tè» mi ha detto. «Alle due finestre del salotto c’erano pesanti drappi, sempre coperti di polvere. Un giorno ho notato un topolino seduto sotto la poltrona. Lui ha allungato la testolina per guardarmi meglio, con gli occhietti scintillanti e i baffi che guizzavano.»
Ripensandoci, è scoppiato a ridere.
In quel momento mi è venuto in mente il racconto di Maeve Brennan, La visitatrice, il cui dattiloscritto è stato scoperto di recente negli archivi della No tre Dame University dell’Indiana, e poi pubblicato. Da viva, Brennan aveva scritto e dato alle stampe due volumi di racconti. Ma quando uscì La visitatrice, la sua opera più lunga, lei era già morta.
Non ci sono topolini nella casa di Dublino in cui si svolge la storia. La governante, Katharine, non l’avrebbe mai permesso.
Il titolo illustra il tema della storia. Anastasia King torna a casa dalla nonna paterna, l’anziana signora King, dopo aver vissuto sei anni a Parigi con la madre, Mary. Ma la madre è morta da poco e la nonna tratta Anastasia come un’ospite, una visitatrice, invece che come un membro della famiglia.
L’atmosfera malinconica e lievemente minacciosa si accentua. Sebbene tutte le luci della vecchia casa dublinese siano accese per dare il benvenuto ad Anastasia, giunta in taxi dalla stazione, la loro scintillante promessa di futuro è un’illusione. La fredda accoglienza della nonna la stupisce e la inquieta.
Sono passati sei anni da quando la madre di Anastasia è fuggita, abbandonando suo padre e l’Irlanda. Ora che la mamma è morta da un mese, la ragazza cerca rifugio, consolazione e calore nella vecchia casa, a Dublino.
Della nonna, Brennan scrive: «Era sempre la stessa, con quella sua faccia delicata e meditabonda e signorile, e le mani intrecciate davanti a sé, in un gesto formale». In piedi in mezzo alle sue borse e valigie, Anastasia pensa: «Sta aspettando che io commetta qualche errore».
È un pensiero che dura un istante, rivelatore, profondo, e prepara il terreno per il futuro conflitto tra la ragazza e l’anziana donna.
All’improvviso, Anastasia capisce di avere già commesso l’errore che la nonna non le perdonerà mai. Quando aveva sedici anni, sua madre aveva abbandonato il figlio della signora King, John. È Anastasia era andata a vivere con lei a Parigi.
Anche lei aveva abbandonato suo padre. Rivolta ad Anastasia, la nonna dice: «... quando hai deciso di andare a vivere con tua madre a Parigi, hai fatto una scelta importante. Avevi sedici anni, non eri una bambina». Anastasia esclama: «Oh, nonna, come potevo lasciarla?» E la nonna risponde, zittendo temporaneamente la ragazza: «Non voglio discutere di questo. Ho intenzione di essere molto pratica con te... Sai bene che, scappando via a quel modo, come una pazza, tua madre ci ha disonorati tutti».
Ma la giovane non si arrende. La sua grande aspirazione è quella di diventare più di un’ospite in casa della signora King. Anastasia spera di restare per sempre.
Nel personaggio della signora King c’è qualcosa di brutale e inesorabile. È una donna gretta, vanesia e meschina. Dopo che Anastasia ha vissuto qualche mese con lei nella camera al piano superiore della vecchia casa, da dove può contemplare il piccolo giardino buio, la signora King invita la giovane nipote a tornare a Parigi, nell’appartamento in cui aveva abitato con la madre.
«Non puoi stare qui» dice. Accanto a lei c’è spesso la generosa Katharine, con in mano uno straccio per la polvere e il cuore carico di sconforto.
Eppure l’opposizione di Anastasia al cupo crollo delle sue speranze possiede una forza intrinseca basata sull’accumulazione. Non fa che moltiplicare le richieste di amore e accoglienza all’anziana donna, e a volte arriva a comportarsi come un corteggiatore. Ma è tutto mutile.
La devozione della signora King al ricordo del figlio è così intensa, e implica un’esclusione così radicale degli altri, da suggerire qualcosa di più dell’amore materno, un’ossessione. I suoi gelidi atti di cortesia aumentano: la donna non ha intenzione di soccombere all’urgenza delle necessità della nipote.
Maeve Brennan ha scritto una serie di racconti pubblicati sul «New Yorker», la rivista americana. Sono stati raccolti in due volumi, il primo intitolato The Rose Garden e il secondo The Springs of Affection. Quelli ambientati in Irlanda spiccano come gli ospiti d’onore a una festa.
Sulla parete dell’ufficio la scrittrice teneva una frase, scritta a matita, del poeta irlandese William Butler Yeats: «Soltanto ciò che non insegna, ciò che non chiede a gran voce, ciò che non convince, ciò che non accondiscende, ciò che non spiega è irresistibile».
I racconti di Brennan sono irresistibili. È una qualità difficile da esprimere. Com’è possibile descrivere il vigore della sua lingua, la sua stupefacente freschezza? È come se, dopo averli letti, il lettore fosse costretto a vedere la vita e la gente in modo diverso.
Per un breve periodo l’autrice fu sposata con un affascinante mascalzone, St. Clair McKelway. Nei cinque anni in cui restarono insieme consumarono alcolici senza sosta.
William Maxwell, illustre ed elegante scrittore, editor di Brennan al «New Yorker», fu anche suo caro amico e mentore, e negli ultimi anni di vita la protesse quando le capitava di perdere il controllo della propria mente e cadere in episodi psicotici. A un certo punto la scrittrice si sistemò nella toilette delle signore, in redazione, e il personale le mandava i pasti. Ma alla fine non riuscirono più a tollerare le sue allucinazioni. Non era più in grado di scrivere racconti, solo annotazioni, molte delle quali indirizzate a Maxwell. Una diceva: «L’esperienza non insegna alcuna lezione».
Maxwell scrisse la prefazione a una delle sue due raccolte, The Springs of Affection, in cui osserva: «Molti uomini e donne trovavano Maeve incantevole, ed era una vera amica, ma non fu possibile fare molto per salvarla da se stessa... durante gli ultimi dieci anni della sua vita entrava e usciva dalla realtà in un modo che ti spezzava il cuore, e che soltanto gli ospedali possono affrontare».
Morì sola in una casa di riposo all’età di settantasette anni.
Prima della triste fine della sua esistenza, per lunghi anni produsse opere significative, numerosi racconti eccelsi.
Il suo acume quieto e luminoso, il modo in cui scopriva peso e significato nelle cose più piccole, nelle stanze e nelle persone, sono evidenti in quello che molti lettori, tra cui anche Maxwell, giudicano il racconto più bello, The Springs of Affection. Ecco un esempio della sua lucidità nel passaggio dalle stanze alle persone che ci vivono: «Min ricordava il giorno del matrimonio di Mar...