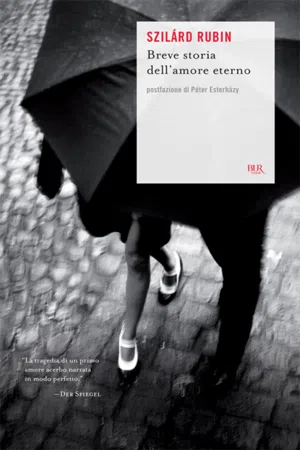![]()
1.
Mi fermai sulla strada illuminata dal chiaro di luna, dalle parti del Policlinico. Dietro di me le mura del bagno termale Onda, da cui sentivo arrivare l’odore dei bacini appena riempiti di acqua. Dalla piscina giungeva un alito fresco che si spandeva nella notte.
Non passava un’anima. Mi appoggiai al muro per guardare la strada immersa nel sonno. Regnava il silenzio, e in mezzo alla carreggiata vuota il mio sguardo sostava come ipnotizzato sui cristalli di quarzo scintillanti, nella sabbia striata dalle scie delle biciclette. Avevo la pelle fresca e distesa per il bagno, il mio corpo era pulito come un vetro da laboratorio. Scrutavo assorto la notte, con lo spirito vigile dei vagabondi. In fondo alla strada un orologio elettrico risplendeva in alto, sul quadrante chiaro e sereno riuscivo a distinguere persino le tacche dei minuti. L’una era passata da oltre un quarto d’ora.
Avevo in tasca le chiavi di casa del mio amico, ma mi dispiaceva andare già a dormire. Ero a Pécs di passaggio, immerso nel giocoso fluttuare delle peregrinazioni estive. Anche se i flutti del Balaton ancora si agitavano nel mio animo, ormai desideravo solo rivedere il Danubio. Mi sedetti sulla panchina davanti al muro di cinta del bagno termale e mi accesi una sigaretta.
Ero a una quarantina di chilometri appena da Mohács. Anche senza soldi, ci sarei potuto arrivare a piedi, attraversando una serie di paesi a me ben noti, o passando per i sentieri serpeggianti tra le cantine delle colline ricche di vigneti. Cosciente di tutto questo restavo seduto sulla panchina e soffiavo nella notte il fumo della sigaretta.
Io e Orsolya eravamo arrivati verso le dieci per ballare nel locale all’aperto all’interno del bagno termale. Nonostante sua madre e una sua zia di queste parti se ne stessero sedute a un tavolino armate di lorgnette e di binocolo da teatro, e sebbene il suo vestito bianco di batista fosse chiaramente visibile anche attraverso il folto degli alberi, Orsolya non resistette a lungo sulla pista da ballo. Capivo benissimo ciò che le stava succedendo. Il suo volto introverso e innocente, che pareva emergere dal corridoio di un monastero di clausura all’alba, ardeva per l’eccitazione, mentre gli occhi vagavano in cerca degli angoli più oscuri del parco. Seguendo un impulso irresistibile ci liberammo dal vortice delle coppie danzanti e penetrammo nel buio circostante. «Ho caldo» sussurrò lei, «facciamo il bagno!» Gettammo i nostri abiti tra i cespugli e c’immergemmo dolcemente nella piscina, evitando di tuffarci per non far rumore. Tra lo scintillio blu scuro dell’acqua soltanto i suoi seni protetti dall’abbronzatura mandarono qualche bagliore, prima che lei s’immergesse del tutto. Nuotammo per qualche minuto, nudi, librandoci nell’acqua e toccandoci, sfiorandoci, leggeri e scivolosi come pesci, mentre tra i rami s’intravedeva il vorticare degli abiti colorati, e la musica giungeva fino a noi.
Tornando al tavolino ci asciugammo le gocce d’acqua rimaste dietro le orecchie e sulla fronte, cercando di staccare i vestiti dalle schiene bagnate come se fossimo sudati per il gran ballare. Orsolya fece persino il gesto di rinfrescarsi con il ventaglio della zia.
Mi misi ad ascoltare, per pura cortesia, il discorso della vecchia signora che parlava delle antiche vigne di famiglia ormai distrutte: «La filossera si era portata via tutto» diceva, «ma i viticultori più audaci si sono spinti fin nei deserti, a piantare i nuovi vigneti nelle distese sabbiose». «Di quali sabbie parlate, Tante Anna?» chiese Orsolya. «Della puszta di Deliblát, che domanda!»
La vecchia signora era originaria del Banato, così come tutta la famiglia di Orsolya, e sotto lo chignon custodiva tutti i pettegolezzi locali di quella che era stata, un tempo, la regione di confine del Regno. Era sempre bella, come in quella foto nell’album di famiglia dei Carletter che la ritraeva ancora ragazza accanto al giovane ulano, ai piedi la trappola Triumf fatta venire apposta da Haynau, in cui stava acquattato un gatto selvatico. Il mio sguardo si soffermò sulla sua mantellina, che non avrebbe sfigurato nella teca di un museo, e sulla catenina d’argento da cui pendeva il ritratto del santo protettore della cavalleria leggera, san Jeržy; in quel momento si formò in me l’immagine dell’antico ufficiale di cavalleria mentre si attarda in cima al Plutz e volge lo sguardo tutto intorno ad accarezzare le dune mobili spinte dai venti, o mentre avanza al trotto verso le paludi di Alibunar, in mezzo alle barcane, nel cuore l’aridità e la malinconia dei soldati colonizzatori, finché non viene inghiottito dalle sabbie diluviane. Ebbene, amavo la lontana discendente di questi due individui! E infatti, in questa Orsolya educata secondo i dettami del Biedermeier, non sopravvivevano forse, accanto al desiderio di piacere tipico di chi proviene dai confini della patria, i crudi istinti dei colonizzatori? E l’audacia con cui metteva a rischio il suo buon nome, non si mescolava in lei a un’altera superbia?
Seduto tra quelle dame dagli occhi blu splendenti come smalto, io, con la mia pelle bruna e il mio naso aquilino, sembravo un giovane ostaggio turco in mezzo a una famiglia di antica nobiltà.
«Sicuramente» dissi con tono adulatorio «anche il vino dei terreni sabbiosi è buono. Ma in Slovacchia ne ho bevuto di ottimo!»
«Was denn?»*
«In un castello…»
Orsolya sorrise incredula, e questo bastò a farmi tacere intimidito. Fui felice che si cambiasse subito argomento.
«Wie geht’s dem armen Herczeg?»** chiese Tante Anna, commossa.
La dama tenacemente filoasburgica riteneva che il romanziere Ferenc Herczeg, suo compatriota, fosse il più grande scrittore del secolo. Le sue opere la riportavano agli anni della giovinezza, allo Yacht Club dell’Adriatico durante le estati trascorse sulle coste della Dalmazia. Quanto mi avrebbe odiato, se la sua Orsolya le avesse raccontato che ogni volta che tornava dalla villa dell’anziano e solitario romanziere a H˝uvösvölgy, il quartiere di Buda dove si recava a consegnare un pacchetto inviatogli dalla famiglia, mi sembrava tornasse da un appuntamento galante, e io la accoglievo contrariato e ingelosito.
Adesso, seduto su quella panchina per strada, sorridevo pensando che i Carletter immaginassero lo scrittore come appartenente all’aristocrazia e insieme consigliere segreto della Corona. Una vita trascorsa, invece che nello Spielberg, Sulle ali del vento, invece che a Szárszó, nel Palazzo gotico.* Era poi così strano se, sognando il nostro futuro, anche Orsolya scivolava sullo yacht di Onkel Franz?
Pensavo alla dimora di Tante Anna, ai cuscini impregnati degli odori delle stanze di Gerebenc e di Dunadombó, che la maestosa ma slanciata signora aveva volentieri sprimacciato per Orsolya. Quali sogni le conciliavano? Quali volti, quali luoghi vi apparivano?
All’improvviso mi accadde qualcosa. Anzi, per essere precisi accadde di nuovo qualcosa che mi perseguitava da quando ero solo un bambino, eppure quella sera giunse del tutto inaspettato! Senza che nulla mi avesse offeso, sentii dentro di me un vuoto glaciale, cominciai a battere i denti e guardai allucinato, fisso davanti a me con l’inquietudine degli orfani. In un batter d’occhi tutto il mio mondo mi aveva abbandonato, lasciandomi lì solo, senza relazioni né valori. Non mi serviva a nulla ripetere che Orsolya mi amava: suonava come un dogma ripetuto a vuoto.
«Dovresti pensare subito a qualcosa, a qualcosa di bellissimo!» mi aveva consigliato Orsolya quando le avevo parlato di questo mio stato di abbandono. E allora il rimedio al mio male si trovava proprio di fronte a me: il lago, quel Balaton che da tempo desideravo vedere.
Eravamo arrivati a Keszthely la sera tardi. Al castello avevo suonato per far uscire il custode, a cui diedi una grossa mancia affinché ci facesse da guida nei luoghi che avevano ospitato le feste dell’Helikon. Quella visita fuori dell’ordinario era stata una mia idea: Tante Helga, come chiamavo la madre di Orsolya, si era detta d’accordo, pur con le dovute riserve. «Che ci possiamo fare?» osservò infastidita. «Questo Attila sa benissimo che a certa gente è permesso di tutto oggigiorno!» Eppure la verità era un’altra. Nell’antiquato mondo ungherese in riva al Balaton volevo pavoneggiarmi davanti ai Carletter dei fasti passati, della ricchezza dei nostri avi. Avevo suonato il campanello con la baldanza del principe ereditario di ritorno a casa.
«Lo stile del parco» lesse Tante Helga consultando la guida «fu un tempo francese, mentre oggi è quello di un giardino all’inglese…»
Bachi di un giallo sulfureo, simili ad accendini lampeggianti, cadevano dalle piante ornamentali nei bacini delle fontane chiuse da cui proveniva una forte puzza d’urina. L’acqua stagnante del lago artificiale, su cui si specchiavano tritoni monchi, era da tempo stata abbandonata dai cigni. Eppure il castello stava ancora in piedi, anzi stava per giungere a termine la risistemazione degli interni.
La signora Helga, da esperta turista, chiese al custode un paio di pattine, ma non ricevette in risposta che un cenno negativo della mano. Al che si volse verso me e Orsolya, intimandoci di togliere i sandali e di portarli in mano. Non sapeva cosa ci stava chiedendo! Niente si addiceva di più al suo aspetto nibelungico che camminare a piedi nudi! Era una dama con l’aspetto di un’eroina, protagonista delle saghe germaniche, come soltanto una tedesca per metà slava può esserlo: persino i suoi vestiti sembravano ispirati dagli affreschi manieristi tipici dello storicismo. Con il suo naturale contegno di gran dama avanzava a passi incerti ma misurati attraverso i saloni silenziosi del castello. Io e Orsolya non facevamo che pestarci i piedi, senza dare nell’occhio, e le piante nude di lei mi eccitavano almeno quanto i ritratti dalle tinte imbrunite dei principi dovevano eccitare la signora Helga. Nella biblioteca presi un libro dallo scaffale, era il romanzo breve di Eichendorff, il Diario di un perdigiorno. Quell’incontro casuale mi sorprese: l’apprendista giardiniere fannullone, amato persino dalle contesse, poteva essere il mio antenato letterario. Ma lo sguardo severo di Tante Helga mi ordinò di rimettere immediatamente a posto il volume, e io pensai ancora una volta a quando avrei potuto, senza farmi sorprendere, posare furtivamente il mio piede su quello di Orsolya…
Più tardi, mentre attendevamo che partisse il traghetto per Fonyód, ci sedemmo nella pasticceria in riva al lago. C’era un bel giardino, con sedie di vimini bianchissime sul pavimento color ocra. Eppure la signora Helga si guardò intorno con aria indispettita, commentando:
«Come è cambiato l’ambiente, qui! Prima della guerra…».
Ma Orsolya l’interruppe:
«Ma io sono qui ora!».
Riempì la cannuccia di sciroppo di lampone e ne spruzzò il contenuto in aria.
«Uuhu!» disse, con il viso cosparso di gocce di sciroppo. «Ecco come si comportano i clienti al giorno d’oggi!»
Mi aspettavo che sua madre l’avrebbe fatta quanto meno a pezzi, invece accadde proprio il contrario: si fece una risata, e Orsolya cambiò improvvisamente tono.
«Non stare sempre a rivangare il passato!» la pregò, conciliante. «Se vivessimo ancora a quei tempi, Till non avrebbe alcun futuro!»
«Adesso però sei tu che non ce l’hai, Dummkopf!»*
Orsolya non rispose. Ma nel sorriso che mi rivolse c’era tutta la sua fiducia nel fatto che il mio futuro sarebbe stato una garanzia anche per il suo.
In preda alla confusione, presi il giornale che qualcuno aveva dimenticato su una poltrona. Poco prima c’era stato un temporale, il giornale si era bagnato e aprendolo avevo notato che era rotto proprio al centro: non valeva molto come paravento. Eppure, se non l’avessi aperto, non avrei mai potuto capire cosa si prova quando si crede davvero nel futuro. Non ci fu bisogno di altro, bastò l’odore madido della carta di giornale ridotta in poltiglia, delle pagine completamente impregnate di umidità e d’inchiostro, come il primo giornale che avevo comprato dopo la guerra. L’odore mi colpì, e subito scomparve, incerto e ingannevole, lasciandomi lo struggimento per qualcosa che, mi sembrava, non ci si poteva mai davvero rassegnare a perdere.
E il destino, non era forse altrettanto ingannevole? L’adolescente svogliato, sempre rimandato a settembre, lo studente che non valeva nulla, anzi era la vergogna di tutta la classe, tirato su dalla nonna, una piccola bottegaia di paese, era all’improvviso diventato un “giovane talento”, veniva invitato alle feste e persino in villeggiatura. Volsi lo sguardo su Orsolya. Sedeva con le gambe divaricate, come un ragazzo, gli occhi ancora opachi per la nuotata sott’acqua guardavano fissi in lontananza, con un’espressione vuota tipica dei bambini, mentre con la cannuccia aspirava lentamente, assonnata, il suo sciroppo di lampone. «La mia amante!» pensavo esaltato. Ormai nulla poteva più mutare, a riguardo. Pertanto chiesi magnanimamente alla signora Carletter, con la modestia che si conviene al vincitore:
«È vero che un tempo anche qui sul Balaton si svolgevano gare di cavalli? La signora Helga dovrà pur saperlo…».
Ma certo che lo sapeva! Riusciva ancora a vedersele davanti agli occhi, e vedeva anche sua nonna seduta fra le dame in tournure, con il didietro imbottito di cuscini di crine, impegnate a festeggiare la proprietaria della scuderia vincente, una contessa che – come diceva la signora tenendo il mignolo all’insù – «aveva fatto arrivare un fantino da Osaka!». Mi sforzai di mostrare un’espressione partecipe e interessata, come probabilmente aveva cercato di fare l’adolescente importato dal Giappone mentre sfilava davanti alle tribune plaudenti, con il ghigno da leopardo già scomposto dalla fatica. Annuii, ma mi sentivo estraneo proprio come il fantino, acquistato e mantenuto dall’antica famiglia di magnati…
Lontano, nel silenzio della notte di Pécs, un tram che scivolava placido sulla Király utca scampanellava tra i ricordi di Keszthely. Mi sembrava di essere sulla buona strada: il ricordo poteva risolvere il segreto del mio senso di vuoto e della mia indifferenza. Ormai cercavo di proposito di trovare elementi che mi rendessero estraneo ai Carletter e al lor...