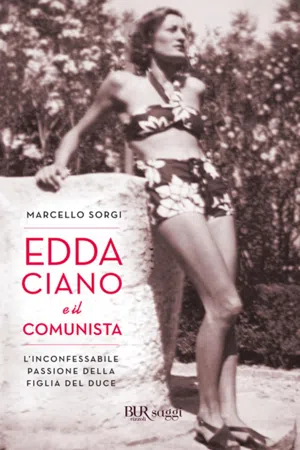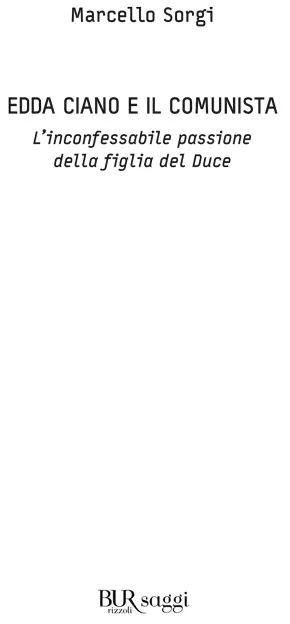![]()
![]()
Ad Antonio e Gregorio.
![]()
Prologo
L’album dei ricordi
«Eppure…»
Paino guardava gli scaffali della biblioteca, ma — si capiva — anche quelli mentali della sua memoria, che in quel momento gli faceva difetto.
«Eppure, ti giuro che stava qua, vedrai che a qualcuno prudevano le mani e chissà dove l’ha messo…»
Apparentemente, nelle due stanzette di via Maurolico, dove da sempre ha sede il Centro Studi Eoliani, regnava un ordine perfetto: libri introvabili e preziosi, sul passato e le tradizioni delle sette isole Eolie, sembravano ordinati con cura lungo le pareti. Faldoni con i dorsi colorati custodivano documenti inediti. E sui muri, foto, manifesti, cimeli, ricordi vari delle decine e decine di eventi, come si chiamano oggi, vissuti in un quarto di secolo.
Paino, Allegrino e Saltalamacchia si chiamano tutti e tre Nino, e per questo rispondono solo al cognome. Sono ellittici dei loro nomi di battesimo, tutti li conoscono così. Il Centro Studi lo hanno fondato quasi per gioco, erano ancora dei ragazzi. La prima collezione che avevano catalogato era una serie completa di fumetti di «Tex». Poi, con l’aiuto del professor Giuseppe Iacolino, memoria storica e archivio vivente della cultura e dell’epica eoliana, hanno cominciato a impegnarsi di più.
Così, dal cinema al teatro alla letteratura, a poco a poco il loro Centro è diventato un punto di riferimento, per chiunque voglia conoscere a fondo il contesto eoliano. Liparoti e amici da sempre, i tre si sono divisi i compiti: Paino, il più posato, il più riflessivo, s’è tenuto l’organizzazione. Allegrino, agile e svelto come i falchi che sorvolano la sua casa, sulla montagna dell’Alta Pecora, cura tutta la documentazione fotografica e filmata. Saltalamacchia, alto, elegante, straordinariamente gentile, introduce dibattiti e ospiti con mestiere da conduttore televisivo.
Quella mattina di inizio agosto 2007 Paino mi aspettava, come gli avevo chiesto, per parlare di confinati politici. Lipari, infatti, durante il fascismo era stata destinata a colonia penale per un migliaio di oppositori del regime, tra cui alcune delle personalità che avrebbero avuto un ruolo importante nella costruzione dell’Italia democratica e repubblicana, o che si sarebbero giocate la vita nella lotta clandestina. Da Ferruccio Parri, per dire, il primo presidente del Consiglio dell’Italia liberata, a Emilio Lussu, fondatore, con Carlo Rosselli, del movimento antifascista Giustizia e libertà. Rosselli e Lussu, insieme con il repubblicano Fausto Nitti, nel 1929 erano stati protagonisti di un’avventurosa fuga per mare da Lipari, organizzata segretamente anche con l’aiuto di esponenti dell’antifascismo liparota.
Gorgogliando tra sé in solitudine, come il rumore sordo delle onde che piano piano muovono i ciottoli sulla riva, Paino infine aveva trovato pace. Davanti a lui, su un tavolo, per terra, su due sedie, c’erano libri, documenti, fotocopie che aveva faticato a ritrovare. «Qui c’è tutto quello che può servirti» mi aveva fatto cenno con la mano. «Ma senza nulla togliere alla tua curiosità» aveva aggiunto «secondo me la storia da raccontare è un’altra. Una vicenda che nessuno è mai riuscito a esplorare e che farebbe molto riflettere.»
Non si trattava degli antifascisti. Anzi, all’opposto, di una delle prime donne sottoposte al confino per complicità con il fascismo dopo la guerra. La «sorvegliata speciale numero 1», come lei stessa amava definirsi, era Edda Ciano Mussolini, figlia del Duce e vedova dell’ex ministro degli Esteri Galeazzo Ciano. Era arrivata nell’isola nel settembre ’45, a cinque mesi dalla terribile fine del padre e dallo scempio del cadavere appeso a testa in giù a piazzale Loreto, e a ventuno dall’esecuzione del marito. Il suo confino era durato dieci mesi. A fine giugno ’46, dopo neanche un anno, era stata liberata per effetto dell’amnistia firmata da Togliatti.
Al suo arrivo a Lipari, Edda era così depressa e malata che forse non ce l’avrebbe fatta, senza l’aiuto di una famiglia — e senza l’affetto di un uomo. La famiglia che l’aveva sostenuta era quella di don Eduardu Bongiorno, capomusica della banda municipale di Lipari ed esponente antifascista, che era stato d’aiuto a Rosselli al momento della fuga dall’isola. L’uomo, di cui s’innamorò, era uno dei due figli di don Eduardu: Leonida, partigiano comunista, da poco rientrato dalla Francia, dove aveva preso parte sotto falso nome alla guerra di Liberazione.
Così Edda, che ancora si definiva «ostentatamente fascista», si legò a un uomo che altrettanto orgogliosamente esibiva la tessera del Pci. Un capopopolo che organizzava le manifestazioni degli affamati che lottavano per il pane e contro la miseria del dopoguerra. Un comunista colto e romantico, capace di aprirsi uno squarcio nel velo di solitudine della contessa: farla sorridere, renderle meno penosa la prigionia, riscoprendo con lei la poesia della vita indigena delle Eolie.
Anche se Edda nell’isola era abbastanza socievole, e la sua storia con Leonida divenne presto pubblica, tutto per anni era destinato a restare nell’oblio. Per ragioni politiche, presumibilmente, perché ancora oggi un comunista e una fascista innamorati sono difficili da accettare. Ma anche, soprattutto, per ragioni familiari: morto Leonida, suo figlio Edoardo, che porta lo stesso nome del nonno, ne aveva custodito il ricordo fin troppo gelosamente. Ed era a lui che Paino mi aveva indirizzato, per cercare di ricostruire la storia.
L’appuntamento era stato fissato per il giorno dopo. Comunque fosse andata, sarebbe valsa la pena di conoscerlo. Già a prima vista Edoardo Bongiorno si presentava come un tipo interessante. Se il nonno era stato un musicista antifascista, e il padre un soldato partigiano, Edoardo, o «Edoardino» come lo chiamavano in famiglia, aveva subito rivelato da piccolo un innato gusto per l’antiquariato.
Lo si intuiva entrando nel suo albergo, l’«Oriente», che fin dal nome celebra le nostalgie socialiste di casa Bongiorno. Tutto, anche il più piccolo spazio dei muri, era occupato da pezzi preziosi: quadri d’autore, antichi strumenti di lavoro, anfore, mobili d’epoca, vasellami decorati. E in mezzo a tanta ricchezza storica, a un patrimonio accumulato pazientemente nel tempo, con gli sguardi ristorati da tanta bellezza, ospiti inglesi e francesi facevano colazione.
In varie lingue, ma soprattutto in dialetto liparota, Edoardo scandiva con ordini precisi la vita dell’hotel. Ci volle un po’ per parlare: era molto indaffarato. E certamente il nostro primo incontro non doveva andar bene. Nel suo studio, dove il computer era appoggiato su una piccola, elegante scrivania, scolpita a mano da un abile ebanista, ci eravamo scambiati i primi convenevoli. Ma quando, senza molti giri di parole, ero venuto al dunque: «Mi dispiace» obiettò Edoardo «di questa storia se vuole possiamo parlare, ma le lettere, quelle lettere, devono restare dove stanno». Non c’era stato neppure il tempo di chiedergli di quali lettere stesse parlando. Preso com’era dall’albergo affollato, Edoardo mi aveva rinviato all’indomani.
Il giorno dopo mi mostrò tre fogli. Il primo era un messaggio scritto da suo padre, Leonida, che, dovendo partire per il fronte e non sapendo se sarebbe tornato, si raccomandava l’anima al Signore e pregava un amico di fare avere notizie ai suoi genitori. Poi, una seconda missiva, scritta molti anni dopo, era indirizzata nientemeno che al presidente degli Stati Uniti, Nixon, via ambasciata di Roma, per protestare a nome di un vecchio soldato alleato contro la guerra in Vietnam. La terza, più o meno con gli stessi argomenti, era rivolta al generale inglese Montgomery, sopravvissuto alla Seconda guerra mondiale.
Pur essendo diverse da quel che mi aspettavo, le tre lettere contenevano un assaggio della personalità di Leonida: un siciliano di grande carattere e temperamento, un garibaldino che, per il solo fatto di aver finito la guerra combattendo accanto a soldati neri che venivano dai sobborghi americani, si sentiva in diritto di rivolgersi direttamente al loro presidente. Di più, purtroppo, Edoardo non voleva dirmi. Sulle «altre» lettere, di cui aveva parlato, e a cui ovviamente ero tornato ad accennare, riteneva chiuso il discorso: «È già un miracolo che esistano ancora. Mio padre, al contrario di me, aveva un rapporto assai complesso con il suo passato. Quando mancò suo padre — mio nonno —, caricò gran parte delle sue cose, compresi i mobili, su un peschereccio, e li andò a gettare in un pezzo di mare profondo migliaia di metri. Era convinto che quando uno muore, scompare. E per lui era giusto che le sue cose sparissero appresso a lui».
Non mi lasciava molte speranze. Edoardo era stato cordiale, ospitale, colorito e generoso nei racconti, ma inflessibile sulle lettere. C’eravamo ripromessi di rivederci e riparlarne ancora. Ma, come dire, almeno da parte mia, senza molte illusioni. Se ha conservato le lettere, mi dicevo, una ragione ci dev’essere. Se non le tira fuori, ce ne dev’essere una più forte. Dopo quel colloquio ero andato in vacanza. Della storia di Edda e Leonida, s’era parlato ancora qualche volta, quell’estate, con gli amici del Centro Studi. Niente di più.
Proprio per questo fui molto sorpreso l’anno dopo, ad agosto 2008, quando Paino, rivedendomi sul corso di Lipari, mi comunicò che Edoardo voleva parlarmi. In cuor mio, avevo smesso da tempo di pensarci. Ma la notizia riaccese di colpo tutta la mia curiosità. Ci presentammo insieme la mattina dopo all’«Hotel Oriente». Per incassare, inattesa, la nuova proposta di Edoardo: lettere e altri documenti avrei potuto vederli in albergo, a patto di non portarli via di lì, né fotocopiarli, né fotografarli. Per un articolo, se era questo che avevo in animo di scrivere, uno sguardo doveva risultare sufficiente.
L’offerta era prendere-o-lasciare: l’inflessibile regolamento edoardiano mi assegnava un solo, piccolo passo avanti. Importante, seppur limitato. E accompagnato, fatto da non trascurare in una trattativa tra siciliani, da gentilezza, attenzioni e segni di amicizia e ospitalità, degni della miglior tradizione.
Così, già prima che accettassi formalmente, senza lasciarmi sfuggire l’occasione, un tavolino da lavoro, all’ombra di una palma e circondato da agavi e banani, era già stato allestito per me nel giardino tropicale dell’albergo. Un cameriere si faceva vivo ogni tanto con tè, granite e deliziose fette di crostate. Per qualsiasi dubbio, per qualsiasi curiosità, avrei dovuto rivolgermi solo a Edoardo. Ma nei dieci giorni in cui, taccuino alla mano, avevo potuto leggere l’epistolario, fu preziosa anche sua moglie, Isabella. Lei di Leonida sapeva tutto: e alla ricostruzione cartacea e documentale del personaggio, aveva aggiunto il suo punto di vista, un acuto spirito d’osservazione e irresistibili, gustosi quadretti familiari.
Dopo il lavoro sulle carte e una chiacchierata più approfondita con Edoardo, in qualche modo eravamo a metà dell’opera. Avevo crampi e calli alle dita per la quantità di righe copiate a mano dalle lettere e da vecchi libri assai rari, ma anche un quadro d’insieme della storia, con molti aneddoti e la sensazione dell’atmosfera di quel tempo. Quanto a Edoardo, come intuii dall’inizio, era soddisfatto che tutto fosse andato secondo i suoi piani. Oltre a osservarmi, tenendomi lì in albergo, poteva dire a se stesso di avermi conosciuto. Il nostro era stato un avvicinamento selvatico, cauteloso, un tantino diffidente. Un’annusata, più che una vera conoscenza, una cosa isolana. E tuttavia eravamo entrati in confidenza, come in quelle amicizie che in Sicilia si rafforzano continuando a darsi del lei, senza entrare in una vera intimità.
Malgrado ciò, sentivo che mi mancava qualcosa. Sapevo bene di non poterlo chiedere, ma quando l’idea di questo libro cominciò a farsi concreta, mi feci coraggio e chiamai Edoardo da Roma. Era fine novembre, combinammo di vederci presto. Tornai a Lipari ai primi di dicembre, in mezzo a una grande tempesta: molti tetti e case dell’isola erano scoperchiati e spezzata a metà l’unica strada percorribile. L’«Oriente» era chiuso, ma Edoardo mi aspettava lo stesso nel suo studio. Con mia meraviglia, non batté ciglio alla proposta di rivedere il materiale e approfondire nuovamente tutti gli aspetti della storia.
Finora avevo potuto sfogliare solo le trascrizioni delle lettere di Edda a Leonida. Adesso mi servivano gli originali, per poter dimostrare l’effettiva esistenza del carteggio. Subito dopo avrei dovuto vedere i luoghi, i percorsi, gli angoli in cui tutto era accaduto. E, ovviamente, per questo, avevo ancora bisogno di lui. In una vecchia custodia, c’era ancora il trombone di don Eduardu. Accanto, la valigia in pelle di Leonida, una borsa da giramondo con gli adesivi di tutti i grandi alberghi che aveva frequentato. Stavolta Edoardo non ebbe bisogno di pensarci: «Partiamo di qui e poi andiamo avanti».
Per due giorni, accompagnato da Allegrino, che saltellava come un cerbiatto con la sua macchina fotografica tra posti, cose e immagini delle diverse dimore familiari dei Bongiorno, facemmo una full immersion. Cominciammo dalla casa dei primi incontri, che Edda aveva ribattezzato Petite Malmaison e dove ancora, un po’ impolverata, c’era l’insegna di legno scolpita a mano da lei. Ritrovammo la piccozza e il cappello da alpino di Leonida, il suo documento falso, da partigiano francese. Andammo nella casa di campagna di Edoardo, per vedere le antiche foto di famiglia.
Ma la scoperta, il vero tesoro di tutta la storia, ci aspettava nella casa di Lipari. Una casa museo, con una mostra permanente dei cimeli di famiglia incorniciati e appesi alle pareti. Messo al sicuro o fatto sparire da Leonida, lì, secondo i ricordi di Edoardo, doveva esserci un grosso pacco di documenti. Appena entrati, salita la scala che s’affacciava su una traversa del corso, puntammo diritti su un vecchio armadio-libreria del salotto. Gli sportelli, chiusi da molto tempo, erano un po’ ingrossati dall’umidità. Si aprirono con qualche sforzo e con rumori sinistri, ma si aprirono.
Dall’armadio, per primo, uscì una sorta di cofanetto di cinque libri di memorie di guerra di Leonida: un’autobiografia indispensabile per capire fino in fondo l’indole e il carattere del personaggio. Poi una specie di registro: fogli di album da disegno, come quelli che avevo potuto vedere in albergo, rilegati con una copertina di cartone e un pesante dorso di legno, stretto tra due perni a vite che tenevano insieme le pagine. Al centro della copertina campeggiava la cifra «1945», sovrastata da una scritta, con il soprannome che Leonida aveva attribuito a Edda: «Con Ellenica. Su un raggio di sole. Fino al tramonto». In alto, sull’angolo destro, le iniziali: «l.b.». In basso, con la stessa grafia, la firma «leonida bongiorno» tutta in minuscolo, ripetuta anche in controcopertina.
Scritte con una piccola «lettera 22», la macchina da scrivere portatile Olivetti, usata per decenni dagli inviati speciali dei grandi giornali italiani, su ogni foglio c’erano le trascrizioni delle singole lettere di Edda. Numerate, ordinate e archiviate, quando possibile, con l’annotazione della data, del tipo di messaggio («a mano», «espresso», «cartolina») e della lingua originale («in francese», «in inglese»).
Fin qui, era quel che già sapevo e avevo avuto modo di vedere all’«Oriente». Ma finalmente, davanti ai nostri occhi, c’era il pacco lasciato da Leonida. Faticammo abbastanza a tirarlo fuori dallo scaffale, ma con un po’ d’attenzione riuscimmo a estrarlo e a poggiarlo su un tavolo. Era qualcosa di irregolare e a suo modo misterioso. Un oggetto soffice e gonfio, di settanta centimetri per cinquanta, chiuso ermeticamente con carta gommata, spago e quei piombini che si usavano un tempo per sigillare le spedizioni postali. Non si può dire quale fosse la nostra eccitazione di fronte all’involucro chiuso: a Edoardo si erano affacciate le lacrime.
Naturalmente non fu facile aprirlo. Il primo strato di carta d’imballaggio doveva rivelarne un secondo, di cellophane. Al suo interno, palline di naftalina triturata. Sotto, altra carta. Poi altra plastica, di nuovo altra carta e così per almeno quattro strati. In fondo ai quali, protetto, quasi come imbalsamato, un enorme album da fotografie, con fogli neri, ricoperti di carta lucida trasparente. Le lettere di Edda, in bella mostra, ciascuna con la sua busta e il suo timbro postale in evidenza, erano state conservate miracolosamente così. Ma non solo: come avremmo scoperto, di lì a poco, con una certa emozione, nel pacco, oltre alle lettere, c’erano gli appunti del diario di Leonida e tutta la documentazione spicciola della sua storia con Edda — dalle ciocche di capelli, ai petali di rosa, ai messaggi cifrati che i due innamorati si erano scambiati negli anni.
A giudicare dagli ultimi documenti, Leonida doveva aver sistemato tutto a metà degli anni Settanta. Una raccolta preziosa, chissà se a insaputa di lei, di materiali che andavano ben oltre lo schedario delle trascrizioni, in cui la vicenda era descritta dall’inizio alla fine con date e annotazioni che si fermavano alla primavera del ’47. Per motivi che avrei capito soltanto dopo, l’album dei ricordi, invece, si spingeva più avanti nel tempo; si addentrava nella vita dei due protagonisti anche dopo la fine della loro relazione, seminando qui e lì qualche dubbio sul fatto che un rapporto così intenso potesse essersi esaurito completamente. Seppur con qualche ambiguità, era come se Leonida avesse voluto scrivere un altro capitolo della sua storia.
![]()
I
L’incontro
Portava spesso occhiali scuri. Aveva in odio la luce sguaiata di Lipari. Teneva gli occhi socchiusi, stancamente.
Anche quella domenica, all’uscita dalla chiesa, quando l’amica, Maria Giuffrè, la tirava verso di sé preoccupata della folla, delle grida, delle facce, della polizia. Ma lei volle fermarsi a guardare.
L’uomo urlava così forte che la gente, spaventata, attorno a lui aveva fatto il vuoto. Era alto, il più alto di tutti, possente, ricordava un pirata saraceno. Urlava Leonida, eppure le sue parole erano persuasive, sommesse, pazienti: «Voi vi dovete calmare. Finitela. Così non andiamo da nessuna parte. A casa, a casa ve ne dovete andare. Altrimenti chiamo io le vostre mogli e gli dico di venirvi a prendere! A casa, ve ne dovete andare. Poi parlerò io con il vescovo…».
Per secoli la Chiesa era stata l’unica vera autorità delle isole Eolie, il piccolo arcipelago carico di storia e di mitologia, a metà strada tra Sicilia e Calabria. La Chiesa aveva amministrato la miseria e la fame, l’ignoranza e l’istruzione, la tenacia e la sopravvivenza. Era naturale che, in quel momento di disperazione, la gente si rivoltasse contro il vescovo. Non c’era la farina per il pane. Le navi arrivavano vuote. Il tempo di guerra era finito, eppure, il dopoguerra si presentava anche peggio.
«Chi è quell’uomo? voglio conoscerlo» sussurrò Edda nell’orecchio dell’amica. E Maria: «Un grande personaggio…».
Nell’ottobre del 1945, Edda Ciano Mussolini era arrivata a Lipari da un mese, come confinata politica. Ultimo approdo di una vita avventurosa e sfortunata. Paradossalmente le era toccata la stessa sorte di quel migliaio di oppositori del fascismo, destinati a pagare, nell’isola, con l’emarginazione il prezzo del loro dissenso. Edda però era una delle prime, e certamente la più illustre, delle personalità messe in cattività dalla nascente democrazia italiana.
Era stata dichiarata ospite non desiderata dalla Svizzera, dove s’era rifugiata con i suoi figli pochi giorni prima dell’esecuzione del marito, Galeazzo Ciano. E lì, dopo due anni di solitudine, isolamento e sofferenza, tra conventi e manicomi, l’aveva colta la notizia della terribile fine del padre, Benito Mussolini, e dello strazio del cadavere in piazzale Loreto.
L’avevano accompagnata alla frontiera di Chiasso, per il rimpatrio. Era stata presa in consegna da uno zelante questore e da alcuni mili...