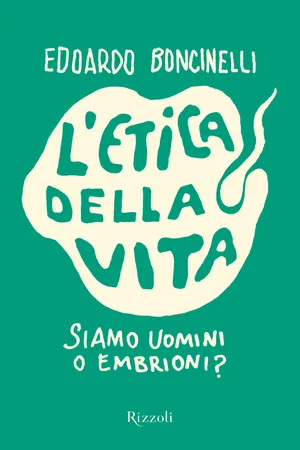![]()
1
L’inizio di tutto
La vita
La vita viene da lontano. È un’avventura cosmica cominciata su questo pianeta quasi quattro miliardi di anni fa e che va avanti ancora oggi. Senza essersi mai interrotta. È anzi proprio questa caratteristica – di passare da una generazione all’altra, da padri a figli e da nonni a nipoti, per secoli e secoli senza interrompersi – che definisce la vita più di ogni altra cosa: alberga per un po’ in un organismo e poi si trasmette.
Non si passa però dal padre al figlio direttamente, come per gemmazione o per germinazione spontanea. Per riprodursi, i padri e le madri devono generare cellule germinali particolari, dette gameti – la cellula-uovo la mamma e lo spermatozoo il papà –, ed è solo dalla fusione di due di queste cellule che può nascere un nuovo individuo. Da adulti vivi derivano gameti vivi che fondendosi nella maniera opportuna producono altri individui vivi, simili ai propri genitori ma non identici a loro. A ciascuno tocca così portare avanti la fiaccola della vita, uniformandosi a un modello comune ma offrendone ogni volta una nuova interpretazione.
Che cosa passa di importante dall’adulto ai suoi gameti e da questi al nuovo individuo? Oggi non è difficile dirlo: il DNA. IL DNA che porta il genoma di quella determinata specie con in più alcune particolarità caratteristiche della famiglia e degli antenati dell’individuo in questione. Il genoma è l’insieme delle «istruzioni» biologiche necessarie e sufficienti per far nascere, crescere, vivere e riprodurre un qualsiasi essere vivente. Contiene tutti i geni pertinenti alla specie dell’individuo, ciascuno con la particolare forma propria dell’individuo stesso. Oltre ai geni, il genoma porta probabilmente qualcosa in più che ancora non conosciamo fino in fondo e che controlla l’attività dei geni stessi, coordinandola nel tempo e nello spazio. I singoli geni forniscono i mattoni dell’edificio, mentre il genoma nel suo complesso dà le indicazioni per il piano architettonico globale e per le rifiniture che lo caratterizzeranno.
Qualunque cosa contenga, il genoma è una lunghissima molecola di DNA che porta tutto ciò che serve a un organismo biologico, scritto in maniera lineare e utilizzando un alfabeto ridottissimo, costituito di sole quattro lettere: A, G, C e T. Questo e solo questo è ciò che passa da un individuo all’altro attraverso le generazioni. Questo è allo stato attuale delle conoscenze il cosiddetto «segreto della vita», l’essenza ultima della vita biologica. Il DNA del genoma non viene però mai «passato» nudo da un organismo all’altro, ma sempre rivestito di altre molecole biologiche e all’interno di una cellula. Esso è infatti contenuto nella parte più gelosamente custodita di questa, il nucleo cellulare, ed è suddiviso per ragioni pratiche in un certo numero di frammenti, ciascuno dei quali avvolto su un «rocchetto» di molecole specifiche che noi chiamiamo cromosoma.
Nella specie umana i frammenti nei quali è suddiviso il dna sono 23 e sono chiamati cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3 e via discorrendo. Nelle cellule del nostro corpo ci sono appunto i 23 cromosomi umani, ma ciascuno è presente in doppia copia. Abbiamo così un totale di 46 cromosomi, due copie del cromosoma 1, due del cromosoma 2, due del cromosoma 3 e così per tutti. Per ciascun tipo di cromosoma, una copia, non sappiamo quale, ci è venuta da nostra madre e una da nostro padre, che ce le hanno trasmesse attraverso i gameti. I gameti, tanto maschili quanto femminili, portano infatti una sola copia di ogni tipo di cromosoma e ne contengono quindi in tutto 23, così che quando si fondono l’uno con l’altro ricostituiscono il patrimonio di 46 cromosomi.
I gameti
Nel caso nostro, come in quello di tutti gli animali superiori, alla formazione di un nuovo individuo concorrono quindi due genomi: uno portato dalla cellula-uovo della mamma e uno portato dallo spermatozoo del babbo. In questo senso, quello che ne risulta è un individuo veramente nuovo e unico, che ha qualche caratteristica biologica della famiglia della mamma e qualche caratteristica biologica della famiglia del papà. Nessuno ha però un genoma che sia l’esito della semplice combinazione dei corredi genetici dei genitori.
Ciascuno di noi, infatti, porta nel suo genoma molte centinaia di migliaia di piccole alterazioni, dette mutazioni, che lo distinguono da ogni altro. Alcune le aveva dalla nascita, altre le ha acquisite durante la vita. Nel loro complesso tali mutazioni determinano la specificità genetica di ogni singolo individuo. La stragrande maggioranza di queste non ha alcun effetto pratico – altrimenti saremmo tutti pieni di difetti genetici, grandi e piccoli – ma alcune ce l’hanno, anche appena percettibile. Al momento di produrre un gamete, il genoma delle cellule che lo generano viene assoggettato per natura a un ulteriore rimaneggiamento, chiamato ricombinazione, che ridistribuisce in maniera casuale tra i due cromosomi di ogni coppia le mutazioni già esistenti nella cellula con il risultato che non ci saranno due gameti uguali nemmeno fra quelli prodotti dallo stesso soggetto. Se consideriamo poi che ciascun individuo proviene dall’unione di due gameti diversi, è evidente che esso sarà geneticamente unico in tutto e per tutto.
Lo zigote
La costruzione di un nuovo individuo, unico e irripetibile, inizia quindi con la fecondazione della cellula-uovo materna da parte dello spermatozoo paterno. Si tratta di un processo lungo e complicato che culmina, quando culmina, con la congiunzione dei due genomi derivanti dai due gameti di partenza. A questo punto si parla di cellula-uovo fecondata, o di zigote. Per la nostra specie la fecondazione può essere chiamata concepimento, e si può definire concepito il risultato della stessa.
Lo zigote contiene in potenza tutte le informazioni genetiche necessarie per dar vita a un individuo. Possiamo pertanto dire che lo zigote è già un individuo? Direi di no. Per due ragioni distinte, anche se di diversa importanza.
In primo luogo, si calcola che solo un quinto degli zigoti arrivino a produrre un individuo vivo. Di tutti quelli che partono con le carte in regola, fra il 70 e l’80 per cento non conducono in realtà a niente, per una lunga serie di incidenti di percorso; e le stime potrebbero essere in grave difetto, considerando le difficoltà di rilevazione di un fenomeno dai tratti così sfuggenti.
In secondo luogo, dallo zigote possono svilupparsi due (o più) gemelli, detti monozigoti – perché derivanti appunto da un solo zigote – o identici – perché dotati dello stesso patrimonio genetico – invece che un unico essere umano. Ciò accade con una frequenza di un parto su 400, una frequenza bassa ma non trascurabile, come dimostra la presenza di coppie di gemelli identici in tutte le parti del mondo.
Lo zigote si può considerare quindi un progetto di individuo, ma non ancora un individuo, perché può non portare a nulla, oppure a due o più individui distinti.
Lo zigote presenta alcune caratteristiche genetiche e presto avrà alcune caratteristiche biologiche. Ci possiamo chiedere a questo punto: qual è il rapporto fra genetico e biologico? In un adulto o anche in un giovane di quindici anni, la differenza fra le due cose è macroscopica. La sua individualità genetica è custodita nel genoma delle sue cellule, che corrisponde, almeno in prima approssimazione, a quello presente nello zigote dal quale deriva. La sua individualità biologica, invece, è il frutto di molteplici fattori: delle istruzioni contenute nel suo genoma, certamente, ma anche di tutto quello che gli è successo durante i mesi dello sviluppo embrionale e gli anni della sua vita fino al momento che stiamo prendendo in considerazione. Anche senza esaminare le raffinatezze della sua mente e della sua psiche, il nostro individuo porterà in tutto il suo essere biologico i segni delle esperienze vissute. Il modo in cui si è nutrito, le malattie che ha avuto, i traumi fisici o biologici ai quali è andato incontro, ma anche gli esercizi sportivi che ha potuto fare: tutto questo avrà forgiato il suo corpo, sia in potenza che in atto, e avrà contribuito a costruire la sua individualità con moltissime caratteristiche biologiche, in aggiunta a quelle dettate dal suo patrimonio genetico.
Un po’ più sottile si presenta il caso di due gemelli identici anche appena sbozzati. Condividono, è vero, il genoma, ma quando rileviamo la loro divisione sono passati già alcuni giorni dalla formazione dello zigote dal quale sono entrambi derivati. Sono sufficienti pochi giorni ad autorizzarci a pensare che siano già biologicamente distinti? Direi proprio di sì. Il fatto che siano distinguibili almeno per la loro posizione mi permette di pensare che qualcosa di specifico sia successo in ciascuno dei due. Ciò che può essere distinto non potrà che essere distinguibile, dicono alcuni filosofi. Ed è infatti perfettamente concepibile che sia così. Qualche piccola differenza nei processi biologici della prima formazione deve pur esserci stata, se sono due invece di uno e se uno si trova da una parte dell’utero e l’altro dall’altra.
Direi che la lezione è chiara: fin dai primissimi istanti dopo la fecondazione, entrano in gioco un complesso di fenomeni biologici che, pur basandosi sulle direttive impartite dal genoma, introducono elementi di specificità e quindi di unicità. Gli abbozzi di due gemelli identici sono quindi biologicamente, anche se non geneticamente, distinti fin dal loro primo apparire. La loro biologia si è già leggermente scostata dal loro assetto genetico e non c’è motivo di pensare che ciò non sia vero anche per qualsiasi abbozzo di embrione, anche se si sta sviluppando da solo. Torneremo ancora su questo tema, ma fin da ora possiamo dire che lo scostamento fra la biologia e la genetica comincia di fatto dai primissimi eventi susseguenti alla fecondazione, o che addirittura prende l’avvio in contemporanea al procedere di questa.
La fecondazione
Sarebbe interessante vedere quali passi sono necessari perché avvenga la fecondazione e perché si giunga infine alla congiunzione dei due genomi all’interno della cellula-uovo fecondata. Questo non è un libro per specialisti e non mi soffermerò su tale processo, se non per delinearne le tappe principali.
L’incontro fra la cellula-uovo e lo spermatozoo avviene di solito verso l’estremità di una delle due tube ovariche della madre, dette anche tube di Falloppio o ovidotti. I due gameti ci sono giunti provenendo da direzioni opposte: la cellula-uovo ci è arrivata dall’ovario più vicino, mentre lo spermatozoo è passato dalla vagina all’utero e da questo è risalito per la tuba fin quasi alla sua estremità, dove è avvenuto l’incontro.
L’uso del singolare è appropriato per la cellula-uovo, ma non altrettanto per lo spermatozoo. È una sola infatti, nella maggior parte dei casi, la cellula-uovo giunta a maturazione che viene rilasciata dall’ovario al momento dell’ovulazione e catturata dall’estremità della tuba ovarica più vicina. Tale estremità semiaperta presenta delle proiezioni a forma di dita, chiamate fimbrie, sulla cui superficie si trova una proteina specifica che riconosce la cellula-uovo e la «risucchia» all’interno della tuba stessa.
Lo spermatozoo che feconda la cellula-uovo, dal canto suo, è uno, ma solo perché è l’unico prescelto all’interno di un vero e proprio stormo. Si calcola che non siano meno di 280 milioni gli spermatozoi immessi all’interno dell’apparato femminile per ogni atto di concepimento naturale, anche se di questi soltanto 200 circa raggiungono la regione tubarica più adatta per la fecondazione, cioè quella terminale. Durante il viaggio, che può durare anche sei giorni, gli spermatozoi vanno incontro al fenomeno della capacitazione, un processo maturativo definitivo che li mette nella condizione migliore per penetrare poi all’interno della cellula-uovo.
Perché tutta l’operazione abbia luogo con successo, però, occorre che siano soddisfatti certi requisiti.
Innanzitutto lo spermatozoo e la cellula-uovo si devono riconoscere, presupposto essenziale per la successiva entrata in contatto. Tanto la cellula-uovo quanto il tratto riproduttivo femminile secernono pertanto molecole che attraggono e attivano gli spermatozoi. Quando uno spermatozoo che abbia subito la capacitazione nella maniera appropriata si accosta alla cellula-uovo, deve per prima cosa superare il suo involucro esterno, chiamato zona pellucida, e lo fa rilasciando enzimi digestivi da una struttura particolare che si trova all’apice della testa e che è chiamata acrosoma. Gli enzimi creano così nella zona pellucida un varco dal quale può passare lo spermatozoo per penetrare al suo interno.
A questo punto le membrane cellulari dei due gameti entrano in contatto, si fondono e inizia il vero e proprio processo di fecondazione. È essenziale però che sia un solo spermatozoo a penetrare nell’uovo, altrimenti il corredo genetico finale dello zigote non sarebbe quello giusto. La presenza di due o più spermatozoi all’interno della cellula-uovo condurrebbe infatti a un eccesso di materiale genetico e a una precoce disgregazione della cellula fecondata. Ogni specie ha sviluppato una sua strategia per prevenire eventi del genere. Nei mammiferi l’entrata del primo spermatozoo nella cellula-uovo elimina dalla sua zona pellucida le molecole che attraggono e riconoscono gli spermatozoi. Non si potranno così legare a quella cellula altri spermatozoi e quelli già entrati in contatto verranno «scossi» via. Nessun altro spermatozoo quindi potrà più accostarsi e a maggior ragione entrare. Chi è entrato è entrato e nessuno lo potrà seguire.
Non è lo spermatozoo «più veloce» quello che vince la gara, come talvolta si sarebbe erroneamente tentati di credere, né il più forte, ma uno qualsiasi di quelli che sono arrivati più preparati a contatto con la cellula-uovo. In buona parte è quindi una faccenda casuale: di tanti che sono partiti e di quanti sono giunti al termine del viaggio, uno solo è quello che darà luogo a uno specifico concepito. Fa un certo effetto pensare come la natura genetica di quella che, se tutto va bene, sarà una specifica persona dipenda da una successione di eventi casuali.
Perché sia stato concepito proprio io è stato necessario che mia madre, quella specifica donna, e mio padre, quello specifico uomo, si siano conosciuti; che si siano piaciuti e che abbiano deciso di intrattenere una relazione di una certa stabilità. E abbiano avuto dei rapporti nel periodo specifico durante il quale si è liberata in una tuba di mia madre quella specifica cellula-uovo delle tante che erano in attesa del loro turno nell’ovario; e infine che sia stato quello specifico spermatozoo a vincere la gara della fecondazione. Dato che tutto è andato avanti liscio per il resto della gestazione, sono nato io. Che cosa sarei stato se uno qualsiasi di questi eventi avesse preso un’altra piega? Se fossi stato concepito un anno, un mese o un giorno prima? Sarei ancora io? E chi sarei stato se semplicemente a vincere la lotteria della fecondazione fosse stato un altro spermatozoo? La dotazione genetica di tutti questi individui sarebbe stata diversa dalla mia, ma la loro consapevolezza? Domande affascinanti, domande senza risposta.
Ma andiamo avanti. La fusione delle membrane cellulari dei due gameti dà inizio anche alla cosiddetta attivazione dello zigote, ovvero a una serie di eventi metabolici necessari per arrivare al vero e proprio zigote, capace di sintetizzare nuovo DNA e nuove proteine. L’evento iniziale di questo processo è la liberazione di uno sciame di ioni di calcio prima imprigionati nelle strutture subcellulari della cellula-uovo. Lo zigote attivato è uno zigote pronto per compiere la serie di operazioni che lo attendono, prima fra tutte la divisione cellulare, una volta che sia avvenuta la fusione dei due nuclei cellulari che portano i genomi, e che può andare in porto anche 12 ore dopo la penetrazione dello spermatozoo.
Lo sviluppo
Lo zigote racchiude in sé il patrimonio genetico e la dotazione biologica immediatamente necessaria per condurre allo sviluppo di un essere umano. Quest’ultimo finirà per contenere circa 50.000 miliardi di cellule, delle quali 1000 miliardi circa solo nel cervello. Si chiama sviluppo, o sviluppo biologico, il complesso di eventi che conducono dalla singola cellula rappresentata dallo zigote all’insieme organizzato del grandissimo numero di cellule che costituiscono il corpo di un adulto. All’interno di tale processo si può distinguere uno sviluppo embrionale, denominato anche embriogenesi, che dura fino alla nascita, e uno post-embrionale, che include anche il fenomeno della crescita e che dura teoricamente tutta la vita, ma che conduce a un individuo maturo intorno all’età riproduttiva.
Il compito è quindi immane. Occorre generare tante cellule e conferire a ciascuna di esse le istruzioni che le spettano e che si dividono in due grandi categorie: quelle che riguardano il suo destino istologico e quelle che specificano la sua posizione finale nel corpo. Ogni cellula deve sapere, in sostanza, a quale tipo di tessuto – pelle, muscolo, osso, nervo, ghiandola e così via – finirà per appartenere e in quale parte del corpo andrà a collocarsi. Tali informazioni verranno in primo luogo direttamente dal genoma, ma sarà di certo fondamentale anche il contributo della fitta rete di segnali che le varie cellule si scambiano fin dai primissimi momenti dello sviluppo. L’una cosa e l’altra sono alla base di quanto succede in un embrione in via di sviluppo, ma anche di ciò che accade in qualsiasi organismo durante tutto l’arco della sua vita.
È evidente che quanto avverrà, avverrà per gradi. Per gradi si passerà da poche cellule a tante cellule, per gradi ciascuna cellula si avvicinerà al raggiungimento dell’identità che le spetta, per gradi le varie parti del corpo acquisteranno la loro piena funzionalità. Ogniqualvolta ci siano le condizioni per farlo, i meccanismi dello sviluppo corporeo si dipaneranno e si articoleranno, procedendo verso l’obiettivo finale della formazione di un corpo adulto.
Lo sviluppo non torna mai indietro, anche se a varie riprese si arresta momentaneamente per attendere un input esterno, e le sue varie fasi si succedono in fretta, prendendo ciascuna il tempo strettamente necessario per l’adempimento del proprio compito. Lo sviluppo embrionale, in particolare, è come una palla di neve che rotola a valle: non percorre sempre obbligatoriamente la stessa traiettoria – c’è una certa variabilità – ma arriva sempre e comunque in basso. In poche ore, in qualche giorno o impiegando diverse settimane, a seconda della specie di appartenenza.
Da quanto tempo sappiamo queste cose? Da poco. Abbiamo dovuto attendere la disponibilità di un buon microscopio per renderci conto dell’esistenza stessa dei gameti femminili. Non è facile infatti vedere a occhio nudo una cellula-uovo, tanto che fino al Settecento non si capiva bene quale fosse il ruolo della donna nella riproduzione e si ignorava che anche lei contribuisce alla formazione del patrimonio genetico dei figli. Si è dovuto attendere il 1876 perché qualcuno osservasse, nel riccio di mare, la penetrazione di uno spermatozoo in una cellula-uovo, vale a dire l’evento centrale della fecondazione. Per quanto riguarda poi i meccanismi fondamentali dello sviluppo biologico, tutto quello che sappiamo l’abbiamo appreso negli ultimi cento anni e la parte più interessante negli ultimi trenta. E c’è ancora tanto da imparare.
Settimane fondamentali
È abbastanza comprensibile che lo sviluppo del nostro corpo ci inter...