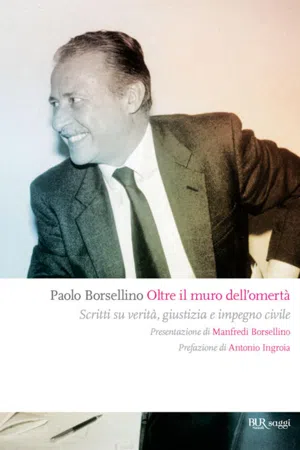Prefazione
Questo non è un libro dedicato a Paolo Borsellino. Non è una delle tante, assai pregevoli, opere sulla sua vita, sulla sua carriera e la sua attività, o sulle indagini per la strage di cui rimase vittima, assieme ai poliziotti di scorta, quel pomeriggio d’inferno del 19 luglio 1992. Non è una di quelle opere, insomma, che sono fiorite spontaneamente attorno alla sua figura a testimoniare come quest’uomo sia, a tutti gli effetti, un eroe moderno della nostra democrazia.
Questo è un libro di Paolo Borsellino. In queste pagine si trovano le sue parole, la sua straordinaria umanità, la sua lucidità inossidabile. La sua modestia e la sua passione. La sua riservatezza e il suo coraggio.
Borsellino è stato e rimane, indiscutibilmente, un esempio. L’insegnamento della sua vita cancella con un soffio i modelli attualmente imperanti, imperniati sulla furbizia, sulla prevaricazione, sull’indifferentismo etico e sull’egoismo sociale.
Aveva grande energia, che impiegava sempre e senza riserve. Aveva fede, in Dio e nell’uomo. Era cosciente dei limiti della propria opera, ma al contempo era fiducioso nelle capacità di riscatto, anche nelle condizioni peggiori, che vive in ognuno.
Era saggio, perché profondo e semplice. E sapiente, nel senso più nobile del termine. Mai, però, volle scrivere un libro.
Come sa bene chi lo ha conosciuto da vicino e per lungo tempo, chi ha avuto la fortuna e il privilegio di frequentarlo nelle aule di giustizia, ma anche fuori dai palazzi blindati, era persona colta, che amava le buone letture e le buone conversazioni. Con lui si poteva parlare di tutto, era pronto ad aprire pagine di storia controverse così come a raccontare coloriti aneddoti in puro dialetto siciliano. Ma aveva anche il gusto di rammentare versi indimenticabili, come, per esempio, quelli dedicati a Palermo da Wolfgang Goethe. Gli piaceva recitarli a memoria, in tedesco, rimarcare l’apprezzamento che riscuoteva la sua amata città natale. Conservava però la consapevolezza, come specifica lui stesso in un passo che troverete riportato nel libro, che si ama ciò che non piace, ciò che si vorrebbe cambiare. Nos queremos Espana porque no nos gusta, dice Borsellino, citando un celebre detto spagnolo.
Eppure mai si concesse di scrivere un saggio o uno dei tanti testi di mafiologia – lui, vero esperto di mafia – che hanno poi invaso le nostre librerie e biblioteche. La sua umiltà gli faceva ritenere di essere un uomo d’azione più che di concetto. Ma che concetti, idee chiare e pensieri profondi innervassero tutto il suo agire è dimostrato dai suoi (pochi) scritti e dai suoi (tanti e generosi) interventi pubblici a convegni, manifestazioni o incontri con gli studenti nelle scuole.
Questo libro assolve, quindi, un compito importante. Restituire, senza mediazioni narrative, un autoritratto «pubblico» di Paolo Borsellino, in tutte le sue sfaccettature e angolazioni.
Tra queste righe ritroviamo il conferenziere dei convegni giuridici, alle prese con gli stessi problemi che sembrano ripetersi eguali in questi ultimi decenni e il magistrato che elaborava riflessioni originali e importanti, ancora attualissime: sul processo penale, sul ruolo del pubblico ministero, sull’indipendenza e l’autonomia della magistratura, sulle prospettive di riforma per rendere più efficiente l’azione giudiziaria di contrasto al fenomeno mafioso.
Nelle sue parole rintracciamo il giudice che partecipava ad appassionati dibattiti sulla lotta alla mafia, sulle campagne politico-mediatiche di denigrazione della magistratura e delle sue indagini, e sul rischio di «normalizzazione» (vale a dire dell’addolcimento delle norme antimafia), e possiamo riconoscerlo come il simbolo della lotta quando parla agli studenti per costruire una nuova cultura della legalità, intrisa di alti valori etici, una cultura della vita contro la violenza della morte, una cultura della parola contro l’incultura dell’omertà mafiosa. Infine, ricordiamo l’uomo Borsellino che pronuncia, prima sommessamente, e poi a voce sempre più alta, parole commosse di dolore e indignazione alle veglie funebri degli amici e colleghi uccisi da Cosa Nostra.
Questo libro è una raccolta di scritti. Ci sono le relazioni ai convegni giuridici, ci sono le scalette delle conferenze nelle scuole, la trascrizione degli interventi a tavole rotonde e gli appunti preparatori alle interviste. Ci sono perfino i manoscritti, particolarmente emozionanti, per preparare i suoi interventi alle veglie funebri in onore di Giovanni Falcone, vergati di suo pugno.
Sono scritti che coprono un arco temporale di quasi un decennio, una parabola che prende avvio nel 1984, l’anno della speranza, del maxiprocesso, durissimo e duraturo colpo all’impunità di centinaia e centinaia di mafiosi, e che conduce, attraverso la fine degli anni Ottanta – gli anni della disillusione, della rimozione, delle polemiche sui professionisti dell’antimafia, e delle campagne di delegittimazione e smantellamento del pool – al 1992: stragi, disperazione, indignazione. Il 1992 però è anche l’anno della reazione, che troverà per sempre nelle parole-testamento di Paolo la propria bandiera.
Borsellino ci lascia insegnamenti, giudizi e riflessioni. La mappa per leggere il nostro passato e la memoria per costruire il nostro futuro, da custodire come un’eredità, pesante e scomoda per le nostre fragili spalle, ma da preservare con cautela.
Quello che colpisce in queste pagine è, in primo luogo, la straordinaria attualità delle questioni affrontate. Il che dimostra come su alcuni terreni il nostro Paese faccia fatica a progredire, muovendosi come un gambero con pochi passi avanti e tanti passi indietro.
In secondo luogo, poi, impressiona la franchezza di Paolo nell’affrontare qualunque tema: una schiettezza nota a chi lo conosceva, ma che sulla pagina appare di una trasparenza nitidissima. E così il suo pensiero, come viene fuori dal suo discorso diretto, è spesso ben diverso dall’immagine mediata e divulgata.
Un nodo cruciale spesso affrontato da Borsellino nei suoi scritti, per esempio, è quello del «pentitismo», argomento controverso e a lungo dibattuto. I collaboratori di giustizia, arnese indispensabile per penetrare all’interno di un’organizzazione criminale segreta come Cosa Nostra, sono uno strumento investigativo che Borsellino difende a spada tratta. Le sue parole sono nette e non lasciano spazio a interpretazioni. «Vanno respinte» dice «le argomentazioni di coloro i quali sono arrivati perfino a sostenere che le dichiarazioni dei pentiti non hanno di per sé alcun valore probatorio, pressoché alla stessa stregua di una lettera anonima, e possono essere utilizzate soltanto come spunto di successive indagini.» E non rinuncia a manifestare il proprio sdegno di fronte a coloro i quali «sono addirittura arrivati ad affermare che la chiamata di correo priva di riscontri degraderebbe un indizio a mero elemento di sospetto se nel corso del processo non intervenissero validi riscontri estrinseci di essa».
Ebbene, a ben riflettere, le idee e i giudizi che facevano allora scandalizzare Borsellino non sono forse oggi quotidianamente proposti da autorevoli opinionisti e politici in modo ben più diretto, aperto e provocatorio?
La sincerità dei suoi scritti lascia affiorare anche sentimenti ed emozioni. C’è il Borsellino amareggiato, che a un anno dall’omicidio dei suoi collaboratori, due coraggiosi investigatori come Ninni Cassarà, il dirigente della Squadra Mobile di Palermo, e Beppe Montana, il dirigente della Sezione Catturandi, ricorda la scia fatale che aveva travolto il primo dopo che ebbe pronunciato la frase «convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano», parole poi ripetute da Paolo stesso.
C’è il Borsellino arrabbiato, che denuncia le «omissioni che resero più agevole il compito degli assassini di Cassarà, Montana e Antiochia», e non omissioni qualsiasi, ma «omissione dei responsabili organi statuali centrali». Era un uomo dello Stato, insomma, pronto a denunciare lacune e carenze dello Stato medesimo nel sostegno e nella protezione dei suoi servitori più impegnati sul fronte della lotta alla mafia, altro che silenzioso funzionario reticente nell’esternare il proprio punto di vista, come spesso è stato descritto.
C’è il Borsellino indignato, che si scaglia contro la tentazione di «normalizzazione», e cioè di ridimensionamento degli strumenti di contrasto alla mafia, ai quali si ricorre solo nei momenti in cui appare necessaria una risposta di tipo «emergenziale». Sotto l’urto, cioè, di un’emozione nazionale, in genere coincidente con un nuovo bagno di sangue deciso dai vertici di Cosa Nostra.
La sua indignazione arriva a sconfinare nella contestazione politica quando segnala il rischio che «dietro il paravento della normalizzazione» si pervenga «a una frettolosa smobilitazione dell’apparato antimafia e coloro che, doverosamente e dolorosamente, hanno ritenuto in questa lotta di trovarsi in prima fila non vengano addirittura additati, come recentemente è avvenuto, alla pubblica esecrazione».
Ebbene, non è forse, di nuovo «recentemente avvenuto»? Non sentite correre un brivido lungo la schiena nel...