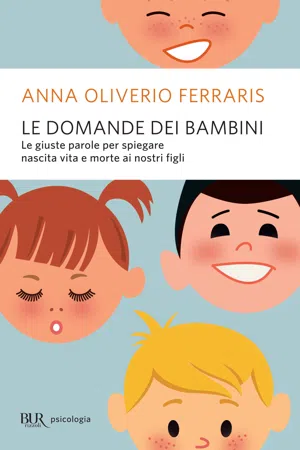
eBook - ePub
Le domande dei bambini
Le giuste parole per spiegare nascita vita e morte ai nostri bambini
- 304 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Le domande dei bambini
Le giuste parole per spiegare nascita vita e morte ai nostri bambini
Informazioni su questo libro
I bambini ci rivolgono spesso domande davanti alle quali ci troviamo in difficoltà. Riguardano le questioni ultime, i fondamenti dell'etica, l'amore e il sesso. Sono domande difficili perché riguardano questioni fondamentali che spesso noi per primi preferiamo evitare, e per le quali facciamo fatica a 'trovare le parole giuste', quelle che riescono a toccare il cuore e la mente dei bambini. Anna Oliverio Ferraris passa in rassegna tutte le domande più comuni dei bambini e propone alcune tracce di risposta, a seconda delle diverse età.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Le domande dei bambini di Anna Oliverio Ferraris in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788817108003eBook ISBN
9788858623404[1]
PARLARE, PERCHÉ, COME...
Mamma, perché Nicola ha due papà? Perché io ne ho uno solo?, Chi sono i gay?, Perché ci sono le guerre?, Cos’è l’aborto?, Dove si va quando si muore?, Cos’è l’amore?, Perché mi avete adottato?
Queste sono alcune delle numerose domande che possono porre i bambini d’oggi; domande diverse rispetto a un tempo, anche se fanno parte di quell’immutabile curiosità infantile che ha sempre spinto i bambini a chiedere il perché di ogni cosa.
Un tempo i genitori, che vivevano in una società regolamentata da norme facilmente riconoscibili e dove i bambini erano tenuti al riparo da notizie troppo inquietanti, avevano meno difficoltà a rispondere alle domande dei figli, o se queste domande erano troppo difficili potevano cavarsela con la classica risposta: «Sei ancora piccolo per queste cose». Oggi, la situazione è radicalmente mutata. Il mondo si muove, i bambini anche, ma a ritmi diversi, più veloci. Esposti a ogni tipo di messaggi, osservano e «assorbono» il mondo che li circonda; un mondo che non ha più i colori pastello dell’affettività e del sogno, ma quelli dei contrasti sociali e politici. Povertà, malattie, morte, razzismo, guerre, criminalità: la violenza in tutte le sue forme li aggredisce. È difficile fare «come se» quella o quell’altra realtà non esistesse quando la strada, la scuola e la televisione sono lì per ricordarle. Compito complesso per i genitori, che devono trovare un compromesso tra i sogni del bambino e la realtà. Tra mostrare o nascondere la verità, tra dire tutto o dire niente. Anche il rapporto tra genitori e figli è cambiato, non è più improntato all’autorità ma all’amicizia, il che rende più difficile eludere le domande o cavarsela con le bugie. Ovviamente, si tratta di una forma di «amicizia» particolare perché un genitore resta pur sempre un adulto, che ha una sua esperienza alle spalle, deve assicurare protezione, insegnare a crescere, guidare.
Genitori e figli
Il diverso rapporto che si è creato tra genitori e figli è un fatto abbastanza recente. È cambiato a partire dagli anni Sessanta-Settanta del Novecento. Allora sembrava che questo cambiamento avrebbe reso tutto più facile, che un rapporto più democratico con i figli avrebbe risolto una serie di problemi tradizionali tra le generazioni. In realtà, se per alcuni aspetti il rapporto tra adulti e bambini è diventato più individuale e meno istituzionale, i problemi non sono finiti, perché nel frattempo la società è andata incontro a un cambiamento vertiginoso che ha investito le tecnologie, il lavoro, i rapporti tra i sessi e soprattutto la stessa famiglia. Il numero di «terzi genitori» è in aumento, le famiglie separate e ricomposte sono ormai un aspetto usuale dello scenario in cui viviamo e tutti questi cambiamenti generano interrogativi da parte dei bambini che, per loro natura, sono molto simili a quelli di un tempo: conservatori negli affetti, alla ricerca di sicurezza, di continuità, di punti di riferimento, di indicazioni. Anche i genitori più preparati possono perciò sentirsi a disagio quando i figli incominciano a porre i primi perché: perché che non riguardano più soltanto i tradizionali: «Da dove vengono i sogni?», «Perché i nonni sono vecchi?», «Perché i maschietti fanno pipì in piedi?», ma situazioni che possono andare oltre il loro vissuto individuale e che li raggiungono, in modo per lo più estemporaneo, attraverso i teleschermi, la pubblicità stradale, i discorsi degli altri bambini.
C’è poi un altro aspetto. In questi ultimi anni la cultura psicologica si è molto sviluppata e sono molte ormai le persone consapevoli del fatto che l’infanzia è l’età in cui vengono gettate le fondamenta della personalità dell’ adulto, della sicurezza o insicurezza, dell’ottimismo o pessimismo, dell’autostima o della scarsa stima di sé. Gli adulti, quindi, cercano di agire per il meglio, di non compiere troppi errori; ma spesso è proprio questa nuova coscienza delle esigenze e delle capacità di apprendimento infantili a bloccarli, per il timore di compiere mosse sbagliate. Tutti quanti prima o poi veniamo assaliti da dubbi e scrupoli: è opportuno dare alcune risposte? A che età è giusto rispondere in un modo piuttosto che in un altro? Che tipo di valori è bene instillare nei figli, in una società in cui i valori sono diversi da gruppo a gruppo o in cui a volte sembra non esistano valori certi?
Partendo da domande poste dagli stessi bambini, nelle pagine che seguono verranno affrontati temi che riguardano aspetti fondamentali della nostra vita e il loro significato, tenendo presenti due aspetti importanti: i bisogni della crescita, legati a una dimensione psicologica, e le caratteristiche di una società ad alto livello tecnologico e sempre più multietnica, fatta cioè di bambini che frequentano classi sempre più «colorate», che giocano con piccoli robot elettronici, che mettono mano al computer, usano cellulari e sono, in genere, tecnologicamente più esperti dei loro nonni e talora dei loro stessi genitori. Nella società di oggi, però, molti conoscono il come ma non il perché, la funzione ma non il significato, i risultati ma non le cause. I bambini, invece, con la loro mente fresca, aperta alla conoscenza, curiosa e libera, ci riportano ai quesiti di fondo, ci inducono a riflettere sui valori; in altre parole, ci coinvolgono in un atteggiamento filosofìco, creano i presupposti per un dialogo in cui chi pone domande si attende delle risposte significative; hanno bisogno di noi per orientarsi, per chiarire a se stessi le sensazioni che provano, per capire il mondo.
Se questa comunicazione tra l’adulto e il bambino viene inibita, bloccata o sviata sul nascere – perché noi adulti ci sentiamo impreparati o non sappiamo cosa dire o abbiamo i nostri problemi psicologici, per cui alcuni temi per noi sono diventati tabù inaffrontabili – si verifica un graduale restringimento della comunicazione e dei rapporti: questi diventano sempre più centrati sulle cose e i mezzi per ottenerle e sempre meno sui significati, su ciò che sta a cuore. Esiste un’età critica tra i 3-4 e gli 11-12 anni in cui vengono poste le basi del dialogo tra genitori e figli, tra generazioni diverse: qualche volta gli adulti possono ignorare alcune risposte, ma non possono ignorare l’arte del dialogo, le strategie da seguire per restare in sintonia con i loro figli, nipoti e alunni. I tempi sono importanti, soprattutto per chi cresce ed evolve: se perdiamo l’opportunità di comunicare serenamente con i nostri figli quando sono bambini diventa poi difficile recuperare il dialogo quando sono più grandi. Se li abituiamo a parlare fin da piccoli, non soltanto continueranno a voler conoscere il nostro pensiero anche in seguito, ma avranno anche modo di sviluppare le loro abilità espressive e comunicative e, con il tempo, diventeranno abili nel ragionamento e nel pensiero critico.
Questo libro presenta una serie di domande su temi «difficili», ma non vuole certamente dare risposte prefabbricate: vuole invece, attraverso riflessioni, esempi e metafore, iniziare gli adulti all’arte del dialogare con i bambini alla luce delle conoscenze della psicologia dello sviluppo. Questo nostro cammino deve però, necessariamente, iniziare con una riflessione sulla natura della comunicazione: un’attività che consideriamo ovvia, scontata, ma di cui in realtà non sempre consideriamo le implicazioni, le potenzialità e le insidie.
Parlare per comunicare
Tutti i genitori dovrebbero trovare del tempo per conversare con i figli su argomenti diversi, non certo per avere ragione, per «vincere», o per imporre il proprio punto di vista, ma per offrire loro un modello di dialogo sereno, dare loro l’opportunità di esercitarsi nell’uso della parola, rispondere ai quesiti, fornire spunti di riflessione, di approfondimento. Il metodo è quello maieutico (o socratico) che aiuta a ragionare, insegna ad ascoltare e a esprimersi chiaramente, non si basa sulla sopraffazione ma sulla comprensione. Un ottimo esercizio anche per noi adulti, che spesso siamo troppo impegnati a dare direttive, giudicare, valutare.
Un primo punto da tenere presente è che parlare e comunicare non sono la stessa cosa: si possono dire molte parole senza comunicare alcunché, al contrario, poche parole, un cenno, un atteggiamento possono comunicare più di un lungo discorso. Inoltre, poiché la comunicazione si muove contemporaneamente su diversi piani, le parole possono nascondere messaggi impliciti più significativi e pregnanti di quelli espliciti, possono favorire la comprensione oppure confondere, dare l’impressione di dire qualcosa senza in realtà dire nulla. Nella lingua inglese esiste un termine – ventilation (muovere l’aria) – che è usato in senso figurato per indicare, appunto, la possibilità di produrre parole senza in realtà comunicare alcunché. Ma le parole possono anche avere, in alcuni casi, un potere di incantesimo: usate con abilità danno vita a ciò che sarebbe stato inconcepibile prima che fossero pronunciate. In mano a persone esperte la parola è dunque un’arma potente, nel bene e nel male, e generalmente gli adulti sono in questo campo più esperti dei bambini, anche se i bambini non sono mai del tutto privi di risorse.
Nel rapporto con i figli, così come con chiunque altro, si comunica contemporaneamente su due diversi canali, quello verbale e quello non verbale: sono importanti non soltanto le parole, ma anche la mimica, i gesti, le posizioni che si assumono mentre si parla, il tono della voce, la velocità dell’eloquio, le ripetizioni, le pause, gli sguardi (vedi scheda 1). La comunicazione è un’attività ricca di sfumature, che vengono registrate quasi sempre dall’interlocutore, consciamente o inconsciamente; spesso ciò che si dice con il linguaggio non verbale corrisponde a quello che si dice con le parole, altre volte invece si danno – volutamente o involontariamente – messaggi differenti oppure confusi o addirittura in aperto contrasto l’uno con l’altro. Si dice una cosa, ma se ne fa intendere un’altra. Per esempio, si può dire a un bambino che siamo soddisfatti di lui, che gli vogliamo bene, ma con un tono freddo che esprime il contrario; oppure che non siamo d’accordo con lui con un tono che però gli fa capire che non lo disprezziamo per questo, ma che anzi lo rispettiamo e abbiamo fiducia in lui.
Scheda 1
Forme della comunicazione non verbale
- Sguardi, occhiate.
- Mimica (del volto).
- Pianto.
- Sospiri, lamenti, grida, fischi.
- Gesti (delle mani, delle braccia).
- Postura (posizione del corpo eretta, sdraiata, seduta, inclinata da un lato, portamento ecc.).
- Vicinanza/distanza (tra persone).
- Orientamento (faccia a faccia, l’uno di fianco all’altro, seduti ad angolo).
- Contatto fisico (carezze, abbracci, strette di mano, pacche sulle spalle ecc.).
- Tono della voce (rassicurante, minaccioso, irritato, ansioso, sussurrato, allegro ecc.).
- Movimenti del corpo (lenti, rapidi, scoordinati, assertivi, incerti, della testa, degli arti, delle spalle, del bacino ecc.).
- Pause (nel parlare), interruzioni.
- Abbigliamento, acconciature, accessori, tatuaggi, gioielli.
Ci si può anche rivolgere a una persona per farsi intendere da un’altra. Per esempio, si parla al bambino ma in realtà il messaggio è diretto a un altro familiare (marito, moglie, suocera ecc.): il bambino diventa veicolo di un messaggio delle cui conseguenze finisce per sentirsi responsabile. Analogamente, con forme sottili di istigazione e di suggerimenti, si possono far dire a un bambino determinate cose (offensive, spiacevoli, imbarazzanti ecc.) rimanendo nell’ombra e far cadere la responsabilità del messaggio sull’inconsapevole messaggero. Questi e altri inganni, che a volte gli adulti perpetrano nei confronti dei bambini senza averne una piena consapevolezza, non aiutano la comunicazione: anche se il bambino non comprende, puntualmente, in che modo viene strumentalizzato o raggirato, avverte però un disagio di fondo che lo porta a chiudersi, a diffidare, a sviluppare una forma di sfiducia nei confronti delle parole e, in alcuni casi estremi, anche un mutismo ostinato.
Nei dialoghi tra noi e i bambini c’è invece ampio spazio per l’umorismo, le battute di spirito, i giochi di parole, le finte aggressioni e per tutte quelle sfumature del linguaggio che man mano essi imparano a riconoscere e a valutare. Piccoli inganni a scopo di divertimento, di scherzo, in un clima di fiducia, non producono danni, anzi abituano a riconoscere i trabocchetti della comunicazione, rendono consapevoli, «esperti», capaci di difendersi e di contrattaccare. È bene che i bambini imparino, giocando con le parole e i loro significati, a riconoscere le incongruenze, a diffidare dei sofismi, a contrastare un imbroglio con una battuta, a capovolgere i termini del discorso smascherando una trappola.
La favola, il racconto, può esserci di grande aiuto per introdurre i bambini, in modo adatto alla loro mente, a tematiche importanti come i sentimenti, i valori, i tempi della vita, la violenza, l’imprevisto. Il racconto su temi che riguardano il loro mondo, i loro interrogativi, le tappe e i «compiti» della crescita, consente anche di ripercorrere esperienze vissute ma non bene assimilate, di sciogliere e curare, con l’aiuto della metafora, errori di interpretazione o piccoli traumi. Nei capitoli successivi il lettore troverà perciò alcuni racconti che «aiutano a crescere», a cui potrà ispirarsi per idearne altri su misura delle specifiche esigenze dei propri figli, alunni o nipoti. Il racconto dalla viva voce, è bene ricordarlo, ha anche il pregio di creare una vicinanza con il narratore: il bambino sente di valere il nostro tempo e la nostra presenza.
Le trappole della comunicazione
Riuscire ad avere una comunicazione coerente e onesta con i figli è importante se si vuole costruire un dialogo che duri nel tempo. Banalizzare spesso ciò che dicono, fraintendere il senso delle parole per non dover rispondere, interromperli continuamente, parlare in loro vece, ridicolizzarli, fingere di non sentire, negare con gli atteggiamenti ciò che si dice a parole sono modi di comportarsi che non aiutano la comunicazione e non favoriscono un rapporto basato sulla fiducia, così come non è d’aiuto la strategia, cui abbiamo accennato, di usare i bambini come ambasciatori di messaggi trasversali degli adulti. D’altro canto i bambini sono un po’ stregoni: anche se non sanno smontare le nostre costruzioni verbali sentono perfettamente quando la parola non è autentica.
Un primo passo per non restare bloccati in forme di comunicazione disfunzionali consiste nel saperle riconoscere.
Scheda 2
Comunicazioni disfunzionali
Comunicazione inibita. Si dice poco o nulla. Ci sono lunghi periodi di silenzio. I problemi non vengono né discussi né risolti, i segreti abbondano (sono troppi e anche su aspetti irrilevanti), il che indica atteggiamenti difensivi e mancanza di fiducia reciproca. Molti argomenti sono tabù e i bambini imparano ben presto a evitarli.
Eccesso di comunicazione. C’è molto rumore ma poco significato. I membri della famiglia si interrompono di frequente l’un l’altro. Non prestano ascolto o fanno lunghi discorsi di cui è ben difficile afferrare il significato, le intenzioni. C’è invadenza. Non si lascia spazio alla riflessione. Si sposta troppo spesso il piano della comunicazione. Si parla per sviare o per nascondere la mancanza di una reale comunicazione.
Comunicazione incongrua. Normalmente c’è congruenza tra ciò che si dice e come lo si dice, tra la comunicazione verbale e quella non verbale: una informazione «triste» viene accompagnata da mimiche e inflessioni della voce tristi. Tuttavia, se un messaggio triste si accompagna a un sorriso e un tono di voce indifferente, il significato della comunicazione è confuso. Questo tipo di incongruenza può essere – a seconda delle circostanze e del tema della conversazione – scherzoso, allusivo, intelligente; ma può anche nascere dalla volontà di negare i fatti (o i reali sentimenti o i meriti di qualcuno) comportandosi come se le cose stessero in tutt’altro modo. Se usata troppo di frequente con i bambini, la comunicazione incongrua provoca confusione, a volte demoralizzazione, altre volte mutismi «incomprensibili», in una parola, nevrosi.
Comunicazione dislocata. Pensieri e sentimenti sono espressi attraverso sintomi comportamentali e fisici (somatizzazione) piuttosto che con parole. Un bambino che ha paura di andare a scuola può avere mal di testa mattutini o attacchi di panico, invece di parlare apertamente delle sue paure. Se non si fa attenzione si può rispondere al mal di testa psicosomatico come se originasse da un disturbo fisico e non psicologico.
Comunicazione deviante. Questa e altre forme di comunicazione disfunzionale si basano sulla presenza di un «centralinista» attraverso cui vengono incanalate tutte le comunicazioni, una persona che funge d...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Dedica
- [1] - PARLARE, PERCHÉ, COME...
- [2] - LA VITA E LA NASCITA
- [3] - SESSUALITÀ E AMORE
- [4] - MATRIMONI E DIVORZI
- [5] - ADOZIONE
- [6] - DIVERSI DA NOI
- [7] - LA MALATTIA E L’HANDICAP
- [8] - DIRE LA MORTE
- [9] - RELIGIONE
- [10] - COSE CHE CONTANO
- [11] - VIOLENZA
- [12] - PROBLEMI DELLA SOCIETÀ
- NOTE