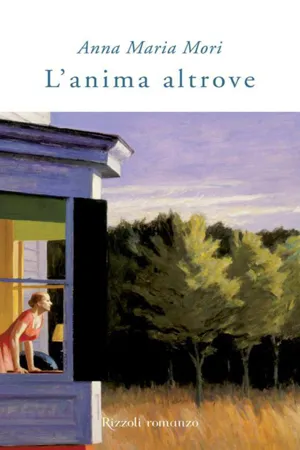![]() L’anima altrove
L’anima altrove![]()
Ai miei figli
Francesca e Michele
e ad Antonio, senza il quale…
![]()
Rewind
La vita può essere capita solo all’indietro,
Ma va vissuta in avanti.
SØREN KIERKEGAARD
2011.
Ci sono tende rosso scuro a schermare il sole di giugno che entra prepotentemente dalle finestre molto grandi. La dottoressa dà le spalle alle finestre e alle tende che colorano i suoi capelli biondi raccolti in un nodo, basso, sul collo, e regalano anche al suo viso e alle braccia un colorito roseo: tutto l’insieme dona una piccola ondata di calore incoraggiante. Davanti a lei, quasi a contrasto, la freddezza della sua scrivania, ordinatissima, senza un filo di polvere: un paio di libri, il blocchetto della carta intestata, non una fotografia, né un fiore che parli di lei e della sua vita privata.
La nuova paziente, appena entrata, ha visibilmente più o meno la sua età: sono due donne che una volta si sarebbero definite – senza offesa, signora… – “vecchie”, e oggi sono solo “adulte”, il che vuol dire, ieri come oggi, che tutte e due hanno più passato che futuro. Probabilmente è anche in nome di questo che, da subito, si crea una specie di alleanza, anche senza parole: la parola giusta forse sarebbe “compassione”. (Freud non sarebbe d’accordo, ma tant’è.)
Si osservano. La psicoanalista, in proposito, esercita un suo preciso diritto, e quindi guarda con sincerità, sicurezza, ma anche con il necessario distacco professionale la sua nuova paziente, indagando sul viso, sulle mani, sull’atteggiarsi del corpo. La paziente guarda fingendo di non guardare.
Insieme, senza dirselo, decidono che, sì, possono fidarsi l’una dell’altra.
«Mi chiamo Irene…»
«Lo so.»
«Come fa a saperlo?»
«Ho letto il suo nome sul registro delle prenotazioni delle visite.»
«Quali altre cose sa di me?», e nel tono c’è una fragile volontà di sfida, di provocazione.
«Assolutamente nessuna. Aspetto che sia lei a dirmi qualcosa in più.»
Una pausa. Un breve silenzio.
La psicoanalista: «Cominciamo con una domanda. Perché è venuta da me?».
«Perché… Perché è una vita che mi porto addosso un disagio che non so decifrare, un disagio che, invece di diminuire, con il passare degli anni sembra persino aumentare. Non vivo bene insieme a questo disagio. Ho deciso di affrontarlo. Insieme con lei, se lei mi accetta come paziente.»
«Com’è questo disagio, come si manifesta?»
«Non riesco a liberarmi da una specie di sindrome infantile del “no”, e quando mi sforzo di dire “sì”, senza esserne convinta, somatizzo, mi vengono delle emicranie feroci, nausee, vomito…»
«Mi spieghi meglio.»
«Come se fosse facile, magari riuscissi a spiegarlo. Sono qui perché lei mi aiuti a farlo. Da sola ci ho provato milioni di volte, ma non ci sono riuscita. Sono anche andata a farmi fare una endoscopia dello stomaco per capire se ci fosse qualcosa di brutto che mi induceva così frequentemente al vomito. Il medico, consegnandomi il referto, mi ha rassicurato: “Non c’è niente, tranquilla…”. “Dottore, ma io soffro di nausee continue, vomito…” Lui mi ha guardato sorridendo, e mi ha detto: “È il suo modo di esprimere un rifiuto per le cose che non le vanno bene. Cerchi di individuarle, le eviti, e vedrà che i suoi sintomi scompariranno. Se mai, quando sente che è più necessario, prenda qualche goccia di tranquillante: servirà a calmarla, perché lei è in un perenne stato di sovreccitazione”. Poi mi ha teso la mano e se n’è andato. Da allora il mio rovello è persino aumentato: cos’è che non mi va bene? Data la frequenza dei miei sintomi di rifiuto, sembra che non mi vada bene quasi niente… Fingo di appartenere, ma in realtà non appartengo mai fino in fondo… per esempio alla città dove vivo da più di quarant’anni: la guardo, è bellissima, ma la sento e mi sento estranea, qualche volta mi sta anche antipatica; non ho mai appartenuto del tutto ai lavori che ho fatto, non sono mai riuscita a dire il famoso “noi” che unisce le persone di uno stesso ufficio, di una stessa azienda; per un certo periodo mi sono occupata anche in maniera attiva di politica, ma quando mi hanno offerto l’iscrizione al partito e l’ingresso, con tutti gli onori, nel comitato centrale, sono scappata, ho rifiutato con una scusa qualunque; quando il “noi” diventa folla, assembramento, ho paura; non sono mai riuscita a partecipare a un corteo, a una manifestazione, neanche quando ne condividevo pienamente le ragioni. Quando mi capita di lavorare per un periodo più lungo del solito su un unico tema, un progetto preciso, dopo un po’ mi annoio, voglio cambiare, scappo anche da quello… Non riesco a mettere radici, e la sola idea di poterle mettere mi dà angoscia, mi provoca il rifiuto. È come se inconsciamente fossi tutta tesa a preservare da qualunque possibile contaminazione un qualcosa che però non so, non conosco. E mi viene anche il dubbio di aver vissuto tutta la mia vita senza viverla per davvero.»
«Continui…»
«Sto male con gli altri, e anche con me stessa… Ho sempre voglia di scappare, e se non riesco a scappare mi prende un’ansia che non riesco a controllare. Pensi, mi piacciono più gli alberghi delle case in cui ho abitato e abito, perché con gli alberghi non mi impegno in nessun modo, gli alberghi mi lasciano libera, le case mi imprigionano… Ecco, sono venuta da lei prima di tutto perché sto male, anche fisicamente, e poi perché penso che tutto questo non sia normale. Adesso che sono diventata quasi vecchia, sento che è arrivato, forse, chi sa, il momento di fare finalmente pace con me stessa. E magari anche con il mondo.
«Dottoressa, dov’è questo mio altrove che mi porta sempre fuori e lontano da tutto quello che via via sto vivendo?»
«È lei che deve trovarlo. Io posso solo cercare di aiutarla.»
«Si figuri se non ci ho provato… e dubito di riuscirci anche adesso, ma per me è importantissimo. Mi aiuti, non posso concludere la mia vita senza sapere, senza capire. Senza appartenere: ci sarà qualcosa cui appartengo, qualcosa cui non dire sempre solo di no!»
«Ci proviamo. Si metta comoda.»
«Dove?»
«Si sdrai là, su quel lettino dietro di lei, e si metta in modo da darmi le spalle.»
(Adesso Freud è più d’accordo: così va bene. Brave.)
«Fatto. Sono pronta.»
«Adesso io le dirò alcune parole, e lei dovrà dire liberamente, non si preoccupi di seguire un filo logico e razionale, tutto quello che queste parole evocano dentro di lei.
«La prima parola è: “casa”.»
Silenzio. La paziente è immobile sul lettino. Sembra che dorma, ma ha gli occhi aperti: fissa un punto del soffitto, ma in realtà guarda dentro di sé senza riuscire a vedere, in un buio che le sembra fittissimo. Tutto nero, nessun colore.
La dottoressa aspetta un po’, e poi ripete, calma, asettica: fine della compassione, inizio della professione.
«“Casa”… Cosa le fa venire in mente la parola “casa”?»
Altri minuti interminabili di silenzio, e poi dal lettino esce finalmente una voce. Ed è una voce diversa da quella con la quale la donna ha parlato fino a pochi minuti prima: una voce piccola, esile, quasi infantile.
«Vedo una bambina grassa, con un costumino da mare di cotone bianco fatto a mano, che cammina sola dentro un giardino di margherite più alte di lei. C’è un gran sole. Dev’essere estate. Poi qualcuno chiama, non so di chi sia la voce che chiama, e la bambina entra in una casa, ma non vedo niente e nessuno dentro quella casa, vedo solo uno scalino davanti a una porta, e dietro la porta un gran buio.»
«Continui… “Casa”…»
«Adesso ne vedo un’altra, di casa. La vedo meglio, più nitida dell’altra. È una grande villa rettangolare a due piani, e tutto intorno ha un giardino. Vedo alberi, fiori. Un grande noce a destra della facciata; la bambina grassa ci passa ore dentro, nascosta tra i suoi rami: una piccola baronessa rampante. Davanti all’ingresso c’è una specie di corte, con un tavolo di pietra sotto i rami di un fico: la bambina ci fa merenda con pane e lardo o pane e zucchero. Qualcuno prova e riprova a convincerla a fare merenda con pezzetti di pane inzuppati nel caffellatte, con l’orzo al posto del caffè, ma la bambina rifiuta: meglio pane e zucchero, con il pane che, tra i denti, resta duro da masticare, ed è molto più buono di quando diventa molliccio, viscido, inzuppato nel caffellatte…»
«Come si sente, lei, dentro quella casa, quel giardino?»
«Felice, mi sento felice… Sento molte voci accanto a me. Qualcuno canta…»
«E dov’è questa casa?»
«Lontano, lontano… Non c’è più.»
«Lei ha provato a cercarla?»
«No, l’ho perduta e non voglio più cercarla.»
«Perché?»
Una pausa, un piccolo sospiro: «Perché sì», e la voce si fa dura, testarda, quasi imperiosa.
«E quelle voci che sentiva accanto a sé?»
«Non ci sono più neanche quelle. Tutto finito, morti tutti. Morta anche la casa.»
«Le persone, sì, muoiono. Prima o poi moriamo tutti. Ma le case no, quelle non muoiono. Restano.»
«E invece no. La mia casa è morta, mortissima. Amen.»
La psicoanalista parla piano, quasi sottovoce: un lieve rumore di fondo, un sussurro che sembra venire dalle pareti stesse dello studio più che dalla sua bocca. La paziente invece adesso ha alzato la voce: suona forte, aggressiva.
Il sussurro, sottovoce: «Mi pare di capire che quella è la casa della sua infanzia: per crescere bene bisogna fare pace con la propria infanzia, tornarci dentro».
La voce forte, aggressiva: «Ma io non posso, non voglio».
La luce rosso-rosa dello studio si stende sopra il viso contratto della paziente sul lettino, senza ammorbidirlo. La donna resta immobile, le braccia e le mani rigide accostate ai fianchi. Tiene gli occhi chiusi. Tutto di lei, il viso e il corpo, sembra teso a difendere un “dentro” da intrusioni esterne: un “dentro” che non deve, non vuole uscire.
La psicoanalista muove solo, silenziosamente, la mano destra con la penna per segnare qualcosa su un blocco di carta bianca davanti a sé, sulla scrivania: traccia rapidamente un appunto, poche parole, che la paziente, in quanto sdraiata, non può vedere né leggere.
Rimangono tutte e due in silenzio, per qualche lunghissimo secondo. Poi la psicoanalista, senza cambiare tono, sempre con la stessa voce che sembra venire da lontano, asettica, priva di intonazioni, ricomincia con calma: «Riproviamo: se io dico “casa”, lei a cosa pensa? Cosa sente?».
E questa volta la paziente rimane in silenzio. Non ha più voglia di rispondere.
![]()
Parte prima
LONTANO DA QUANDO
Siamo stati tutti felici, nel posto da dove veniamo.
JOYCE CAROL OATES, La madre che mi manca
Un paese ci vuole… Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti…
CESARE PAVESE, La luna e i falò
![]()
Prologo
Singolare e plurale
C’è il tempo del presente e quello del passato. In mezzo, il tempo dei ricordi. E i ricordi, qualche volta, divorano il presente e il futuro: diventano il tempo unico, immobile, della nostalgia e molto spesso anche del rancore.
C’è il tempo del vivere, e il tempo del morire. Il tempo del nascere. Del diventare adolescenti, giovani, adulti. E poi vecchi: il tempo, oggi interminabile, della vecchiaia.
La giovinezza dovrebbe avere un tempo, ma le è stato tolto: è diventata un’entità astratta e quasi metafisica che si vorrebbe occupasse, almeno all’apparenza, l’intero arco della vita. È il tempo infinito del “sembrare giovani”.
C’è il tempo dell’innamoramento e quello dell’amore. Il tempo del volersi bene. E poi il tempo, i tempi del lungo disamore.
C’è il tempo della maternità che, da naturale e biologico come è sempre stato, è diventato politico, tecnologico, medico, psicopatologico. Il tempo del lavoro o della mancanza di sicurezza nel lavoro combatte una guerra silenziosa e dolorosa contro il tempo della maternità.
C’è il tempo del dormire, e quello dello stare svegli. Il tempo dell’insonnia, e il tempo del dormire troppo per rifiutarsi di vivere.
C’è il tempo della malattia. E quello della guarigione.
Il tempo del morire.
Ci sono i tempi esterni e quelli interni: non coincidono quasi mai.
C’è il tempo dell’essere e quello del mostrarsi. Oggi si esiste solo se e quando ci si mostra.
C’è il tempo del fare. Ci dovrebbe essere, e c’è sempre meno, il tempo del pensare, non foss’altro per cercare di dare un senso al fare.
C’è il tempo di investire sul futuro. Era anche un diritto, e come tale di tutti. Oggi riguarda (o si vorrebbe che riguardasse) solo le imprese e gli imprenditori: la gente comune non può, non deve investire sul proprio futuro, al massimo è invitata a credere, obbedire e combattere per il futuro delle imprese.
C’è il tempo dell’impegno e quello, malinconico, del disimpegno.
C’è il tempo dei filosofi e quello dei comuni mortali.
C’è il tempo infinito delle religioni che promettono l’immortalità o la resurrezione, e il tempo troppo breve della vita mortale.
C’è il tempo libero. Ma da che, e da chi?
C’è il tempo del lavoro (per chi ce l’ha), e il tempo della pensione («Oh, che bella la pensione, non vedo l’ora di andare in pensione!» e di lì a pochissimo si cade in depressione perché non si sa più cosa fare della propria vita). C’è il tempo dei progetti, e il tempo del “vuoto a perdere”.
C’è il tempo della guerra. E quello della pace: che non dovrebbe essere solo la pausa tra una guerra e l’altra.
C’è il tempo dell’esodo, ed è un lungo, terribile, momento che però, riguardando i corpi e i numeri degli esseri umani, si può documentare: clic, una foto, ecco i profughi. E poi, dopo l’esodo, c’è il tempo dell’esilio: più che i corpi, riguarda le anime, ed è perciò impossibile da fotografare. In quanto si tratta di un tempo più interno che esterno, può essere invisibile. Anche eterno.
È il tempo che si ferma.
C’è il tempo della rabbia, che una volta era creativa. Oggi c’è il tempo del rancore e della rassegnazione, e crea solo barriere impercettibili che dividono ogni essere umano da ogni altro essere umano.
C’era il tempo della forma e delle forme: si insegnava che “l’etichetta è una piccola etica”. In tempi di “invasioni barbariche”, si è deciso che era tutto tempo perso e improduttivo, e si è passati ai tempi più rapidi del comando senza diritto di replica, eventualmente seguito dall’insulto.
C’era un tempo in cui la buona educazione era una virtù riconosciuta da tutti. Siamo passati al tempo in cui la maleducazione è richiesta nei curricula per fare carriera, e in politica per vincere le elezioni.
C’era il tempo del «Buongiorno, come stai?», ed è arrivato il tempo del «Buongiorno, come sto?».
C’era un tempo in cui non era beneducato parlare di soldi. Siamo in un tempo in cui l’unico argomento unificante e assolutamente trasversale sono i soldi.
“Il tempo è danaro.” Capita sempre più spesso che non ci sia il tempo e neanche il danaro.
Ci sono i tempi delle sinfonie: Adagio con sentimento, Allegro ma non troppo, Andante… E i tempi della vita: Svelto, Sempre più svelto, Trotto, Corsa, Galoppo. Adesso si cerca di rendere più rapido anche l’ultimo tempo.
C’è il tempo del Sud: elogio della lentezza, del pensare magari senza fare, lunghi tempi destinati all’attesa e alla diffidenza. E il tempo del Nord, che troppo spesso è il tempo del fare senza pensare. Sarebbe bello trovare una via di mezzo tra l’uno e l’altro.
C’è il tempo dei giovani e quello dei vecchi. Per molti versi, adesso si assomigliano sempre di più.
C’è il tempo dei bambini e quello degli adulti. Non si fanno più bambini anche perché gli adulti non riescono ad adattarsi ai tempi dei bambini.
C’è il tempo delle donne e il tempo degli uomini: ed è il terreno su cui gli uomini e le donne verificano la punta massima delle loro diversità e dei loro conflitti.
C’è il tempo del malessere, del disagio, della sofferenza fisica e psicologica, e si coniuga quasi sempre con il tempo della solitudine.
C’è il tempo della comunicazione e della convivialità. E quasi sempre non coincide con il tempo della sincerità.
C’era un tempo in cui si scrivevano lettere e biglietti. Poi è arrivato il tempo del telefono. Oggi tutti e due sono stati sostituiti dalle e-mail e dai messaggini telefonici. Ed è scomparso il tempo della voce umana.
C’è il tempo della speranza. E coincide – dovrebbe coincidere – con il tempo intero della vita.
C’è il tempo del “come eravamo”, e il tempo del “come siamo”.
Il tempo è anche la moda e le mode del tempo. E magari riguardassero solo le maniere, più o meno innocue, del vestire: la moda e le mode segnano il tempo e i tempi nel modo di pensare, di comportarsi, di curare e di curarsi, di soffrire e di essere contenti, riguardano le idee e le pratiche correnti, le speranze individuali e collettive, le convinzioni.
La vita è il tempo della vita.
Noi siamo il tempo in cui siamo chiamati a vivere.
![]()
1
Natalia
C’è una storia nella vita di tutti gli uomini.
WILLIAM SHAKESPEARE, Enrico IV
Era il 1901. Inizio del cosiddetto “secolo breve”, un secolo che sarebbe stato terribile. Ma i tanti che nascevano in quegli anni non lo sapevano, neanche avrebbero potuto immaginarlo: chi nasce ha il diritto alla speranza e all’innocenza.
Oggi, del ventesimo secolo, le immagini collettive che ci vengono riproposte sono quasi esclusivamente quelle delle morti di massa della Prima e poi della Seconda guerra mondiale, i morti per niente dentro la morsa di neve e di ghiaccio della campagna di Russia, le violenze, la notte che impropriamente viene chiamata dei cristalli (e fa pensare ai lampadari di un ballo con il fruscio delle sete al suono di un valzer di Strauss laddove è stato l’inizio di una strage orrenda e inqualificabile), i lager nazisti, le camere a gas, il bombardamento di Dresda, Vichy, Salò, le Fosse Ardeatine, i campi di concentramento di Stalin e di Tito, le foibe, l’atomica su Hiroshima e Nagasaki…
È che purtroppo la morte è più fotogenica, più...