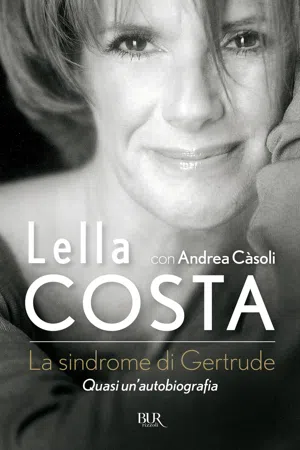Dice Andrea Càsoli che forse non è del tutto chiaro il titolo di questo libro. Per me invece è chiarissimo. Ovvio: la sindrome di Gertrude è quella che ha portato la Signora in questione, meglio nota come monaca di Monza, a rispondere di sì (ma l’arte sublime del Manzoni ha evitato perfino di esplicitarlo: «La sventurata rispose», appunto) a uno che invece avrebbe fatto meglio a ignorare. Per passione, per noia, per ribellione, per curiosità, per sfinimento (a volte capita che far accettare un “no” sia talmente faticoso che uno, anzi, più spesso una, ci rinuncia), perché sapeva resistere a tutto tranne che alle tentazioni.
Ecco, io più o meno funziono così: quando mi chiedono qualcosa, tendo a rispondere di sì. Intendiamoci, in genere son cose belle, o comunque non disdicevoli e men che meno criminose. Però non mi rendo conto, al momento, che magari non avrò proprio tutto il tempo, o la dedizione, o la pazienza, o magari la capacità di far fronte a quello che la richiesta comporta. La sindrome di Gertrude, appunto, m’inibisce l’uso corretto del ragionamento e così mi ritrovo ad accettare prima ancora di aver capito di che cosa si tratta.
Ora, vi starete chiedendo che razza di libro sia quello che avete tra le mani e che ho accettato di fare per via della sindrome di cui sopra: tutto torna, no?
L’idea che a qualcuno possa interessare un libro su di me, detto tra noi, continua un po’ a turbarmi. Però in fondo mi piace e anche tanto, e mi lusinga un po’, anzi parecchio. A patto, naturalmente, che sia chiaro in partenza ciò che questo libro non è e non vuole essere: niente agiografia, niente pettegolezzo, niente eccesso di autoreferenzialità.
Piuttosto il gusto di provare a raccontare quella sorta di molteplicità che ha finito per caratterizzare la mia vita. Perché, in fondo, io non sono un’attrice in senso tradizionale, e però recitare è proprio il mio mestiere; perché non sono né scrittrice né giornalista, ma ho un rapporto stretto con la scrittura, e non soltanto dei miei testi teatrali; perché di televisione sicuramente non vivo, ma altrettanto sicuramente alla televisione devo una notorietà diversa e più ampia di quella che mi dà il teatro; perché mi stanno a cuore temi e battaglie sociali e civili per i quali mi capita di spendermi, ma non vorrei mai farne un mestiere; perché cerco ostinatamente di non confondere memoria e desiderio, di conciliare leggerezza e impegno, magoni e miracoli.
E perché tutto questo accettare proposte sfide provocazioni mi ha portato a percorrere strade che mai avrei immaginato, a fare incursioni in territori apparentemente molto lontani dal mio, e a bearmi e nutrirmi di ogni tipo di diversità linguistica, culturale, artistica, umana.
Dunque, in sintesi (quella di Càsoli: io ne sono priva), in questo libro racconterò di carcere e cinema, scarpe e solidarietà, teatro e teiere, musica e memoria, doppiaggio e diritti civili; ma anche di musicisti, attrici, cantanti, scrittori, poetesse, stilisti (wow!), soubrette, registi, chirurghi, e soprattutto di quegli esseri di sovrumana generosità che vanno sotto l’etichetta riduttiva di «pubblico».
In questo libro ci siete anche voi, con me.
Parola di Gertrude.
Ritratto dell’attrice da giovane
Donne si diventa, ma attrici si nasce. E io, modestamente, la nacqui. A Milano. Col nome di Gabriella. Correva un anno imprecisato della seconda metà del secolo scorso, ma correva così veloce che non si è riusciti a capire quale fosse. E, dopo tutto, che importanza può avere un triviale dettaglio anagrafico, nell’immortale disegno del destino di un’Artista (maiuscolo e con l’apostrofo, trattandosi della sottoscritta)?
Poiché la folgorazione avvenne, e assai precocemente, sulla via della scuola materna, dove dopo alcuni ruoli da comprimaria in musical estivi esordii, a quattro anni e mezzo, come Maria nella tradizionale produzione natalizia: un successo straordinario, di pubblico e di critica. A otto anni fui ovviamente un’indimenticabile Giulietta, a undici un’intensissima Antigone, a tredici una dolente Desdemona, a quindici una sorprendente Medea (niente di meglio di qualche classico in fase prepuberale per assicurare un vitalizio a psicanalisti e cartomanti negli anni a venire). E poi, uno dietro l’altro, tutti i Molière e i Pirandello e i Goldoni, qualche Ibsen e qualche Strindberg negli inverni più freddi, il primo Cˇechov che non si scorda mai, perfino un Brecht o due negli anni della contestazione, spaziando da Euripide a Feydeau, e sempre tornando a Shakespeare, l’immenso. Una vita di/da/per/sul palcoscenico, sempre travolta dal Sacro Fuoco dell’Arte ma non per questo estranea al mondo reale, tanto da pormi quell’interrogativo che ancora oggi, al culmine della carriera, m’inquieta e mi tormenta: cosa significa essere attrice di teatro, oggi? Perché incaponirsi in questo mestiere fatto di fatica, di rinunce, di chilometri, di sudore, della polvere del palcoscenico (sostanzialmente un mestiere antigienico, insomma)? … E poi così ingrato e traditore, perché ti prende, ti prende e nulla ti dà in cambio. … Perché dunque mi ostino a farlo?
Ma perché è la mia vita, è così da sempre e così sarà per sempre…
Ecco, non è andata esattamente così.
Mi piacerebbe (forse), ma la realtà è un’altra. Per carità, qualcosa di vero c’è: luogo e data (ops) di nascita, nome, quelle cose lì. Anche le recite alla scuola materna.
Ma poi non c’è più stato, il teatro, nella mia vita, per tanti di quegli anni che adesso mi fa addirittura impressione ricordarlo.
C’è stata una normalissima vita di bambina e ragazzina e poi ragazza e giovane donna che andava bene a scuola senza impegnarsi particolarmente, e che sì, una passione ce l’aveva: leggere. Passione incontrata a quattro anni: la mia nonna materna aveva l’unica tipografia e l’unica cartolibreria di Costigliole d’Asti, dove io ho passato le estati più belle della mia infanzia, quelle magiche che non tornano più. Un giorno improvvisamente il giornalino – allora non si chiamavano fumetti – che avevo in mano (per la precisione, «Il Monello») smise di essere soltanto segni e figure e acquistò qualcosa di eccitante e meraviglioso: il suono, la parola. La prima storia che ho decifrato s’intitolava Piccola Eva occhio di lince, e mi ha cambiato la vita per sempre. Lo so che detto di una bambina di quattro anni fa ridere, ma una volta tanto è la vera verità.
Mia madre racconta ancora (ma per fortuna si limita alle riunioni di famiglia, giusto quelle cinquanta, sessanta persone) della volta che dovette lasciarci soli in casa, me e mio fratello, sei anni io tre lui, e quando tornò un paio d’ore più tardi trovò il tapino addormentato sul pavimento della cucina (molto Dickens), e la disgraziata ancora in bagno a leggere, immemore e rapita (molto Jo di Piccole donne).
Ho continuato a leggere per tutta la vita, anche se non sempre con tanta intensità. Credo che da questa passione sia nata la scelta del liceo classico, e poi di Lettere, alla Statale di Milano. Dove non mi sono laureata: ho dato tutti gli esami e anche alle scadenze giuste, ma la tesi non sono mai riuscita a finirla. Ho scoperto da poco che anche Claudio Bisio è nella stessa situazione, e ci siamo ripromessi di verificare se non si possa recuperare; ma mi conosco, non ci riuscirò, mi torna troppo in mente l’Ecclesiaste: «C’è un tempo per ogni cosa…».
Anche perché – finalmente! – avevo avuto la Chiamata, la Folgorazione, l’Illuminazione. Non sulla via di Damasco, ma su quella di Niguarda, popolare e popoloso quartiere milanese dove negli anni Settanta si cercava di dare vita a un Consultorio di Psicoterapia; e, a parte il fatto che i consultori evidentemente fan parte della mia vita, adesso magari vien facile fare dell’ironia, ma era davvero un gran bel progetto. In una gran bella città, anche. Ma non buttiamola sulla nostalgia. Frequentando quei corsi, interpretando donne schizofreniche durante il role playing, ho scoperto che recitare mi piaceva, e soprattutto che vedermi recitare piaceva agli altri. E che mica per niente, in diverse lingue, si usa lo stesso verbo per dire recitare e giocare. To play, jouer, spielen, appunto.
«Che tempo abbiamo avuto! Se solo aveste potuto vedere il tempo che c’era ai miei tempi» è il finale della mia Alice, sintesi di quegli anni formidabili e complicati, fatti di accademie e corsi di teatro, di lavori inventati. Vivevo già da sola, dovevo pur mantenermi e, se ci sono riuscita, lo devo, guarda caso, sostanzialmente ai libri. Nel senso che oltre a leggerli li ho venduti, prima per la Aid, un’agenzia che distribuiva riviste e libri stranieri in Italia, e poi per la Guaraldi, piccola e combattiva casa editrice fiorentina: forse c’è ancora qualcuno dei miei ex colleghi di allora che si ricorda di me, che non solo ero la più giovane e la meno preparata, ma ero anche l’unica femmina in quel mondo fatto di lunedì mattina al magazzino delle Messaggerie italiane, e poi di treni, appuntamenti con librai, giorni e a volte settimane fuori casa, solitudine. Quando, anni dopo, ho affrontato le mie prime, avventurose tournée, mi sono resa conto di essere in qualche modo già “preparata” a quel senso continuo di spaesamento, di sradicamento, di nostalgia, letteralmente: fa male, la vogli’e turnà. E ogni tanto ne traducevo anche, di libri, soprattutto dall’inglese (ma per l’Aid ho perfino tradotto gli inserti di «Maison & Jardin»: ah, quanto grès nel mio passato…). Ricordo ancora la paralizzante sensazione di inadeguatezza che ho provato la prima volta che, grazie ai buoni uffici di Delfina Vezzoli, allora editor, credo, di Bompiani, venni convocata alla presenza di Umberto Eco, il quale, a titolo di test attitudinale, mi assegnò la traduzione di un racconto in cui John Updike faceva il verso a Jack Kerouac: roba da mettere in difficoltà perfino Arbasino, che allora consideravo un mito e un mentore. Lo leggevo praticamente in clandestinità (negli anni della militanza dura e pura non era esattamente un autore contemplato), e mi ha salvato la vita: non solo grazie a lui ho scoperto T. S. Eliot, che da allora è il mio poeta preferito, ma, frustrata dal numero impressionante di autori ed eventi che lui citava come niente fosse e io ignoravo totalmente, mi sono messa a studiare. Invitata con garbo dalla Bompiani a “ripassare più avanti”, mi sono dedicata, grazie a un amico prezioso come Federico Golderer, a tradurre fantascienza e altre amenità (forse gira ancora qualche copia de Il signore della svastica di Norman Spinrad, o dell’Arte della corsa, demenziale quanto profetico manuale di jogging). Nel frattempo avevo avuto l’immensa fortuna di conoscere Silvana Mauri e Ottiero Ottieri e di essere invitata ai loro leggendari giovedì: non sono in grado di spiegare quanto questa amicizia abbia significato per me, e quanto mi manchino. Soprattutto Silvana, la donna più intelligente, generosa e spiritosa che abbia mai incontrato. A proposito di traduzioni: non ricordo esattamente quando, ma a un certo punto Ottiero, nella sua irresistibile vaghezza, aveva accettato di tradurre una serie di cosiddetti classici per ragazzi. Poi naturalmente si era distratto e lasciato incantare da mille altre sirene, e quando ormai mancava poco alla scadenza prevista per la consegna Silvana mi chiamò per chiedermi, col suo garbo indicibile, di salvarli dalla rovina morale e materiale traducendo al posto e a nome di Ottiero L’ultimo dei Mohicani. Ovviamente avrei ricevuto adeguato compenso, ma non credo sia stata la necessità (reale) di guadagnare qualche soldo a farmi dire di sì. ...