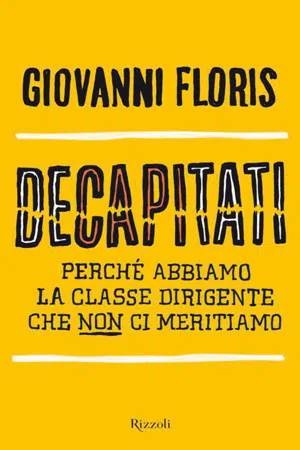Introduzione
La scelta che abbiamo davanti
«Seguimi.»
Un mio compagno di scuola è morto durante un conflitto a fuoco, e prima di morire ha ucciso un poliziotto. Il mio amico era un terrorista, aveva altri omicidi sulla coscienza. Si penserà che è una cosa piuttosto comune conoscere un ragazzo che ha sbagliato strada negli anni di piombo, ma non è così, perché io sono nato nel 1967 e quando gli hanno sparato gli anni di piombo erano passati da un pezzo. Erano passati persino gli anni della «Milano da bere», quelli in cui sedevamo nella stessa aula.
È morto nel 2003, quando il terrorismo non esisteva più. Esisteva però una banda isolata di criminali, che ha sparso sangue innocente ed è stata sgominata. Il mio compagno di scuola era stato invischiato in un incubo non suo, e aveva ucciso in nome di parole che nessuno pronunciava più, sulla scia di ideologie dimenticate da tutti. Era rimasto irretito in una nebbia di terrore che si era diradata da anni, vittima di racconti che avevamo sentito quando eravamo ragazzini. Nessuno di noi dava più credito a quelle storie, ma lui ne era stato arpionato e trascinato nel baratro di anni non nostri.
Per noi tutti c’è qualcuno che abbiamo perso, qualcuno che abbiamo sconfitto, qualcuno da cui siamo stati battuti. Per noi tutti c’è qualcuno che abbiamo seguito. Per il mio compagno, seguire quel qualcuno è stata l’ultima azione della sua vita e la più sbagliata. Non so, e non posso sapere, da cosa sia dipesa la decisione, da quale fascinazione sia scaturita o da quale mancanza, ma so che questo episodio è emblematico. Illustra una verità che nessuno di noi deve dimenticare. Scegliere chi seguire, come fa ogni giorno la maggior parte di noi, e indicare la strada da seguire, come fanno i pochi eletti a essere leader, non è un dettaglio trascurabile, non è una decisione da prendere alla leggera. È qualcosa che cambia la vita. Che può significare la salvezza o la disfatta.
Credo che oggi questa verità debba tenerla ben presente l’intero Paese. (Non per cercare di presentare le mie esperienze personali come fiaccole di verità per la nazione, ma un esempio è un esempio.) Perché il nostro è un Paese che, per dirla con gli psichiatri, tende alla rimozione, ma oggi non può più permettersela. Credo quindi che sia utile una riflessione su quelli che sono stati i nostri capi e i loro esempi, su chi abbiamo seguito e perché e in quali circostanze.
Dove ci ha portato la classe dirigente che attualmente ci comanda è sotto gli occhi di tutti, ma censurarne le (molte) assurdità non sarà il tema di questo libro. Noi guarderemo anche a quello che c’è stato prima, le nostre radici, e a quello che verrà dopo. Perché le nostre scelte determinano la nostra vita ed è arrivato finalmente il momento di fare quelle giuste.
Dobbiamo decidere cosa vogliamo da chi seguiremo in futuro. E pretenderlo. L’Italia non è fatta necessariamente di Fantozzi stesi a tappetino di fronte ai potenti. È fatta di gente sveglia e piena di buone idee.
Ho visto cose... che abbiamo visto tutti
Un taxista mi ha spiegato come far rigare dritto Cassano e Balotelli. L’autista che mi portava all’aeroporto aveva praticato il calcio a un buon livello, e diceva di capire i campioni irrequieti e sregolati, perché ricordava di essere stato come loro: «Quelli sono matti» mi spiegava. «A quelli serve un allenatore che si metta sul loro stesso piano. Il mister deve urlare, sgridarli, metterli sotto. Non deve spiegare come ci si comporta, perché quando si è stupidi come sono stato anch’io, un allenatore corretto che ti fa la lezioncina peggiora le cose. Più ti ricorda che ti stai rovinando più fai qualcosa per rovinarti, tanto per dargli torto.»
L’allenatore, quale che sia lo sport, è uno dei primi capi che un ragazzo incontra. Può trattarsi anche del maestro di musica, o del tutor di un centro estivo, o Akela nei boy scout: è la prima persona che (a parte i propri genitori, ovviamente, e a parte gli insegnanti, figure di cui parleremo dopo, e che sarebbe comunque sbagliato e riduttivo inserire nella categoria dei «capi») insegna una disciplina e che impone di rispettare delle regole, o un ruolo. La prima persona cui si è subordinati.
Quando giocavo a pallone ho imparato che la cosa più difficile non è conquistare il posto in squadra, è mantenerlo. In genere i mister non mi scoprivano subito, perché negli allenamenti non davo il massimo: funzionavo meglio in partita, quando sentivo la tensione dell’incontro (questo difetto l’ho mantenuto: nella diretta tv mi sento a mio agio, nel registrato accuso la finzione). Dopo qualche spezzone di partita mi conquistavo il posto, e in genere poi non lo perdevo: il fatto che il capo mi sottovalutasse mi dava la carica, mi faceva venir voglia di dimostrargli che sbagliava. E vedere il capo che ammette di aver sbagliato è sempre una bella soddisfazione! Poi, finita la sfida al mister, bisognava tenersi il posto conquistandoselo a suon di gol, e in realtà quello era l’impegno più duro, perché la motivazione bisognava trovarla dentro di sé.
Se fai sport, conoscendo il tuo preparatore cominci a conoscere i capi: c’è quello bravo, quello incompetente, quello che subisce la pressione della società, quello che subisce la pressione dei tifosi, quello che impazzisce per un giocatore e non ne vede un altro, quello che crede in te, quello che invece non scommetterebbe un euro sulla tua riuscita. Avendo a che fare con loro ho capito due cose. Una è che nessun mister può fare a meno di un giocatore forte. La seconda è che, magari non nel ruolo che pensavi, o non nei tempi che immaginavi, se giochi bene e se ti alleni seriamente un posto in squadra alla fine lo trovi sempre. E l’altra cosa che non puoi mai esplicitamente fare è mettere in discussione la leadership del mister. Non lo puoi fare davanti a tutti, o non lo puoi fare umiliandolo: se lo fai sei fuori, irrimediabilmente, e non giochi fino a che la società non fa fuori lui. Perché un capo su certe cose non può, anche volendo, passare sopra.
Come tutti noi, anche io ho conosciuto tanti capi. Come tutti, sono stato capo e sono stato sotto di un capo, a volte ho imposto le mie idee e altre volte non ci sono riuscito. E in quest’ultimo caso, a volte ho accettato la cosa, e altre mi sono ribellato. E di nuovo: in certi casi ho fatto bene a ribellarmi, perché avevo ragione io, e in altri ho fatto male, perché avevo torto.
Mi ricordo di una bidella a scuola che mi fulminò: contestavo una professoressa, avevo buone ragioni per farlo, perché si assentava, era disordinata e interrogava solo negli ultimi giorni prima dello scrutinio. Quando capii che la gente mi ascoltava e non mi prendeva per pazzo, quando realizzai insomma che rischiavo di avere ragione, cavalcai la mia battaglia in maniera talmente rumorosa che costrinsi gli altri professori a prendere le parti della collega. Rimasi isolato, e venni richiamato. La bidella che aveva seguito la cosa, seduta dietro alla sua scrivania in fondo al corridoio mi guardò e chiosò con un sarcasmo tutto romano: «Ahò! Sei riuscito a passà dalla parte del torto. E sei bravo...».
Facendo il militare di leva ho conosciuto il comando che non si discute, e ho capito come una regola che in guerra ti può salvare la vita, l’immediata obbedienza all’ordine del superiore, possa diventare vuota, inutile e irritante nel cortile di una caserma metropolitana.
Ho lavorato in un villaggio vacanze in cui il proprietario dell’hotel aveva un potere smisurato su tutto il personale. Altro che i soldati! Lui cacciava ad nutum chi non si piegava agli incredibili carichi di lavoro che imponeva: incuteva puro terrore al suo staff. Me ne andai in segno di protesta, ma solo più tardi capii che lo avevo potuto fare solo perché stavo lì per pagarmi la vacanza, e non per mantenere una famiglia.
Dopo la laurea ho collaborato con alcuni centri di ricerca: alcuni erano guidati da capi stressanti, maniaci della perfezione, convinti che l’istituto che guidavano (in genere pro tempore) fosse l’unico istituto del pianeta, e che al lavoro di ogni loro dipendente fossero legate le sorti della nazione. Altri avevano al timone persone che si rendevano conto della limitatezza del loro ruolo, consci che i loro subordinati avevano vite complesse, mille problemi cui pensare e che quindi non potevano sempre mettere il lavoro al centro della loro vita. I primi erano mal sopportati e facevano scappare molti dipendenti, ma gli istituti in genere funzionavano a meraviglia con chi resisteva. I secondi erano amati e creavano un buon clima, ma i risultati del loro lavoro spesso non erano brillanti.
Il capo, ovvero il direttore, cui devo di più è indubbiamente Paolo Ruffini: è lui che mi ha assunto al Giornale Radio, nominato corrispondente e assegnato Ballarò; ma pur non avendo una grande anzianità di servizio, tra la Rai e le mille testate cui ho collaborato di capi ne ho avuti tanti, e dai loro atteggiamenti ho cercato di imparare. Ho lavorato con direttori aperti e coraggiosi, che assegnavano i pezzi agli stagisti che stimavano, scavalcando le gerarchie interne delle redazioni; ho lavorato con direttori che non salutavano neanche i loro vice, e che pensavano solo a chi gli stava sopra; o con direttori che cercavano di andare d’accordo con tutti, spargendo nomine sui giornalisti come il parmigiano sui maccheroni. Ma soprattutto in Rai ho conosciuto dei veri maestri della gestione del personale. Abituati a non poter scegliere il proprio staff (come succede spesso nel pubblico), i migliori dirigenti di viale Mazzini sono avvezzi a tirare fuori il meglio da chiunque lavori con loro. Mi raccontò un collega di essersi lamentato col proprio direttore di un componente della sua redazione: era pigro, non lavorava, protestava continuamente. «Dobbiamo cacciarlo» disse al suo capo, e quello gli rispose: «No, lo devi far lavorare». Il confronto andò avanti per un po’, fino a che il mio amico sbottò: «Insomma, è impossibile far camminare chi non ha le gambe!». «Sì» rispose il dirigente, «farlo camminare è impossibile. Ma lo puoi far strisciare.» Esecrabile cinismo alla romana, certo, ma il concetto era chiaro, ed è un concetto positivo: in ognuno c’è un meglio che può essere tirato fuori, e un vero capo deve saperlo estrarre da chiunque.
Molto bene. Ora serve un vero capo che sappia tirar fuori il meglio dal Paese. C’è in vista un capo del genere? No. Serve che piova dal cielo? No. Il Paese ha le risorse per esprimerlo? Sì. Vedremo come si sono manifestate nel passato, dove cercarle e come riportarle in vita.
1
Capitani scoraggianti
Solo posti in piedi sul viale del tramonto
La premessa necessaria dell’analisi e del discorso che faremo è una premessa dolorosa: la nostra classe dirigente, nel suo complesso, non ci piace più. Ha mostrato tutti i suoi limiti, ha dato quello che poteva dare e ha avuto probabilmente in cambio molto più di quello che le spettasse.
Quando si sostituisce chi comanda bisogna però stare attenti. Innanzitutto perché c’è il pericolo di sottovalutarli: per quanto ci abbiano deluso, i leader di quello che ormai consideriamo il nostro passato, ma che in realtà è tuttora il nostro presente, sono abili, furbi, a volte intelligenti e in qualche caso preparati. Chi fa parte di una classe dirigente, anche se la società chiama il suo tempo, sa combattere per il proprio posto, sa rendersi indispensabile, e soprattutto sa riciclarsi.
Il secondo rischio è quello di sopravvalutare il nuovo che avanza, o che vorrebbe avanzare. I cambiamenti repentini e radicali portano sempre con sé una selezione approssimativa della nuova dirigenza: spesso nel ricambio emergono i capipopolo, oppure viene proiettato nella sala del comando chi è bravo a criticare il vecchio, ma non ha nessuna qualità nel costruire il nuovo. Quando Bettino Craxi, Giulio Andreotti, Arnaldo Forlani (ma anche Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante) lasciarono il campo emersero Silvio Berlusconi, Antonio Di Pietro, Gianfranco Fini e Umberto Bossi. I pr...