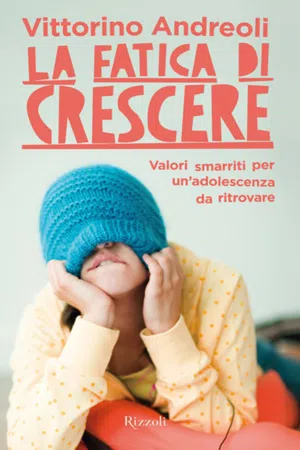LA CRESCITA
La crescita è il primo grande periodo in cui si articola l’arco dell’esistenza dell’uomo. Segue la fase della maturità e quella della senescenza.
La crescita propriamente detta ha inizio con la nascita e si conclude con la fine dell’adolescenza e comprende due periodi distinti: l’infanzia e l’adolescenza.
L’infanzia
Generalmente viene fatta iniziare con la nascita, ma oggi si ritiene più corretto pensare alla crescita già durante la gestazione, a partire cioè dal concepimento, vale a dire da quando il seme maschile si unisce all’ovulo femminile e comincia il grande movimento cellulare che, dopo nove mesi di gestazione, porterà alla nascita del bambino; neonato che noi consideriamo avere zero anni, anche se in realtà la crescita è partita nove mesi prima e quindi ha già accumulato una sua esperienza esistenziale.
Questa osservazione non è solo una semplice curiosità, in quanto i dati scientifici mostrano come quel periodo, definito «fetale», in cui il futuro bambino si trova ancora nel ventre materno, sia importante anche per le fasi successive, perché non è qualcosa di passivo, ma deve essere considerato come esperienza, un’esperienza che condizionerà quelle successive. E per convincersene basti pensare che è ormai assodato che a cinque mesi e mezzo è in grado di percepire i suoni acuti, e quindi di avvertire, anche se in modo particolare, il battito cardiaco della madre e persino la sua voce, e forse i rumori esterni. E questa percezione ha in qualche modo un proprio effetto sui movimenti del feto, già presenti in quel periodo, ma anche su altri tipi di espressione. Per esempio, oltre a muoversi può mettersi un dito in bocca, e quindi avere in qualche modo già un’esperienza particolare del proprio corpo.
Oggi gli studiosi rivolgono un’attenzione particolare alla crescita che, come abbiamo visto, viene fatta iniziare, anche se può sembrare un paradosso, prima della nascita.
L’infanzia termina con un «avvenimento» importante e biologicamente preciso: la pubertà.
La pubertà rappresenta un vero e proprio sconvolgimento: è una trasformazione che ha inizio nel corpo, un momento che si può facilmente riconoscere per le sue caratteristiche biologiche, visibili e determinabili anche attraverso esami di laboratorio (gli ormoni in particolare). La pubertà conclude la fase dell’infanzia e apre quella dell’adolescenza.
La pubertà generalmente comincia intorno agli undici/dodici anni e ormai da parecchio tempo possiamo rilevare come il suo inizio sia sempre più precoce (nel dopoguerra, infatti, si presentava «più tardi») e pertanto è logico affermare che ci debbano essere alcuni fattori esterni che in qualche modo la condizionano. È possibile riscontrare una qualche differenza tra femmine e maschi, in quanto nelle prime si manifesta con un leggero anticipo.
Dunque, l’adolescenza ha inizio con la pubertà ed è scandita, come abbiamo visto, da un fatto visibile. Ma quando finisce? Generalmente la si fa terminare con i diciannove/vent’anni; e per offrire un riferimento temporale si tende ad affermare che si conclude con il completamento del ciclo della scuola superiore. Però non termina con un fatto altrettanto preciso, più che altro finisce con una convenzione, quando il soggetto comincia a essere un giovane maturo, cioè una persona autonoma nella società e almeno in grado di provvedere alle esigenze primarie della vita.
È curioso, per esempio, che nel nostro Paese si stabilisca che a diciotto anni un giovane ha raggiunto la maturità, età richiesta per poter esercitare il diritto di voto alle elezioni e quindi per poter essere parte attiva del processo di democrazia della nazione (in altri Paesi, invece, questa età è anticipata). Allo stesso modo si pensa che a diciotto anni ci sia la maturità per guidare l’automobile, il che significa non tanto una capacità di tipo meccanico, quanto quella di cogliere il senso del rispetto delle regole del codice della strada, ma anche quello nei confronti degli altri, e da qui una maturità che contempli la possibilità di relazionarsi con loro e di rispettarne i diritti.
L’adolescenza dunque si conclude con una convenzione che dipende anche dai diversi tipi di società.
Non si può fare a meno di sottolineare questo aspetto, affermando per esempio che ci sono alcune società in cui il periodo dell’adolescenza è ridotto, quasi inesistente. In questi casi, con la pubertà l’adolescente viene subito posto in ruoli precisi all’interno della comunità e quindi assume una funzione sociale ben determinata. Fino a qualche anno fa presso alcune tribù africane il figliolo divenuto pubere veniva sottratto alla famiglia d’origine e portato a vivere in una comunità in cui era iniziato a pratiche e a comportamenti che servivano per difendere tutta la tribù, e quindi per imparare a esercitare una funzione che potremmo definire «da guerriero».
Ci sono invece società in cui il periodo dell’adolescenza è prolungato, e tra queste bisogna comprendere anche quella del tempo presente. I giovani adolescenti che continuano a studiare, che vanno all’università, è come se in qualche modo procrastinassero (consapevoli o meno) la fine dell’adolescenza perché si trovano per lo più in una condizione di dipendenza dalla famiglia, e quindi, in rapporto al concetto di autonomia che abbiamo sopra ricordato, è chiaro che il periodo dell’adolescenza è prolungato, mentre i giovani che invece cominciano a lavorare subito dopo la scuola superiore si trovano a essere più vicini al completamento dell’adolescenza, se misurata come autonomia anche economica.
Se applichiamo questo stesso parametro a individui che, pur in età anagrafica che li fa considerare «maturi», non hanno un lavoro e vivono ancora in famiglia, mantenuti dal padre o dalla madre o dalla pensione dei nonni, ecco che si cominciano a vedere adolescenze allungate e persino ritardate, che in certi casi potrebbero anche non portare mai alla fase successiva della maturità.
Quindi, come abbiamo visto, il periodo della crescita non è poi così preciso, né per l’inizio, che potrebbe comprendere la fase fetale, né per il termine, perché l’adolescenza finisce in àmbiti di tempo che sono molto diversi in rapporto a elementi che non sono solo biologici, e cioè precisamente determinati, ma che dipendono appunto dalle diverse società e dalle loro peculiari caratteristiche organizzative.
Se poi cerchiamo di analizzare un po’ più a fondo la fase della crescita, è chiaro che già all’interno del periodo dell’infanzia, che appunto facciamo finire con gli undici/dodici anni, ci sono ulteriori sottoperiodi, come quello che definiamo della prima infanzia, che è la fase in cui il bambino è completamente dipendente dalla madre, con la quale stabilisce addirittura una specie di simbiosi tanto da non sapere percepire la differenza fra il proprio corpo e il suo, perché non ha ancora sviluppato il processo dell’identificazione, cioè il processo di individuazione.
C’è poi la fase del linguaggio verbale che generalmente ha inizio tra l’anno e mezzo e i due anni, e non c’è dubbio che grazie a questo strumento di comunicazione il bambino comincia a svolgere una serie di funzioni che prima non erano evidenti.
Le distinzioni all’interno del periodo dell’infanzia sono cambiate moltissimo nel corso degli anni. Basti pensare che in un passato abbastanza recente ha dominato un modello, quello di Jean Piaget, che vedeva la crescita infantile come una sorta di linea retta su cui ogni tanto si inseriva una nuova funzione, come se con la maturazione cerebrale si presentassero nuove possibilità. E si parlava di una fase sensoriale data dalla capacità esclusiva di percepire gli stimoli esterni – tattile, dolorifico, visivo... – a cui si dava una risposta quasi meccanica: a ogni stimolo una risposta proporzionata. Si progrediva fino al raggiungimento del livello di «bambino astratto», quando cioè il bambino raggiungeva la capacità di astrazione, di cogliere i concetti e quindi di andare al di là dell’oggetto che colpisce i suoi sensi: in grado quindi di parlare del cavallo che colpisce direttamente i suoi sensi, ma anche della «cavallinità», per usare un termine introdotto da Platone. Il concetto è un qualcosa di astratto che trascende i singoli oggetti per arrivare all’idea che li comprende tutti. La capacità di astrazione si sarebbe raggiunta in un bambino proprio nella fase della pubertà, in genere, come abbiamo visto, intorno agli undici/dodici anni.
A questo modello lineare, ne fu contrapposto uno che potremmo definire elicoidale. Si pensò che il bambino sin dalla nascita sia una «persona» che abbia già tutte le esigenze umane, e quindi che non le acquisisca nel tempo, ma semplicemente le rinforzi, le ampli, e diventi una persona con capacità più ampie. Da qui il riferimento all’elica che a partire da un punto e girando su se stessa diventa sempre più grande.
Se poi guardiamo a quanto ha fatto la psicoanalisi, si scopre l’esistenza di una fase speciale (fase edipica) in cui il comportamento del bambino si caratterizza per il suo particolare attaccamento verso la madre, quasi una sorta di amore libidico, che gli farebbe considerare chiunque le si avvicini, padre compreso, come un nemico. Nell’Edipo re di Sofocle viene narrata la tragica vicenda di Edipo che uccide suo padre Laio, re di Tebe, senza sapere chi fosse e altrettanto inconsapevolmente sposa Giocasta, la regina, che era sua madre. E quando scopre questo suo insopportabile peccato, si acceca. Come si vede il mondo dell’infanzia è un mondo che ha animato la scienza caricandola di tragicità, in certi casi coinvolgendo anche la mitologia.
L’infanzia comunque ha una caratteristica essenziale: quella di fare riferimento alla famiglia. Il mondo del bambino è un mondo focalizzato sulle figure parentali, centrato nella casa e quindi in quello che è il suo nido, e quindi tutto ciò che il bambino fa è sempre riferito al gruppo familiare.
L’adolescenza
L’adolescenza è un periodo altrettanto lungo. Dura, con i limiti che abbiamo detto, sette/otto anni e generalmente viene distinta in due fasi: la prima e la seconda adolescenza.
La prima è caratterizzata da una sorta di lotta che l’adolescente conduce proprio contro la famiglia e in particolare contro quelle figure a cui era molto legato. Una lotta che lo porta a denigrare e a considerare negativamente tutto ciò che prima era positivo. Questo aspetto della contestazione che è quasi strutturale
– il che significa che ci sarebbe da preoccuparsi se non avvenisse – viene considerato come un atto necessario per potersi staccare dalla famiglia e aprirsi agli altri, legandosi a una dimensione più ampia, che è quella della società. Ciò che caratterizza in modo peculiare la prima adolescenza è proprio il passaggio dal gruppo familiare al legame con quello dei pari età.
In questa fase insomma emerge il rifiuto a stare con il padre e la madre, a stare in casa; rifiuto che, espresso in mille maniere e talora con molti eccessi, è invece la conseguenza di una sorta di attrazione verso altre persone, verso gli altri adolescenti. Il gruppo dei pari età diventa così il punto di riferimento, di ritrovo e possiamo dire anche «di sicurezza», in un periodo difficile perché l’adolescente sta vivendo una fase di metamorfosi: il suo corpo sta cambiando, muta anche il suo modo di pensare, quindi la sua personalità. Cambiano anche i riferimenti sociali, le amicizie, e di conseguenza ecco verificarsi il distacco dall’affetto del padre e della madre.
Questa metamorfosi – è bene sottolinearlo – è causa di insicurezza: si perde la propria identità, non si è più bambini, ma nello stesso tempo non si ha una dimensione precisa, nemmeno quella corporea, e tanto meno un ruolo sociale, e quindi è un periodo in cui l’adolescente si sente insicuro e avverte paura. E spesso non si piace proprio perché è qualche cosa in via di trasformazione.
E la sua metamorfosi riporta al racconto di Franz Kafka, La metamorfosi, in cui un mattino il signor Gregor Samsa si sveglia e si accorge di avere il corpo di un insetto, di uno scarafaggio per la precisione, e non sa più cosa fare. Non è più quello di prima, deve alzarsi perché è un commesso viaggiatore, deve prendere il treno. Lo chiamano: «Gregor, è tardi, alzati»; e lui, che si sente come impossibilitato a muoversi, risponde: «Sì, vengo», ma non si muove perché sta sperimentando una fase in cui in fondo non sa più chi sia, e prova persino ribrezzo nei confronti di se stesso.
Una metafora che si presta, sia pure in modo estremo, per interpretar...