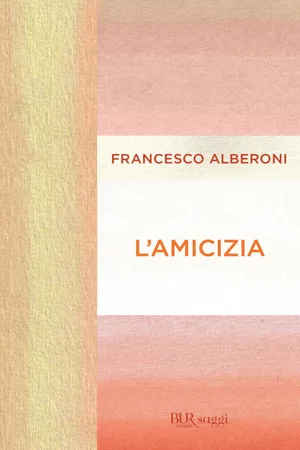Capitolo decimo
1. Perché con gli amici non ci si annoia? Perché la vera amicizia è sempre avventura, esplorazione dei misteri della vita, ricerca. È così che nasce l’amicizia nell’infanzia e nell’adolescenza. Due bambini diventano amici inventando nuovi giochi, liberando la fantasia, andando ad esplorare il grande e misterioso mondo che li circonda. I libri di Mark Twain: Le avventure di Tom Sawyer e Huckleberry Finn, ci mostrano questo aspetto vitale, creativo, avventuroso, dell’amicizia infantile. Il compagno di giochi, a questa età, non è il sonnolento amico delle serate oziose. È un essere proteso sul mondo, vibrante, capace di evocazione. Ciascuno ha bisogno dell’altro per dar corpo, per mettere in scena un mondo immaginario da cui esplorare, poi, il mondo reale. Non c’è nessuna conoscenza del mondo che non parta dalla fantasia. Nel momento in cui questa si spegne, in cui cessa la creazione dell’immaginario, scompare anche la curiosità, ed è finito il sapere. Questo è vero in ogni età della vita. È però nell’infanzia e nell’adolescenza che si vede più chiaramente all’opera questo meccanismo del conoscere.
Rispetto all’infanzia, nell’adolescenza diminuiscono le fantasie di avventure nel mondo, ma diventa più profondo l’interesse per la vita psichica, per il mondo sociale, per la storia. Tutti gli adolescenti devono scegliere, ormai, in una gamma più ristretta di possibilità, che rapporto stabilire con gli altri. Tutti sono, in qualche misura, degli psicologi che scandagliano la loro psiche e quella degli altri per comprenderne le leggi. In questa ricerca della propria identità e, quindi, delle differenze con gli altri, la persona più prossima, quella più studiata, è l’amico. Colui che è più vicino a te e che, quindi, puoi studiare come un te stesso visto dall’esterno. L’amico adolescenziale perciò non è l’identico, è il simile e, nello stesso tempo, il diverso, l’estremamente diverso. È chi ci apre una prospettiva differente sul mondo, chi ha visto ciò che noi non abbiamo visto, chi ha esplorato per noi, e continua ad esplorare per noi, regioni nuove dell’esperienza.
Tutti gli adolescenti sono, in qualche misura, anche dei filosofi, perché si pongono le domande cruciali: perché le cose sono in questo modo e non in un altro totalmente differente? Perché io sono qui e che cosa ci sono venuto a fare? Dove vado e dove devo andare? Sono le domande della coscienza che si risveglia, stupefatta di sé e del mondo, stupefatta e affascinata. Che sente una seduzione in ogni cosa che può diventare, e una perdita in tutto ciò a cui rinuncia. L’amicizia ha a che fare con queste domande. Il rapporto con l’amico indica le possibilità ed i limiti della persona. L’amicizia è identificazione e differenziazione. Nel libro Narciso e Boccadoro, Hermann Hesse ci presenta due amici totalmente dissimili. Narciso è uno scienziato e un asceta. Boccadoro è un artista sensuale. Ma non sa di esserlo, perché ha rimosso la sua infanzia e l’amore per sua madre. L’amico Narciso lo spinge a cercare dentro di sé, fino a trovare la sua vera natura. Quando l’ha scoperta, Boccadoro se ne va dal convento, lontano da Narciso, che pure ama, per scegliere il suo destino.
L’incontro fra gli amici è sempre scoperta della propria diversità, della propria unicità e, quindi, della propria solitudine, del proprio rischio individuale. Certo l’amicizia è anche rassicurante, perché l’amico sta con te. Insieme gli amici fanno le cose più pericolose. Le due ragazze che desiderano andare al ballo non hanno il coraggio di andare da sole. Unite si sentono più forti, più sicure, meno vulnerabili. Però, anche se vanno insieme, non è per stare insieme. A ballare saranno ciascuna per proprio conto, con un uomo diverso. Ciascuna farà un piccolo passo sulla strada della sua individuazione. In seguito si confideranno le cose d’amore, metteranno in comune le loro esperienze, fatte però con persone diverse, cercando le loro diverse strade di vita. L’amicizia rassicura e differenzia. Più due amici si incontrano e più sono costretti anche a camminare soli. Come due cacciatori o due guerrieri, che si aiutano l’un l’altro, ma devono poi battere piste diverse, affrontare nemici individuali.
Su questo punto la descrizione dell’amicizia che viene comunemente fatta è falsa. Gli stereotipi insistono sull’amicizia come protezione, come abitudine, come chiusura. Certo, questo può verificarsi. Anche nell’adolescenza il gruppo di amici, nato per esplorare il mondo e il suo mistero, talvolta si chiude su se stesso per difendersi dalle sfide del mondo. Ma, in questo caso, si può continuare a parlare di amicizia personale? La struttura reticolare dell’amicizia si è persa. Non ci sono più incontri. Il gruppo di «amiconi» è diventato una collettività compatta, che esercita un controllo totale sui suoi membri, come un villaggio, come una tribù. Esclude le esperienze che possono sedurre il singolo e cambiarlo. Esclude altre amicizie al di fuori della collettività. È un nucleo totalitario, geloso, punitivo. Questa collettività teme, soprattutto, la sfida di una nuova collettività nascente: ha paura dell’innamoramento che la incrinerebbe. Il gruppo di «amiconi», è, perciò, la negazione più totale dell’amicizia creativa. Esso cerca di prolungare la sua esistenza schiacciando gli individui che gli si ribellano. Alla fine si dissolve per il tradimento dei suoi membri. Ad uno ad uno costoro se ne vanno, di soppiatto. O perché si sposano, o perché trovano un lavoro, o perché cambiano città o, semplicemente, perché sentono il bisogno di riacquistare un po’ della loro individualità.
L’idea che l’amicizia sia una abitudine, che la sua essenza vada trovata nell’incontro al bar, al biliardo o al flipper, è molto diffusa. C’è anche gente che identifica l’amicizia con le riunioni mondane, o col ritrovarsi a chiacchierare dopo cena. Tutte cose che possono avere significati diversissimi. Quando però c’è noia, non c’è amicizia. Quando c’è ripetizione, monotonia, non c’è amicizia. Gli amici, l’abbiamo visto, non si annoiano. Se si annoiano, allora vuol dire che non sono amici, oppure che è intervenuto qualcun altro a disturbare il loro incontro. Molte riunioni mondane, al bar, nel salotto di una signora, o ad un Country Club, non hanno alcun diritto di essere chiamate riunioni di amici. Il party non è una riunione di amici. È una mescolanza di amici, conoscenti, persone occasionali. I suoi scopi sono molteplici: far passare il tempo, conoscere gente nuova, fare affari, mettersi in luce, cercare una avventura erotica, e mille altre cose. Gli amici, in queste riunioni, hanno poco da dirsi, perché sono separati, perché devono adeguarsi ai rituali sociali. Spontaneamente tenderebbero ad appartarsi, a chiacchierare fra di loro.
2. Abbiamo detto che la vera amicizia è avventura, esplorazione, ricerca, ed abbiamo portato ad esempio l’amicizia infantile ed adolescenziale. Ma non è un errore? L’amicizia infantile e quella adolescenziale non sono diverse, assolutamente diverse da quella adulta? Molti fatti deporrebbero a favore di questa tesi. Per esempio i compagni di giochi si incapricciano l’uno dell’altro rapidamente, vivono un interesse ossessivo che dura giorni o settimane e poi, improvvisamente, si dimenticano di tutto. I sentimenti adulti, sia di amore che di amicizia, sono incredibilmente più stabili. L’innamoramento adulto non ha nulla a che fare con le rapidissime e brucianti «cotte» infantili, infatuazioni passeggere che l’adulto sperimenta sul registro dell’erotismo, non dell’amore.
Per quanto riguarda l’amicizia, vediamo che i bambini bisticciano con i loro amici, tengono il broncio, sono gelosi, poi si riappacificano. Nulla di simile nell’amicizia adulta, che non ammette questo tipo di capricci. A volte gli adolescenti hanno, nei riguardi dei loro amici, atteggiamenti che noi consideriamo tipici degli innamorati: l’attaccamento esclusivo, la gelosia. Nell’adolescenza non c’è la netta distinzione fra innamoramento, affetto, amore fraterno e amore amicale che esiste nell’età adulta. A volte si trovano delle persone che prolungano, nella loro vita adulta, queste modalità infantili ed adolescenziali di rapporto con gli amici. Hanno infatuazioni passeggere, sopravvalutano la persona da poco conosciuta. Sono possessive nei riguardi degli amici, gelose della loro confidenza. Un sintomo inequivocabile di questa fissazione infantile ed adolescenziale è l’invadenza, la mancanza di rispetto, di discrezione.
È vero, perciò, che l’amicizia infantile e quella adolescenziale sono meno distinte da altre forme di affetto e di amore. Ciò non significa, però, che non si possa distinguere, già in queste età, ciò che è tipico dell’amicizia e che, già in questa età, non viene confuso con altre relazioni. Torniamo all’esempio di Narciso e Boccadoro. Il primo incontro dei due amici avrebbe potuto benissimo essere il preludio ad un innamoramento omosessuale. Che si tratti di amicizia lo si comprende però chiaramente quando Narciso dice all’amico: «Non è il nostro compito quello di avvicinarci... la nostra meta non è di trasformarci l’uno nell’altro, ma di conoscerci l’un l’altro e di imparare a vedere e a rispettare nell’altro ciò che egli è: il nostro opposto e il nostro complemento». Questo discorso è tipico dell’amicizia. A qualunque età venga fatto, a cinque anni o a cinquanta.
I caratteri essenziali dell’amicizia si possono identificare facilmente anche in opere tipiche per l’infanzia. Per esempio nel film di Spielberg: E.T. Questo film tratta dell’amicizia fra un bambino, Eliot, e un piccolo extraterrestre rimasto sulla terra. L’amicizia fra due esseri così diversi è già un segno tipico di questo sentimento. Il piccolo Eliot è incantato dall’amico extraterrestre che possiede poteri straordinari. Osserva Pier Aldo Rovatti: «Il bambino si identifica con E.T. per sfuggire al mondo degli adulti, per aprirsi una strada diversa che non sia già tutta segnata. Attraverso l’extraterrestre il bambino tenta, come ha fatto sempre, di deviare rispetto al paesaggio quotidiano della famiglia e della scuola». A questo punto, però, Rovatti curiosamente aggiunge: «Perciò la molla non è l’amicizia». Conclusione totalmente sbagliata, perché è proprio questa l’amicizia, proprio questo deviare rispetto al paesaggio quotidiano. Ricordiamo, in Le avventure di Tom Sawyer, la presentazione di Huckleberry Finn: «Quel giorno Tom si imbatté nel paria dei ragazzi del paese, Huckleberry Finn, il figlio dell’ubriacone. Huck era cordialmente detestato e temuto dalle mamme nella sua qualità di fannullone, ribelle a tutte le leggi divine ed umane, screanzato e cattivo; e per tali sue qualità ammirato da tutti i coetanei... Non ubbidiva a nessuno. Andava a pescare e a nuotare quando e dove e fino all’ora che voleva. Non c’era nessuno che gli proibisse di litigare con gli altri ragazzi o che, a una cert’ora, lo mandasse a dormire... Non era obbligato a lavarsi, a indossare roba pulita. Sapeva bestemmiare e dire parolacce in modo meraviglioso. Non gli mancava nulla, insomma, di tutto ciò che rende bella la vita. Così pareva, almeno a tutti i ragazzi sorvegliati, curati, scocciati dai loro genitori e congiunti. Huckleberry Finn era il ribelle interessante, la figura romantica».
Per il bambino, perciò, l’extraterrestre è il compagno fantastico con cui si ribella alla vita quotidiana ed esplora le frontiere del possibile. Ma che cosa è il bambino terrestre per E.T.? E.T. è solo, indifeso, ha paura. Ha perso i genitori e vuole ritrovarli. Vuole loro, vuole la sua casa. Sceglie come amico Eliot perché non si spaventa del suo aspetto. Non inorridisce, non lo rifiuta. Eliot vede subito che l’extraterrestre è, in realtà, un altro bambino come lui. Lo vede al di là delle apparenze mostruose; ne intuisce l’essenza e il bisogno. Anche questo è tipico dell’amicizia. Per E.T., allora, il bambino è un mezzo per trovare i suoi genitori e la sua casa. Eppure E.T. ama Eliot al punto che sceglie la morte per non fargli del male. La scena dell’ospedale ha tutta la violenza e la drammaticità delle grandi amicizie classiche in cui gli amici offrono di morire l’uno per l’altro, come Damone e Finzia, come Oreste e Pilade. Sarebbe però un grossolano errore confondere questi sentimenti con l’innamoramento. Gli innamorati vogliono stare insieme. E.T. è in esilio, vuole andarsene. Eliot è il compagno del suo viaggio di ritorno. Attraverso Eliot l’extraterrestre ritorna alla sua vera patria che non è la casa di Eliot, è il cielo.
Nel film il rapporto emotivo fra i due amici è intensissimo, straziante, per identificazione e per perdita. Eppure E.T. se ne va. Gli amici terrestri lo accompagnano all’astronave. L’amicizia consente di andarsene. Se fossero stati due innamorati E.T. sarebbe rimasto, o Eliot sarebbe andato con lui, o si sarebbero uccisi. L’innamorato deve restare con l’amato. Invece l’amicizia è servizio. Gli amici lo aiutano a partire, ad andare dove è la sua patria, a realizzare ciò che il suo amore chiede. Questo non è tipico dell’amicizia infantile o adolescenziale, è dell’amicizia tout court.
L’amico, perciò, è sempre un extraterrestre che ci consente di deviare dal percorso quotidiano, alla scoperta di un altrove altrimenti inaccessibile. L’amico è sempre colui che ci capisce, al di là delle apparenze, e ci rende giustizia. L’amico, infine, è sempre colui che ci aiuta ad andare, anche a costo di perderci, dove il nostro destino ci chiama.
3. C’è gente che si incontra, la sera, anno dopo anno, per fare quattro chiacchiere. Talvolta sono coetanei, compagni di scuola. Hanno ben poco da dirsi. Gli argomenti sono quasi sempre gli stessi. Ripetono le stesse battute, fanno le stesse osservazioni. Anche quando i partecipanti, presi singolarmente, sono intelligenti e vivaci, non appena entrano nella «compagnia» si appiattiscono completamente. La compagnia assorbe ogni interesse, banalizza ogni rapporto. Impone a tutti un minimo comun denominatore linguistico che impedisce di dire cose nuove. La conversazione, costruita su infinite ripetizioni, non può più uscire da se stessa. Non sono più possibili incontri. Non si possono più comunicare, e quindi provare, nuovi sentimenti. Non si possono più concepire nuove idee. Il reale coincide con l’esistente e questo con il ripetuto. La «compagnia» illustra, in modo emblematico, l’istupidimento e la degradazione dell’individuo ad opera del gruppo, quando il gruppo non ha un ideale, un fine, una ideologia, nulla. La compagnia amicale è un gruppo tradizionalista senza altro scopo che la propria sopravvivenza.
Spesso essa costituisce la rinascita del gruppo di amiconi dell’adolescenza. Avevamo visto che questo gruppo si rompe quando i singoli si innamorano, si sposano, se ne vanno. Coloro che vivono nelle grandi città non ricostruiscono più, in genere, formazioni sociali di questo tipo. La grande città è anonima. I vicini hanno pochi rapporti fra di loro. Gli amici abitano in luoghi diversi e, per incontrarsi, devono programmare l’incontro. Nei piccoli paesi o nelle piccole città, invece, dopo una fase di separazione e di individualizzazione, gli ex compagni di scuola si ritrovano. Nel gruppo entrano le mogli e i mariti, qualche altro familiare, i figli. Dopo un certo tempo la collettività si ristruttura come società chiusa.
Moltissima gente, quando pensa agli amici, ha in mente questo tipo di formazione sociale. Si comprende, perciò, perché consideri l’amicizia poco stimolante, e perché abbia spesso delle delusioni. In queste compagnie, infatti, finisce per esserci dentro un po’ di tutto. Vi sono alcune relazioni amicali vere, anche se avvilite e inibite dalla collettività. Vi sono poi molte relazioni amichevoli poco profonde o poco sincere, fondate più sull’abitudine che su veri interessi. Vi sono, infine, delle relazioni di pura convenienza o delle relazioni ostili mascherate di amichevolezza. La collettività stringe insieme tutti questi diversi rapporti ed impone ad essi un codice amicale comune, li rende artificiosamente uguali. In questo modo nasconde le indifferenze, le tensioni, le invidie, le ipocrisie, l’antagonismo. L’importante è che siano rispettate le regole di comportamento, i rituali, e questi impongono che tutti si considerino amici e si trattino come amici. La compagnia amicale assomiglia ad un club. Si potrebbe anche dire che la sua struttura è quella di un party, ma congelato, imbalsamato, diventato permanente. È in questo mondo di socievolezza che prosperano le forme di ipocrisia amicale. Abbracci, baci, ma anche false confidenze, invidia, malignità.
Perché si confondono queste cose con l’amicizia? Perché, quando si parla di amicizia, si evoca per prima cosa l’ottusa socievolezza del gruppo? Perché viene in mente la compagnia, gli amiconi, il club, la noia? Perché non viene in mente la ricerca, l’avventura, come nell’infanzia, come nell’adolescenza? Siamo ancora una volta di fronte al processo di rimo...