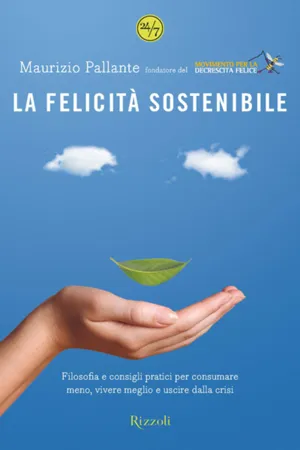Merci e beni
Poiché da alcune generazioni siamo abituati a comprare tutto ciò di cui abbiamo bisogno, o di cui siamo stati convinti di aver bisogno, noi abitanti dei Paesi occidentali tendiamo a considerare le parole beni e merci come sinonimi. In realtà le due parole esprimono due concetti diversi: i beni sono oggetti o servizi che soddisfano un bisogno o un desiderio, mentre le merci sono oggetti o servizi che si comprano, che si ottengono in cambio di denaro. Ma non tutti i beni devono essere comprati, né tutte le merci soddisfano un bisogno. In altre parole, ci sono beni che non sono merci e merci che non sono beni. Ma ci sono anche beni che si possono ottenere solo sotto forma di merci, che si possono solo comprare, e beni che invece non si possono ottenere sotto forma di merci, che non si possono comprare.
Per il riscaldamento degli ambienti in Italia si consumano mediamente 200 chilowattora (circa 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano) per metro quadrato all’anno. In Germania, in Alto Adige e, da qualche anno, anche in alcuni comuni italiani, non è consentito costruire nuovi edifici, o ristrutturare edifici esistenti se il loro consumo energetico per il riscaldamento supera i 70 chilowattora (7 litri/metri cubi). Analoghe normative sono in vigore in altri Paesi europei. Dove è stato imposto questo limite gli edifici sono stati suddivisi in classi di efficienza energetica, utilizzando la stessa metodologia diventata di uso comune per gli elettrodomestici. Gli edifici che consumano 70 chilowattora al metro quadrato all’anno sono inseriti nella classe C, quelli che ne consumano 50 nella classe B e quelli che ne consumano 30 nella classe A. La massima efficienza energetica viene raggiunta da edifici con un consumo equivalente a 15 chilowattora, che inoltre non devono avere un impianto di riscaldamento e, ciò nonostante, sono in grado di mantenere una temperatura interna di 20 gradi anche con temperature esterne di – 20 gradi. In Germania li definiscono case passive, in Alto Adige case di classe oro.
Se si può stabilire per legge che il riscaldamento di un edificio non può assorbire più di 70 chilowattora per metro quadrato all’anno, significa che gli edifici che consumano 200 ne disperdono in atmosfera i due terzi a causa della cattiva coibentazione. Almeno 13 litri di gasolio o metri cubi di gas per metro quadrato all’anno su 20 sono una merce, che si paga sempre più cara, ma non un bene perché non servono a riscaldare l’edificio. In relazione agli edifici più efficienti, le dispersioni salgono da 13 a 18,5 litri/metri cubi su 20. Quasi i nove decimi. Ma gli edifici mal costruiti, che hanno bisogno di più gasolio o più gas per essere riscaldati, fanno crescere il PIL più degli edifici ben costruiti. Se venissero ristrutturati in modo da ridurre le dispersioni, diminuirebbe il consumo di una merce che non è un bene e, al termine degli anni necessari ad ammortizzare i costi d’investimento con i risparmi sui costi di gestione, si avrebbe una riduzione del PIL, senza rinunce e senza diminuzione del benessere. (Anzi, la riduzione delle dispersioni migliora il comfort termico per ragioni che verranno spiegate nel paragrafo seguente.) Un miglioramento che non si avrebbe senza la riduzione dei consumi derivante dalla diminuzione degli sprechi. Senza una decrescita del PIL. La decrescita del PIL che si ottiene riducendo la produzione e il consumo di merci che non sono beni non richiede rinunce e migliora la qualità della vita. Offre un benessere non altrimenti ottenibile.
Come esistono merci che non sono beni, esistono beni che non sono merci: gli oggetti autoprodotti per autoconsumo e i servizi alla persona prestati per amore. Una famiglia che coltiva un piccolo orto per sé non compra la frutta e la verdura. Quindi fa decrescere il PIL facendo calare la domanda di quelle merci. In relazione ai canoni economici vigenti la sua attività è asociale. Ma non rinuncia a nulla. Anzi, si nutre in maniera più sana e mangia prodotti più buoni. Anche questo miglioramento della qualità della vita non si può avere senza la decrescita del PIL indotta da un incremento della produzione e dell’uso di beni che non sono merci. Ancora maggiori sono i benefici che si ottengono dai servizi alla persona prestati per amore invece di essere affidati a pagamento allo Stato sociale o a privati. Può star bene un neonato allontanato a tre mesi dall’affetto esclusivo dei genitori o dei nonni, privato del calore e dell’odore del corpo della mamma, portato in un ambiente che non è suo, e affidato dal mattino alla sera a estranei in condivisione con altri bambini allontanati dall’affetto esclusivo della loro famiglia nella loro casa? Però affidare la sua cura a una struttura pubblica, o a una baby sitter, fa crescere il PIL e consente a entrambi i genitori di contribuire a farlo crescere andando a produrre merci in cambio del denaro con cui potranno pagare chi si occupa di lui in loro vece. Può essere felice una persona anziana allontanata dalla casa dove ha sempre vissuto e portata in un ospizio, affinché i suoi figli possano essere liberi di andare a produrre merci dalla cui tassazione lo Stato ricaverà il denaro necessario a pagare gli estranei che l’assisteranno al loro posto? Il miglioramento della qualità della vita consentito da un aumento del tempo dedicato all’amore per i propri cari implica una riduzione del tempo dedicato alla produzione di merci. Non si può ottenere senza una decrescita del PIL.
Tuttavia, non tutto ciò di cui si ha bisogno può essere autoprodotto. Oggetti e servizi che richiedono tecnologie complesse e competenze specialistiche si possono solo comprare. Un computer è un bene e una tac è un servizio che si possono ottenere soltanto sotto forma di merce. Ma ci sono anche beni che non si possono ottenere sotto forma di merci. Il rispetto e la fiducia degli altri, l’amicizia e la solidarietà non si possono avere in cambio di denaro. Il divertimento si può comprare, ma non la gioia. Il sesso si può comprare, l’amore no. È un caso che in un sistema economico fondato sulla crescita del PIL la gioia si sia confusa con il divertimento e si parli di «amore mercenario» per indicare la prostituzione?
Fatte queste precisazioni, si può dare una definizione della decrescita come riduzione della produzione e del consumo di merci che non sono beni e come aumento della produzione e dell’uso di beni che non sono merci. Riducendo la produzione e il consumo di una merce che non è un bene non ci si priva di nulla, non si fa nessuna rinuncia. Aumentando la produzione e l’uso di un bene che non è una merce non si fa nessun sacrificio. Non è necessario far scendere in campo l’austerità, la sobrietà, la temperanza, la moderazione, che per altro sono virtù inestimabili, valori trasformati in vizi dalla necessità di indurre ad acquistare compulsivamente le quantità crescenti di merci immesse sul mercato dalla crescita del PIL. L’attore protagonista nello scenario della decrescita è l’intelligenza. Perché devo comprare qualcosa che non mi serve? Perché devo preferire una merce invece di un bene qualitativamente migliore che posso autoprodurre spendendo di meno? Certo l’intelligenza deve essere nutrita dall’etica. Ma le motivazioni etiche da sole possono essere addirittura il segno di una inconscia subordinazione culturale all’ideologia della crescita. La rinuncia a qualcosa per nobili motivi implica una valutazione positiva di ciò di cui si decide di fare a meno. Si rinuncia a qualcosa che si ritiene utile, o quanto meno piacevole. Ma se si decide di fare a meno di qualcosa che si valuta negativamente si fa una scelta razionale. È una cosa inutile. Non serve a niente (è una merce, ma non un bene). Oppure: posso autoprodurre qualcosa di meglio che costa meno (un bene che non è una merce). Allora sarei poco intelligente se la comprassi.
Decrescita e felicità
Quando, qualche anno fa, chiesi a una commessa di una libreria megastore il libro La decrescita felice, la mia interlocutrice sgranò gli occhi e, invece di rispondermi, mi domandò a sua volta: «Ma la decrescita può essere felice?». Aggiungere l’aggettivo felice al sostantivo decrescita le sembrava un ossimoro. A persone più smaliziate questo accostamento sembra una furbizia per esorcizzare con una connotazione positiva il contenuto negativo espresso dal sostantivo. I sostenitori della decrescita per ragioni etiche ritengono che questa scelta apporti felicità perché è giusta nei confronti dei poveri, del mondo e di sé. Perché chi la fa contribuisce a ridurre la sofferenza di chi non ha quanto è necessario per vivere, la crisi ecologica, le tensioni internazionali per il controllo delle materie prime e lo stress di vite bruciate dall’affanno di avere sempre di più. Di conseguenza la decrescita è fattore di serenità, pace, convivialità.
Se, invece, la decrescita si realizza come diminuzione della produzione e del consumo di merci che non sono beni e come incremento della produzione e dell’uso di beni che non sono merci, la felicità è una sua caratteristica intrinseca. Non la conseguenza sullo stato d’animo di chi la pratica o sulle condizioni sociali che contribuisce a determinare. La decrescita così intesa è apportatrice di un maggiore benessere. Diventa un indicatore di benessere.
Torniamo agli esempi della casa ben coibentata, che riduce il consumo di una merce che non è un bene, e dell’orto familiare che aumenta la disponibilità di un bene che non è una merce. È convinzione diffusa che il comfort termico in un ambiente chiuso dipenda principalmente dalla temperatura dell’aria, che non deve essere inferiore ai 18 e superiore ai 22 gradi. In realtà il calore prodotto dal metabolismo del corpo umano si scambia al 70 per cento per irraggiamento con le pareti e solo al 30 per cento con l’aria della stanza. Per cui in un ambiente con le pareti fredde, anche se la temperatura dell’aria è calda, si ha una sensazione di benessere termico inferiore a quello che si prova in un ambiente con la temperatura dell’aria più bassa e le pareti calde. In una stanza che ha bisogno di 200 chilowattora al metro quadrato all’anno perché ne disperde 130, le pareti e le superfici vetrate sono più fredde che in una stanza a cui ne bastano 70 perché trattiene molto meglio il calore e ne disperde di meno. Meno energia si disperde, meno se ne consuma, più le pareti sono calde e meglio si sta. Il benessere termico è inversamente proporzionale alla crescita del PIL. La decrescita, se si realizza come diminuzione del consumo di una merce che non è un bene, è fattore di felicità. Non solo per chi ne usufruisce direttamente ma un po’ di quel maggior benessere si riverbera su tutta l’umanità, perché un edificio che consuma 70 chilowattora al metro quadrato all’anno manda nell’atmosfera un terzo dell’anidride carbonica emessa da un edificio che ne consuma 200. Contribuisce a ridurre l’effetto serra. Contribuisce a migliorare, per poco che sia, le condizioni di vita di tutti.
Risultati analoghi si hanno anche ogni qual volta la decrescita si realizza aumentando la produzione di beni che non sono merci. Per riprendere l’esempio degli orti familiari coltivati per autoconsumo, si può presumere che in essi non si utilizzino veleni chimici ma si adottino i metodi dell’agricoltura organica. Quindi la frutta e la verdura prodotte in quegli orti sono più sane e buone di quelle comprate. La qualità della vita migliora. Anche in questo caso la decrescita è intrinsecamente fattore di felicità. Non solo per chi la pratica, ma per tutta l’umanità, perché la coltivazione biologica di un appezzamento di terra, per quanto piccolo possa essere, riduce, per poco che sia, la quantità complessiva di veleni e concimi di sintesi immessi nei terreni agricoli e nel ciclo dell’acqua.
Implicazioni più profonde, anche se più difficilmente dimostrabili, possono derivare da un quanto mai auspicabile ritorno alla cura per amore dei bambini nei primi anni di vita e degli anziani negli ultimi. La maggiore felicità che ne ricaverebbe chi avesse la fortuna di riceverla è una conseguenza così evidente da non richiedere parole, mentre invece sarebbe utile capire quanto incida la sofferenza derivante dalla privazione di un rapporto d’amore esclusivo nei primi tre anni di vita nella diffusione di comportamenti violenti, di una violenza agghiacciante per futili motivi, tra le giovani generazioni che vivono nelle aree urbane.