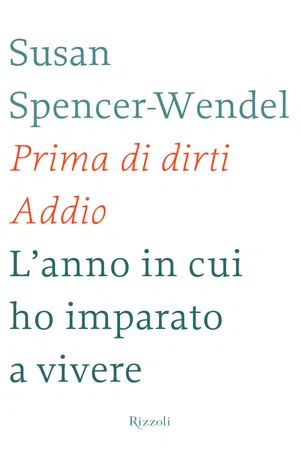![]()
Il decollo
Luglio-Settembre
![]()
1
Ancora fortunata
È strano pensare alla mia vita di prima, quella vissuta con il pilota automatico.
Oltre quaranta ore alla settimana dedicate a un lavoro che amavo: seguire la cronaca giudiziaria presso il tribunale locale per il «Palm Beach Post». Altre quaranta a dirigere il balletto quotidiano delle guerre tra fratelli, dei compiti a casa e degli appuntamenti dal pediatra, dal dentista, dall’ortodonzista, dallo psichiatra (non c’è da stupirsi, eh?).
Ore trascorse alle lezioni di musica dei miei figli o a scarrozzarli tra una e l’altra.
Serate passate a piegare la biancheria sul tavolo della sala da pranzo.
Ogni tanto una cena con gli amici o con mia sorella Stephanie, che vive in fondo alla strada.
Un bagno tranquillo con mio marito nella piscina sul retro di casa, pochi minuti alla fine della giornata, interrotto da una discussione tra i bambini per una divergenza sui canali televisivi o dalla richiesta venuta da chissà dove di Wesley, sei anni, di disegnare sui cucchiai.
«Va bene. Su quelli bianchi di plastica però, non su quelli d’argento.»
Mi sentivo fortunata.
Mi sentivo felice.
E, come chiunque, mi aspettavo che quella felicità sarebbe durata per sempre, passando indenne attraverso balli di fine anno e lauree, matrimoni e nipoti, fino alla pensione e qualche decennio di lento declino.
Poi, una sera dell’estate del 2009, mentre mi stavo spogliando per andare a letto, mi cadde lo sguardo sulla mia mano sinistra.
«Oh, merda» urlai.
Mi voltai verso mio marito John. «Guarda!»
Sollevai la mano. Era scarna e pallida. Nel palmo erano visibili le linee dei tendini e le protuberanze delle ossa.
Sollevai la destra. Era normale.
«Devi andare dal dottore» disse John.
«Okay.»
Ero troppo sbalordita per aggiungere altro. Sembrava che la mia mano sinistra stesse morendo. Ma non ero preoccupata. Il mio unico pensiero fu: come faccio a trovare un buco per il dottore nella mia agenda fitta di impegni?
Andai dal mio medico di famiglia, una donna gentile che mi chiese in cinque modi diversi se sentivo dolore alla mano o al braccio.
«No» risposi.
«Bene, allora probabilmente non è tunnel carpale. Voglio che veda un neurologo.»
Così ebbe inizio un’odissea lunga un anno. Un’odissea fatta di visite mediche. Di tentativi di spiegare il mio arto avvizzito. Di trovare una risposta diversa da quella che John, facendo ricerche per conto suo, aveva individuato dopo il mio primo appuntamento con un neurologo: Sla.
«Che cos’è?» avevo chiesto io.
La Sla, sclerosi laterale amiotrofica, più comunemente conosciuta come morbo di Lou Gehrig, è una malattia del sistema nervoso che comporta la morte dei nervi che servono i muscoli, causando la morte dei muscoli stessi. È una malattia degenerativa e progressiva, cioè continua ad avanzare, passando da un muscolo all’altro. Non se ne conosce la causa. Non esiste trattamento farmacologico. Né una cura definitiva.
Ciò significava che la morte nella mia mano sinistra si sarebbe propagata al braccio. Poi al resto del mio corpo, che si sarebbe indebolito un muscolo dopo l’altro finché sarei rimasta paralizzata.
E infine, entro tre o cinque anni dai primi sintomi, sarei morta.
No. Una cosa simile non sarebbe potuta accadere. No. Doveva esserci un’altra spiegazione.
Una lesione, forse? Pochi mesi prima mentre andavo da mia madre sui Rollerblade ero caduta così malamente che l’impronta del cemento era rimasta sulla mano sinistra per un’ora.
Certo, avevo una protrusione discale… ma non c’entrava nulla con la mano.
Il dottor Jose Zuniga, il mio primo neurologo, suggerì che potesse trattarsi della malattia di Hirayama, un disturbo che implica una misteriosa perdita della funzione muscolare. La descrizione si adattava ai miei sintomi, con una eccezione però: la maggior parte delle persone affette era giapponese.
«Lei non è giapponese» osservò il dottor Zuniga.
Mi adatterò, pensai. E andai di corsa a comprare del sushi. Ignorai i California Roll, che sono per pappemolli, e scelsi un rotolo con l’anguilla.
Ma non si trattava della malattia di Hirayama.
Uno specialista della Sla, il dottor Ram Ayyar, suggerì un’altra patologia: la neuropatia motoria multifocale, un disturbo muscolare progressivo che spesso inizia dalle mani. A differenza della Sla, per la Nmm esisteva un esame. Del costo di tremila dollari. Scandalizzata, scoprii che la mia assicurazione non avrebbe coperto le spese. Fui più sconvolta e frustrata da questa notizia che dal risultato dell’esame: negativo. Non era nemmeno neuropatia multifocale.
Consultai quattro specialisti in sei mesi. Feci un viaggio a Cipro alla ricerca di una causa ereditaria.
Dal momento che non saltò fuori niente smisi di fare esami. Per un anno negai a me stessa di essere ammalata. Un rifiuto di accettare la realtà di quelli che ti fanno dire che il cielo è verde, intendo. Talmente ottuso e miope che ora l’ammetto con imbarazzo.
Nella primavera del 2010, quando iniziai a far fatica a praticare yoga, un mio amico mi fotografò in tutte le 26 posizioni dello yoga Bikram, nella remota eventualità che non fossi stata più in grado di continuare.
In novembre, al cinquantesimo anniversario di matrimonio dei miei genitori, John dovette tagliarmi la bistecca. Riuscivo ancora a mangiare da sola ma non ad adoperare bene forchetta e coltello.
Troppo debole per andare al lavoro con la ventiquattrore, passai a un trolley. «Suppongo che tu lo faccia perché vuoi assomigliare agli avvocati» fu il commento di un mio collega.
Non dissi una parola.
A gennaio 2011, mentre mi lavavo i denti, notai che la lingua si contraeva, indipendente dalla mia volontà. Per quanto provassi, non riuscivo a fermarla.
Poche settimane dopo, mentre ero a cena a casa di mia sorella Stephanie, la vidi strabuzzare incredula gli occhi. John teneva la forchetta in mano e aspettava di imboccarmi. Un momento, quando era diventata una routine?
«Fermati, John» gli dissi bruscamente. «Posso arrangiarmi da sola.»
Come dolce Stephanie aveva preparato la crostata con il burro d’arachidi. Ma la mia lingua non era in grado di deglutire. «Stai cercando di uccidermi?» scherzai dopo aver desistito dallo spostare quella massa appiccicosa all’interno della bocca.
Rifiutavo di rassegnarmi. Consciamente, almeno.
Ma noi siamo creature fatte di subconscio. Comprai il libro Buddhism for Dummies cercando di usare lo zen per calmare la mente.
Qualche giorno dopo il martedì grasso del 2011, andai a New Orleans per un weekend lungo con la mia migliore amica, Nancy, e i nostri mariti. Le strade erano ancora piene di stelle filanti, decorazioni fatte di perline e rifiuti.
Nancy voleva visitare la zona devastata dall’uragano Katrina. Io, scusandomi, declinai: ero più interessata alle distrazioni. Una sera, in Bourbon Street, John e io ci trovammo di fronte a uno strip club.
Non è il mio genere di locale. Ero entrata in un posto simile solo due volte in vita mia, in entrambi i casi per lavoro.
La prima volta, un cliente aveva fatto causa a una spogliarellista dopo che questa l’aveva colpito in viso con la scarpa mentre ballava, procurandogli il distacco della retina e la frattura dell’osso orbitale.
La seconda, stavo seguendo la storia di una persona scomparsa, una cui parente lavorava in un locale chiamato Kitten Club. Entrai nell’esatto momento in cui stava esibendosi sul palco. Novanta chili di donna. I suoi seni sembravano gemelli che facevano la lotta.
«Dai, entriamo» proposi a John in Bourbon Street. «Cerchiamo davvero di non pensare a niente.»
Il locale era stracolmo. Probabilmente avevamo l’aria di chi spende molto perché il buttafuori ci fece sedere proprio al bordo del palcoscenico.
Lo spettacolo consisteva in tre donne – nude a parte una gonnellina scozzese da scolaretta lunga dieci centimetri – e un materasso dall’aspetto lurido.
Una di loro aveva partorito di recente, perché aveva il corpo sodo ma la pancia flaccida, segnata dalle smagliature. Sembrava che avesse appena avuto la montata lattea. Cercava con insistenza di indurci a infilare banconote tra i seni turgidi.
«Su, dolcezza, rilassati» fece rivolta a me.
«Per l’amor del cielo» dissi a John. «Dalle qualcosa per il bambino e andiamocene da qui.»
Cercammo un club meno sciatto, uno con un palcoscenico ampio e le poltrone in pelle. Questa volta ci sedemmo molto distanti dal palco.
Le donne facevano la lap-dance. Con agilità s’arrampicavano sul palo, si mettevano a cavalcioni, si attorcigliavano, dritte, di lato, a testa in giù. Assumevano la posa di renne saltellanti. C’era di che distrarsi in abbondanza, ma io osservavo le loro mani.
Afferravano il palo.
Lo tenevano stretto.
Forti.
Guardai la mia mano inutile, sapendo che non avrei mai più potuto afferrare le cose come facevano loro. I miei giorni di ballerina di lap-dance erano finiti prima ancora di cominciare.
La mattina dopo, a colazione, riferii a Nancy le ultime cattive notizie sulla moda direttamente da Bourbon Street: «Stanno tornando gli scaldamuscoli».
Ridemmo e cercai di non pensare alla mia mano.
Nancy e io ridiamo sempre quando siamo insieme.
Ma quando, all’aeroporto, ci abbracciammo per salutarci, lessi la verità nei suoi occhi. Preoccupazione. Tristezza. Sapeva che avevo la Sla. E lo sapevo anch’io.
Scoppiai in lacrime, proprio lì all’aeroporto di New Orleans.
«Non piangere» disse Nancy. «Non piangere, ti prego.» Per tirarmi su di morale cominciò a imitare il conducente ottuagenario della nostra navetta che aveva parlato al telefono con qualcuno per dieci minuti a voce altissima prima di esclamare: «Ma aspetta, tu sei mio CU-GI-NO Willie!».
Ridemmo e ci separammo asciugandoci entrambe gli occhi.
Tornata a casa, caddi in depressione.
Avevo tenuto a bada le mie paure per più di un anno. Avevo creduto nella mia salute anche se diventavo sempre più debole. Mi ero immersa nella maternità, nel lavoro, nel matrimonio e nei rapporti con gli amici più cari.
Quella primavera cominciai a fare la cosa contro cui avevo messo in guardia me stessa. Invece di vivere il momento scivolai nel terrore di un futuro con la Sla.
Mi vedevo non più in grado di camminare e di parlare. Di abbracciare stretti i miei figli e di dire loro che li amo. Avrei finito con il rimanere paralizzata, il corpo infermo ma la mente lucida. Avrei compreso e vissuto coscientemente ogni peggioramento. E sarei morta con i miei figli ancora così piccoli.
Cominciai a indugiare in quel futuro. Quando mi sedevo a mangiare, pensavo al momento in cui non sarei più stata capace di masticare. La notte restavo distesa nel letto sveglia a fissare il soffitto ripetendomi: «Un giorno, Susan, questo è tutto quello che riuscirai a fare. E accadrà presto».
Ciò che più temevo non era la morte. Era essere del tutto dipendente dagli altri. Un peso per la mia famiglia e per coloro che amavo.
Accennai alla paura di avere quella malattia a una mia amica, un brillante avvocato. «Oh, la Sla è peggio di una condanna a morte» disse scherzando. Non le rivolsi mai più la parola.
Per molto tempo evitai di parlare della Sla perché anch’io credevo la stessa cosa, che il mio futuro sarebbe stato peggio della morte.
Iniziai a prendere in considerazione l’idea di farla finita: dignitosamente, alle mie condizioni.
Pensavo al suicidio più o meno con la stessa frequenza con cui capita di vedere una farfalla. Era un’idea improvvisa che svolazzava rapida nella mia mente e io la studiavo stupendomi della sua simmetria. Poi si dileguava e la dimenticavo perché era solo un’idea passeggera.
Finché ritornò il giorno successivo, e quello dopo ancora. Perché la mia mente era un giardino. Ben tenuto, coltivato, ma incolto lungo i bordi. Un luogo perfetto per le farfalle.
Pensai di assoldare un sicario. Andare in un vicolo scuro all’altro capo della ...