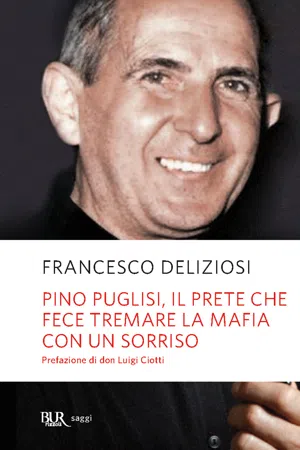![]()
1
Gli ultimi giorni
Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
(Gv 15,20)
Il giorno in cui l’ammazzarono padre Pino Puglisi aveva lavorato molto, nonostante fosse il suo compleanno. Gli capitava spesso, negli ultimi tempi, da quando era tornato nel suo vecchio quartiere, quasi a ricongiungere l’alfa e l’omega della vita. Un ritorno da parroco nella chiesa di San Gaetano, a Brancaccio, che aveva conosciuto cinquantasei anni prima, neonato curioso o sperduto nel sonno fra le braccia della mamma.
Il 15 settembre del 1993 padre Pino si svegliò di buon’ora. Nel calendario fitto fitto di una giornata intensa – due matrimoni e di pomeriggio gli incontri di preparazione al battesimo – era riuscito a inserire anche l’ennesimo appuntamento con la burocrazia. A Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, parlò con un alto funzionario insieme con i volontari dell’Intercondominio, l’associazione di uomini della borgata che lo sosteneva nelle sue battaglie. Un’altra anticamera seguita da un’altra delusione.
Il funzionario li ricevette nella tarda mattinata, ascoltò le loro richieste, il progetto di utilizzare per le attività della parrocchia gli scantinati di via Hazon 18, una terra di nessuno in mano alla criminalità organizzata. Consultò le carte, agitandosi sulla poltrona, lasciandosi scappare che «sì, quei locali si potrebbero requisire». Poi un sussulto e la doccia gelida: «Certo, voi però dovreste pagare l’affitto al Comune». Padre Pino diventò tutto rosso in viso. Si alzò in piedi e, raccogliendo la poca pazienza rimasta, disse con un filo di voce: «Viviamo in due mondi diversi, noi da un lato, lei dall’altro».1
Una delle prime battaglie dell’Intercondominio aveva avuto come obiettivo la costruzione di una nuova rete fognaria per la zona di via Hazon: i lavori, cominciati prima di una consultazione elettorale (le amministrative del 1990), si erano poi bloccati. E ripresero solo dopo che i volontari dell’associazione presentarono un esposto alla Procura.
Nell’aprile del ’92 era partita una campagna per chiedere l’istituzione del distretto socio-sanitario. 3P permise di piazzare i tavoli per la raccolta delle firme davanti all’ingresso della chiesa. E durante l’omelia domenicale esortò i fedeli a sostenere l’iniziativa.
Il 21 settembre del ’92 il gruppo di Brancaccio andò dall’assessore al Patrimonio del Comune, Simona Vicari, per chiedere ancora una volta la realizzazione della scuola media, la prima in un quartiere di ottomila abitanti. E per denunciare, dopo alcuni casi di epatite virale, l’emergenza igienica nei palazzi acquistati dall’amministrazione per duecento famiglie di sfrattati dal centro storico.
I volontari sospettavano che ci fossero state irregolarità nella compravendita degli edifici e nella gestione successiva: infatti moltissimi degli inquilini di Brancaccio non pagavano il canone mensile ma il Comune non faceva nulla per riscuotere le somme. L’assessore appoggiò la richiesta di requisizione degli scantinati2 e sulla gestione degli affitti inviò un esposto alla magistratura di cui diede notizia la stampa.3
Dopo quasi tre anni, padre Pino era vaccinato contro gli insuccessi e si era dovuto abituare anche alle minacce. Lucido e disincantato, ma non per questo amaro e disilluso, in una riunione con i giovani aveva detto a chiare lettere: «Le nostre iniziative e quelle dei volontari devono essere un segno. Non è qualcosa che può trasformare il quartiere. Questa è un’illusione che non possiamo permetterci. È soltanto un segno per fornire altri modelli, soprattutto ai giovani, e cercare di smuovere le acque.
«In questa prospettiva ha senso anche premere sulle autorità amministrative perché facciano il loro dovere, tentare di coinvolgere il maggior numero di persone in una protesta per i diritti civili. Ma non dobbiamo illuderci: da soli non saremo noi a trasformare Brancaccio. Lo facciamo soltanto per poter dire: dato che non c’è niente, noi vogliamo rimboccarci le maniche e costruire qualche cosa. E se ognuno fa qualche cosa, allora si può fare molto.»4
Dopo mesi e mesi di insistenze il parroco e i volontari dell’Intercondominio erano riusciti a ottenere un «filo diretto»: l’11 gennaio del 1993 parlarono con il sindaco dell’epoca, Manlio Orobello; il 4 agosto incontrarono il prefetto, Giorgio Musio, e in seguito diversi suoi collaboratori; per il 22 settembre padre Pino aveva in agenda un appuntamento riservato con l’allora presidente della commissione parlamentare antimafia, Luciano Violante, in occasione di una sua visita a Palermo.5
Nel quartiere si era sparsa la voce e dopo ogni riunione nei «palazzi degli sbirri», dopo ogni servizio in tv o sui giornali, si rincorrevano commenti del genere: «Per colpa del prete dicono che a Brancaccio sono tutti criminali»; «È ora che la smettano di farci fare brutta figura»; «I panni sporchi si lavano in famiglia».6
In caso di bisogno, l’abitudine radicata era di bussare a ben altre porte. Quelle richieste, quelle denunce, invece, scavalcavano gli uomini della cosca, i politici collusi. E provocavano la reazione dello Stato, un pericoloso attacco al dominio fino a quel momento pressoché incontrastato sul territorio.
Sull’onda dello shock per le stragi in cui erano morti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il 23 luglio 1992 i componenti dell’Intercondominio avevano scritto una lettera al presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Sollecitati da Roma, nel giro di poche settimane i poliziotti del commissariato di Brancaccio iniziarono a controllare gli atti del Consiglio di quartiere. Dopo l’incontro con il sindaco Orobello, in via Hazon 18 arrivarono i vigili urbani e ordinarono di sgomberare i sotterranei occupati abusivamente. Erano locali che servivano «come deposito per il traffico d’armi e di droga, per le scommesse clandestine, nonché come luogo d’incontro per la prostituzione anche minorile».7
Insieme con alcuni collaboratori, 3P incontrava periodicamente i parenti dei detenuti e aveva allacciato un dialogo anche con tossicodipendenti e pregiudicati oltre che con alcune donne imparentate a mafiosi di rango. Un compito difficilissimo, che lui stesso descrisse così: «Alle famiglie si può solo lanciare un messaggio, una corda per coloro che sono in una situazione drammatica, per tirarli fuori dalla palude in cui si trovano. Un esempio: si va in una casa dove un figlio è in carcere non perché drogato, ma per spaccio o i genitori sono agli arresti domiciliari per altri reati. Lì si può soltanto dire: siamo solidali con voi in questo momento di sofferenza, vi siamo vicini. Ma con uno stile, un approccio diverso, perché bisogna far capire che all’uscita dalla prigione non si può ricominciare daccapo, con le stesse attività malavitose di prima. Anche alle famiglie, però, si può dare un segno. Chi cerca il guadagno ad ogni costo, anche smerciando morte, può essere colpito dal vedere una suora, un volontario che vanno a trovarlo gratuitamente, per solidarietà umana e cristiana. Già questa visita è una controproposta».9
Erano stati tagliati fuori dalle attività della parrocchia i componenti di un comitato per i festeggiamenti del patrono, san Gaetano. «Finché ci sarò qua io» disse il sacerdote «non si organizzeranno manifestazioni che non hanno nulla a che fare con la religione. Qui c’è gente che muore di fame, è uno scandalo spendere decine di milioni per una festa del genere.»10
Non migliore fortuna era toccata a chi considerava la parrocchia un serbatoio di voti. Padre Puglisi mise alla porta i galoppini, strappò davanti a tutti le lettere con i facsimili elettorali. Il giorno dell’Epifania del ’93 – in occasione di un presepe vivente interpretato dai bambini – un gruppo di politici (alcuni poi finiti sotto processo per mafia) si presentò in prima fila. Il parroco li apostrofò così: «Nel quartiere c’è una situazione disagiata al massimo, senza una scuola media, la disoccupazione è a livelli altissimi, le famiglie sono disgregate, ci sono promiscuità incredibili. E voi venite a chiedere voti… ma con quale faccia vi presentate qui?».11
A maggio arrivò un altro avvertimento. Il sacerdote aveva voluto ricordare Falcone, nel primo anniversario della strage di Capaci, con una marcia silenziosa per le vie del quartiere. Sfilarono i giovani del liceo Basile di Brancaccio, un gruppo di volontari. Il corteo in parte fu trasmesso in diretta dal Tg3 delle 19. Ma molta gente della parrocchia, intimorita, preferì rimanere chiusa in casa. Il giorno dopo la manifestazione, il 22 maggio, due giovani su una moto di grossa cilindrata lanciarono bottiglie molotov davanti alla chiesa: si incendiarono il furgone dell’impresa e la cima di un alberello nell’aiuola vicino al portone.
«Non si può più?» avevano esclamato i ragazzi. «E se abbiamo bisogno di parlare?»
«C’è sempre tempo l’indomani» aveva risposto con aria innocente. «D’altronde è meglio così, potrebbero venire delle persone a trovarmi, a interromperci.»13
Una seccatura maggiore gli era capitata una domenica mattina alla fine della messa: trovò la sua Uno rossa con una ruota sgonfia. I parrocchiani volevano aiutarlo a sostituirla. Ma lui respinse l’offerta e tornò a casa a piedi pur di non far vedere a tutti che lo pneumatico era squarciato a coltellate.14 Un’altra volta si presentò in chiesa con un labbro spaccato. A un amico si limitò a dire: «Ho un herpes». A un altro, senza riuscire a essere più convincente: «Mi sono tagliato col rasoio».15
Decise di comportarsi così dopo che nella notte tra il 29 e il 30 giugno 1993 qualcuno aveva bruciato le porte di casa di tre volontari dell’Intercondominio. Certe battaglie per i diritti, certi incontri nei Palazzi dell’«altra» Palermo, non erano stati graditi. Padre Pino invitò dall’altare la comunità a essere vicina alle tre famiglie vittime degli attentati: «Facciamo sentire la nostra solidarietà. Andiamoli a trovare a casa, rimaniamo uniti. E ricordate: non è da Cosa nostra che potete aspettarvi un futuro migliore per il vostro quartiere. Non potranno mai darvi una scuola media per i vostri figli o un asilo nido dove lasciare i bambini quando andate al lavoro. Qui chi vuole studiare deve sobbarcarsi lunghi spostamenti. Evidentemente questo fa comodo a chi vuole che l’ignoranza continui».
Poi si rivolse direttamente ai mafiosi: «La Chiesa ha già colpito con la scomunica chi si è macchiato di atroci delitti come i cosiddetti uomini d’onore. Io posso soltanto aggiungere che gli assassini, coloro che vivono e si nutrono di violenza, hanno perso la dignità umana. Sono meno che uomini, si degradano da soli, per le loro scelte, al rango di animali».
Non mancò, in quell’omelia, un estremo tentativo di dialogo: «Mi rivolgo anche ai protagonisti delle intimidazioni che ci hanno bersagliato. Parliamone, spieghiamoci, vorrei conoscervi e conoscere i motivi che vi spingono ad ostacolare chi tenta di educare i vostri figli al rispetto reciproco, ai valori della cultura e della convivenza civile». Infine, leggendo negli occhi di tutti sbigottimento e timore, riuscì a dare un po’ di conforto ricordando un pensiero di san Paolo: «Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?».
Quanto alle battaglie per il quartiere concluse: «Non dobbiamo tacere, bisogna andare avanti. Ciò che è un diritto non si deve chiedere come un favore».17
Uno dei volontari presi di mira dagli attentati, Pino Martinez, gli aveva confessato: «Padre Puglisi, la paura in qualcuno di noi ha avuto il sopravvento e un paio di persone mi hanno fatto capire che si vogliono tirare indietro. Ma io so che con lei stiamo facendo un lavoro giusto, occupandoci dei problemi della zona e dei più bisognosi. E anche se mi ammazzano non me ne frega niente». La risposta del parroco era stata: «No, Pino. Tu hai moglie e figli. Io non ho né moglie né figli. E quindi...