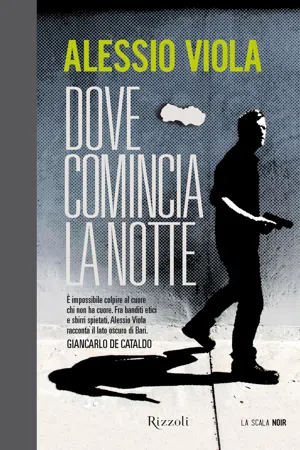![]()
1
Bari, 1999
La macchina del poliziotto era un cesso. Ovunque scontrini di parcheggi, pacchetti di crackers sbriciolati, lattine di Peroni, tovaglioli sporchi di ketchup che sembravano rifiuti di un pronto soccorso, giornali che risalivano ai tempi dell’attentato a Kennedy. Non ricordava più da quanti mesi non la lavava e, soprattutto, non ricordava perché avrebbe dovuto. Il motore girava ancora, e tanto bastava. Quei cazzo di coreani le sapevano fare bene le auto, la sua era leggera da guidare, silenziosa, poco appariscente: l’ideale per seguire uno spacciatore. A lungo aveva preferito le due ruote, ma ormai in città chiunque lo vedeva passare in moto, magari con qualche collega messo anche peggio di lui, capiva che era a caccia. Quasi mai grossa, per la verità: topini, come vengono chiamati a Bari gli scippatori, o piccoli pusher, ubriachi, puttane e tossici, roba del genere.
Al solito porcaio, quella sera nell’abitacolo rischiavano di aggiungersi i resti della cena, un panino con salsiccia, patatine, melanzane sott’olio e ogni schifezza possibile, comprato in un baracchino lungo una strada di periferia. Per fortuna la birra, in quei luoghi dell’orrore culinario, era sempre fredda al punto giusto, in ogni stagione, perché la conservavano nei cassoni frigo per gelati, e non faceva mai in tempo a ghiacciare del tutto, perché lo smercio era troppo rapido e massiccio. Stava per rientrare in macchina a mangiare, poi pensò che il deposito di rifiuti sarebbe aumentato oltre il livello di guardia e optò per sedersi a uno dei tavoli davanti al camper attrezzato come una friggitoria, vicino alle casermette.
Chissà per quale fantasia malata le avevano chiamate così: in realtà erano edifici enormi disposti sui viali lunghissimi – dove stavano parcheggiati vecchi e ingombranti automezzi, dalle jeep ai carri armati – fiancheggiati da camerate dove un tempo alloggiavano generazioni di soldati di leva. Ora quei soldati erano diventati professionisti, ma sulla loro utilità era meglio non porsi troppe domande. Quando era giovane, quella era periferia estrema, in mezzo al nulla, poi tutto intorno erano sorti palazzoni enormi che, paradossalmente, di colpo avevano reso la presenza delle caserme ingombrante per l’intero quartiere.
Il ragazzo che stava sorvegliando aveva mangiato praticamente gomito a gomito con lui, un paio di tavoli alla sua destra. Il poliziotto voleva capire se quello era un posto dove andava soltanto a vendere oppure anche a rifornirsi. Si rese subito conto che aveva un sacco di clienti fra i militari; non a caso in questura la segnalazione era arrivata dalle alte sfere dell’esercito, a cui non era sfuggito il traffico intorno alle salsicce. Lo spacciatore arrivava lì al tramonto, ma non regolarmente, non tutti i giorni, e si tratteneva fino a tardi. Già un paio di volte, per ingannare l’attesa, lo sbirro aveva passato serate intere a ingozzarsi di panini inzuppati d’olio e grasso animale e patatine fritte in un liquame scuro come il mare a gennaio. Sembrava che tutti i malavitosi della città si cibassero unicamente di quella robaccia; ogni volta che doveva pedinarne qualcuno finiva per mangiarci insieme in uno di quei posti al veleno che i baresi chiamano, affettuosamente, “pane e merda”. Rischiava di farsi scoppiare il fegato e gli toccava respirare per ore il tanfo infernale che si alzava dalle piastre di cottura per poi dominare il cielo basso delle notti d’inverno, e anche quello alto delle notti d’estate. Si incollava quasi all’aria, quell’odore, se lo attraversavi non te lo staccavi più di dosso. La nocività dei posti di lavoro.
Quella sera era arrivato sul tardi, sapeva che il tizio sarebbe rimasto fin dopo la mezzanotte. Le bustine di polveri varie e i pacchetti di stagnola erano già esauriti, così come le pillole e pure l’erba e il fumo: non c’era più niente da vendere. Se quel ragazzo avesse conosciuto il potere allucinante dell’olio rifritto si sarebbe messo a spacciare pure quello, c’era da scommetterci.
Il poliziotto si era sistemato a un tavolino rosso di plastica – di quelli che i fornitori regalano ai proprietari dei baracchini che garantiscono ordini importanti –con annesse sedie in tinta e l’irrinunciabile cestino per accogliere lanci non sempre precisi di tovaglioli sporchi e bottiglie di vetro.
Si sentiva una chiavica di stanchezza, la bocca mucillosa di quella cena letale. Aveva sperato che la birra servisse a sciogliere i grassi, ma si era solo alleata alla melma colesterolica che aveva appena ingollato. Risultato disastroso.
Il tizio si stava alzando dal suo tavolino-ufficio. Magro, fisico atletico, non aveva un bell’aspetto: un giaccone di quelli comprati dai cinesi, largo, sporco, con il colletto di pelliccia sintetica marrone, pieno di tasche, perfetto per nascondere la merce. Un cappello da baseball calato sulla fronte, per fare paura ai ragazzini che andavano da lui a comprare in processione, jeans e scarpe vere-finte-Nike dai colori improbabili e sbiaditi. La faccia era quella prevista dalle migliori antologie lombrosiane, scavata, scura, baffi spioventi e neri, capelli che spuntavano da sotto il cappellino, abbastanza lunghi da mostrare la scarsa familiarità con shampoo e barbieri. “Strano, sembra me da giovane” si disse il poliziotto, e sorrise, pensando alle tonnellate di cliché sulla somiglianza fra guardie e ladri di cui sono da sempre disseminati libri e film. Roberto De Angelis, soprintendente della Polizia di Stato, era uno sbirro di una certa cultura, questo andava detto.
Seduto sulla sedia di plastica rossa, le gambe distese, il giaccone abbottonato da marinaio, il collo alto a coprire la nuca, anche lui con un cappello grigio di cotone spesso – aveva evitato quello blu alla “cuculo”, troppo scontato – si rendeva conto che in effetti a separarlo dal ragazzo che teneva sotto controllo c’era solo una sottile ma tenace lamina multistrato di storia, famiglia e amori. Gli anni di sport gli avevano lasciato in eredità, dopo che aveva smesso, il classico ingrassamento veloce e irreversibile, così adesso si era collocato in modo stabile intorno ai cento chili e, anche se conservava una certa agilità e un’andatura piuttosto leggera, nel complesso la sua era la tipica sagoma dell’orso cittadino. La barba incolta, grigia con chiazze bianche divenute col tempo protagoniste assolute del volto, e una chioma sempre più rada ma ostinatamente raccolta in un codino che metteva in patetica evidenza la stempiatura: tutto lo posizionava in un ideale schedario fotografico accanto a Giacinto, l’uomo dal nome mitologico che stava studiando.
Tirò fuori il portasigarette americano in metallo, rigorosamente made in China, estrasse una sigaretta senza filtro, eseguì con studiata flemma la cerimonia in cui la picchiettava sul coperchio per addensare le foglioline, dare loro compattezza e garantirsi che la giusta quantità di catrame e nicotina entrasse nei polmoni, e con il classico zippo la accese, soffiando verso l’alto la prima arrapante boccata del dopocena. Ora se ne vergognava un po’, ma aveva iniziato a fumare proprio per poter mettere in scena quella cerimonia tante volte ammirata nei vecchi film. “Se ti accendi una sigaretta in quel modo, se fumi a quel ritmo, con quella contrazione del viso alla Bogart, sei di un altro mondo” aveva sempre pensato, “quello dei bianconeri che resistono all’avanzata chiassosa e puttana del colore. Sarai diverso dagli altri, nel tuo orizzonte non ci sarà spazio per nessun arcobaleno.” Era adolescente, e per uno come lui era stato del tutto naturale desiderare di diventare poliziotto. Che altro avrebbe potuto fare, quale altro posto di lavoro gli avrebbe permesso di passare notti intere a fumare e bere caffè, girovagare in macchina con la musica a palla e una calibro 9 sotto l’ascella, che quando uno la sentiva, anche per sbaglio, a contatto con la pelle gli partiva l’adrenalina a mille?
Si lisciò con una mano il codino, che ormai nell’ambiente era il suo tratto distintivo: lo sbirro col codino e la barba. Non lo sopportava più, a dirla tutta, quasi ogni giorno accarezzava l’idea di tagliarlo, una rasatura netta, testa pelata da duro alla Bruce Willis, ché a fine millennio il modello Serpico era davvero improponibile. Poi il pensiero degli sfottò, i colleghi che avrebbero sottolineato la sua resa alla vecchiaia, le commesse del centro che non lo avrebbero guardato più con la golosa curiosità che lo sfiorava quando scorrazzava per quelle vie, tutto questo lo costringeva a rimanere legato a quel codino che teneva nascosto sotto i cappelli o dentro il collo di giubbotti e giacconi.
Roberto stava finendo la sigaretta, una Gitanes da notte che neppure i più cazzuti colleghi francesi, e osservava il tizio che raccoglieva le sue cose e si scrollava di dosso briciole e avanzi vari. Doveva avere appena concluso l’ultima vendita, gli era sembrato di sentire storie di macchine, probabilmente stava per fare da mediatore per il riscatto di un’auto rubata. Ma lui non era lì per quello. Bisognava capire da dove si muoveva il tipo, se aveva – e dove – una base, un punto di appoggio. Dopo i suoi giri da rappresentante delle multinazionali della droga spariva in fretta, e non erano ancora riusciti a localizzare dove cazzo andasse a rintanarsi. Avevano cercato di beccarlo con appostamenti intorno a casa, quella della madre, ultimo domicilio conosciuto: niente. Fuori dai bigliardi dove se la faceva ogni tanto, o da una delle fidanzate. Ma pareva non frequentare più quei posti, doveva necessariamente avere un nuovo alloggio, una cupa sicura per sé e per la merce. E Roberto era incaricato di scoprirla. L’aveva già pedinato un paio di volte, ma il ragazzo era sospettoso, si era visto una moto nello specchietto, in genere il mezzo preferito di chi spara: una notte aveva cominciato a compiere lunghi giri oziosi, si era fatto il tour di tutti i bar e alla fine il poliziotto aveva capito che lo stava solo portando in carrozzella. Per questo era passato alla coreana. Piccola, scura, anonima: Lanos – chissà cosa voleva dire. Era la sua macchina, e in una città come Bari tutti conoscono le macchine della borghese, come viene chiamata nei quartieri popolari.
Non si erano mai incontrati di persona, il ragazzo era abbastanza nuovo del mestiere, in questura aveva una scheda piuttosto “ordinaria”: scippi, rapine, furti d’auto. Probabilmente conosceva lo sbirro di nome o di fama, ma non aveva fatto una piega quando entrambi avevano ordinato trigliceridi a volontà per spaccarsi le arterie. Destino comune, a quanto pareva.
Il tizio si era avviato verso la sua Tipo vecchio modello, un tempo doveva essere stata grigia, quasi una macchina d’ordinanza per un guerrigliero metropolitano – così li chiamavano gli esperti dell’antiterrorismo negli anni di piombo. Ottima per mimetizzarsi, insomma. Il ragazzo salì sull’auto e partì. Lui gli si mise dietro a bordo della piccola coreana, con calma, tenendosi a distanza. Quasi niente traffico in uscita dalla città, la tangenziale si immergeva nel buio, i pochi lampioni diffondevano una luce da film giallo. Qualche puttana si attardava sulle complanari, i loro fuochi andavano spegnendosi come il sogno di vivere un’esistenza degna di quel nome.
Si lasciarono alle spalle il panorama della periferia barese, capannoni industriali e costruzioni abusive di ogni sorta, impianti sportivi abbandonati a metà e teatri tenda muniti di permesso e copertura della malavita, officine dove si smontavano le macchine rubate e si depositavano i cartoni di sigarette sbarcati a San Giorgio, il porticciolo antico a sud della città, quello dove a maggio approda la statua del santo patrono, San Nicola, nei giorni della festa.
Arrivarono alle schiere di villette edificate negli antichi Settanta – una distesa ininterrotta di complessi e villaggi che si allungava per tutto il litorale sud – abitate da una piccola borghesia che un tempo pensava di trovare l’America e che invece si era risvegliata in una periferia isolata e grigia, con stradine che si immettevano in maniera suicida nel traffico assurdo della tangenziale.
Roberto sorrise tra sé. Non per Yellow Submarine, all’improvviso trasmessa dall’autoradio, un Sony rubato da un topino che aveva fermato mesi prima: scampato l’arresto, il bastardello si era beccato soltanto una grandiosa mazzolata e, in segno di riconoscenza, il giorno dopo gli aveva fatto recapitare al bar sotto casa il simpatico dono, che lui aveva accettato senza battere ciglio. No, Roberto sorrideva perché, avvicinandosi a Torre a Mare, il quartiere alla periferia sud-est dove i baresi andavano per obbligo istituzionale a prendere il caffè, stava lasciando la strada a tre corsie che qualche anno prima era stata memorabilmente presentata dall’allora sindaco, un socialista, con parole scolpite nella roccia: «Stiamo raddoppiando la tangenziale, che passerà da quattro a sei corsie» aveva annunciato, con tanti saluti all’aritmetica, se non ai buoni affari. Era la fine degli anni Ottanta, i mondiali di calcio stavano arrivando anche a Bari, c’era bisogno di nuove infrastrutture. Sparito nel nulla quel sindaco, ricordava l’agente, insieme a decine di altri compagni di merende, agli inizi dei fantastici anni Novanta che avrebbero dovuto cambiare tutto. Ne aveva visti passare in tanti, dalla questura, e sembrava davvero che stesse per cominciare un altro corso. Invece adesso, finito quel momento magico, si ritrovavano nelle mani di un miliardario milanese che si preoccupava solo dei cazzi suoi. “Beato lui che si fa portare a casa le ragazze selezionate per i vari Drive In e tutto il resto” concluse i suoi pensieri De Angelis, con un’invidia della madonna.
«Cazzo va questo?» si chiese ad alta voce. La Tipo aveva svoltato di colpo a destra, un’uscita mal segnalata sulla tangenziale. La freccia indicava la direzione per Noicattaro, paese di nessuna importanza verso l’interno.
«Bravo, te ne sei venuto in periferia, fuori dalla pazza folla. E bravo Giacinto…» commentò Roberto chiamandolo confidenzialmente per nome. Giacinto Trentadue: furti, spaccio, il curriculum classico del delinquente di strada, l’apprendistato indispensabile per chi vuole collocarsi bene nell’ambiente, come si autodefinisce la malavita organizzata in tutte le sue forme. Una carriera ordinaria, senza azioni armate, tutto sommato sembrava uno innocuo. Della serie: dobbiamo pur campare, dottò, che altro possiamo fare?
Era una zona di residence, quella. Alcuni, “storici”, esistevano dalla fine dei Settanta e portavano nomi presuntuosi: Parchitello, Primavera, cose di questo genere. Altri erano stati edificati a ridosso di Italia ’90, qualche costruttore aveva fiutato l’affare, immaginato palazzi che si sarebbero riempiti delle migliaia di calciofili affluiti da ogni dove per le partite previste a Bari. “Te le raccomando” pensò De Angelis tornando con la memoria a quei mesi. Un mondiale di merda, e quella faccia di cazzo di argentino che insultava il pubblico, nello stadio di Renzo Piano nuovo di zecca, intitolato con una stupefacente trovata di originalità a San Nicola. «Hijos de puta»: il labiale accuratamente evidenziato dalle telecamere che segnò gli spettatori di quella poco memorabile semifinale. Finito il mondiale erano andati in buca, i costruttori, dal primo all’ultimo, e si erano acconciati a mettersi sul mercato per ottenere un profitto, ché tanto le spese le avevano già recuperate con i finanziamenti pubblici; ci mancherebbe che andavano a perderci…
La Tipo del ragazzo rallentava, la stradina era stretta, il poliziotto si teneva distante, ne scorgeva appena le luci rosse posteriori in lontananza, ma tanto non c’era nessuno in giro. La vide fermarsi e fece altrettanto, parcheggiando sul margine della carreggiata. Spense il motore, scese accostando piano lo sportello. Si mise quasi a correre per portarsi al punto dove si era fermato lo spacciatore che, sempre a bordo della Tipo, aveva rimesso in moto e ora stava entrando in un residence. “Poggiofelice” diceva la scritta a caratteri di cemento, grossi e bassi, che dominava la recinzione.
“Guarda dove si è andato a rifugiare il chiavico!” pensò affibbiandogli la patente dialettale che a Bari si riserva ai furbi e a tutti quelli che si credono tali. Intorno soltanto silenzio, il maestrale che si era alzato, il mare non lontano. L’aria pungente e salata gli diede un brivido di piacere. Si avvicinò a quello che sembrava un vero e proprio muro di cinta, c’era anche una sbarra all’entrata attraverso cui si intravedeva qualche luce dalle ville all’interno del complesso. Mentre cercava di capire come fosse organizzato l’ingresso al residence, si chiese se fosse il caso di entrare subito.
Si stava avvicinando un’altra auto, ne avvertì il rumore, arrivava veloce. Si schiacciò contro un ulivo, uno di quelli giganteschi che in Puglia non mancano mai, te li trovi sempre fra i piedi, e per fortuna qualche volta servono.
La macchina veniva dritta al residence. Rallentò vicino all’entrata e ne scese un tizio tarchiato. Da com’era vestito poteva passare per un pescivendolo: stivali corti di gomma, maglione oversize, giaccone da barca. Andò con passo sicuro alla sbarra, la alzò e ritornò verso l’auto, una Golf che aveva certo conosciuto giorni migliori, grigio metallizzata, impossibile da notare in città.
La faccia non gli era nuova, cercò di memorizzarne i tratti, avrebbe verificato in questura. Un volto tozzo e scuro di chi è stato molto tempo al sole o in mare. Barba non rasata, naso schiacciato, un brillantino all’orecchio sinistro che invece di ingentilirne i tratti li rendeva ancora più sgradevoli, non proprio il tizio che vorresti incontrare di notte, in una strada buia. Una faccia così c’era di sicuro, nei loro archivi. Scorse un’altra persona in macchina, forse una donna, i capelli sembravano lunghi ma magari era un capellone in cerca di pasticche con cui concludere la serata, vai a sapere. La Golf imboccò il vialetto, si diresse verso il centro del villaggio, dove si intravedevano le luci di una piscina.
Gli occhi si andavano abituando all’oscurità, ora Roberto riusciva a mettere meglio a fuoco un particolare. Oltre la sbarra, dietro un cespuglio, c’era un’auto ferma. I fari erano spenti, ma nel buio si notavano i riflessi azzurrini di uno stereo che evidentemente teneva compagnia ai suoi due passeggeri. Doveva essere una specie di posto di blocco, una guardiania non proprio giurata. Il poliziotto decise di mettere a frutto il suo passato da atleta. Aveva corso i 400 ostacoli e poi giocato a rugby per anni. Non doveva essere difficile trovare un punto per scavalcare, magari nascosto tra gli ulivi ghiacciati. Si allontanò dal cancello, costeggiò il muro che si inoltrava in una campagna fredda e buia come la notte di una puttana senza clienti. L’accesso c’era, più di uno in verità. La manutenzione non era un granché, più o meno come tutto il resto.
Roberto sperò in cuor suo che non ci fossero cani in giro. Non è che ne avesse particolarmente paura, ma preferiva evitarli. Immaginò il classico dobermann pazzo scatenato: non avrebbe esitato a farlo stare tranquillo, la Beretta doveva pur servire a qualcosa, e pazienza se l’avessero scoperto. Li odiava quei cani.
Scavalcò e scese dall’altra parte senza difficoltà, ...