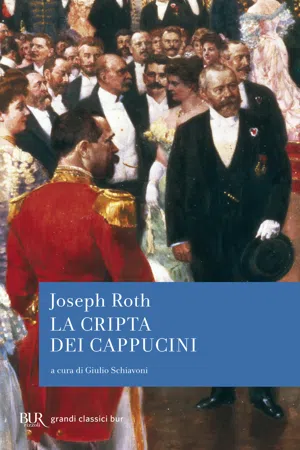![]()
LA CRIPTA DEI CAPPUCCINI
La traduzione è stata condotta sull’edizione Allert de Lange del 1975.
![]()
I
Ci chiamiamo Trotta. La nostra casata proviene da Sipolje, in Slovenia. Dico proprio casata, in quanto noi non siamo una famiglia. Sipolje non esiste più, da un bel pezzo. Costituisce ormai, assieme a parecchie località limitrofe, un comune più esteso. È la volontà dei tempi, si sa. Le persone ormai sono incapaci di star sole. Si associano in assurdi raggruppamenti; e neppure i piccoli villaggi riescono a star soli. E così ne derivano assurdi agglomerati. I contadini si sentono spinti verso la città, e anche i piccoli villaggi anelano, adesso più che mai, a trasformarsi in città.
A ogni modo, ho potuto conoscere Sipolje ancora da ragazzo. Mi ci aveva portato con sé mio padre, un 17 agosto, alla vigilia del giorno in cui in tutte le località della nostra Monarchia, anche nelle più piccole, si festeggiava il compleanno di Francesco Giuseppe I.
Nell’Austria di oggi e nelle regioni che hanno fatto parte della Corona saranno ancora pochissime le persone per cui il nome del nostro casato potrebbe evocare qualche ricordo. Esso è però registrato negli annali dispersi del vecchio esercito austro-ungarico, e confesso di andarne fiero, proprio perché quegli annali sono dispersi. Io non sono un figlio dell’epoca presente; anzi, provo difficoltà a non definirmi un suo oppositore. Non che non la comprenda, come tante volte sostengo (questa è soltanto una scusa pietosa). Semplicemente – per indolenza – non voglio diventare offensivo né rendermi odioso. Per cui mi limito a dire che non comprendo una certa qual cosa, mentre invece dovrei dire che la trovo odiosa o spregevole. Faccio il sordo, anche se ci sento benissimo. Considero più nobile fingere di avere un difetto anziché confessare d’aver udito rumori volgari.
Il fratello di mio nonno era quel sottotenente di fanteria che salvò la vita all’imperatore Francesco Giuseppe nella battaglia di Solferino. Al sottotenente fu conferito un titolo nobiliare. Per lungo tempo nell’esercito e nei libri di storia della Monarchia imperial-regia fu ricordato come l’eroe di Solferino, fin quando – per suo stesso desiderio – su di lui si stese l’ombra dell’oblio. Si congedò. E adesso è sepolto a Hietzing. Sulla sua lapide sono scolpite le semplici e superbe parole: «Qui riposa l’eroe di Solferino».
La benevolenza dell’imperatore volle estendersi anche a suo figlio, che divenne capitano distrettuale, e al nipote, sottotenente dei cacciatori, caduto nella battaglia di Krasne-Busk nell’autunno del 1914. Io non l’ho mai veduto, così come non ho veduto nessuno dei componenti del ramo nobile del nostro casato. I Trotta che avevano ottenuto il titolo nobiliare erano divenuti devoti e umili servitori di Francesco Giuseppe. Mio padre, invece, era un ribelle.
Era un ribelle e un patriota, mio padre: una specie che si poteva incontrare soltanto nella vecchia Austria-Ungheria. Voleva riformare l’Impero e salvare gli Absburgo. Comprendeva troppo bene il significato della Monarchia austriaca. Per cui divenne sospetto e dovette fuggire. Ancor giovane, se n’andò in America. Di professione era chimico. A quell’epoca c’era bisogno di persone come lui negli stabilimenti di preparazione dei colori – in enorme sviluppo – di New York e Chicago. Finché era stato povero, mio padre aveva provato nostalgia soltanto dell’acquavite. Ma quando aveva finito per arricchirsi, iniziò a provare nostalgia dell’Austria stessa. Tornò indietro e si stabilì a Vienna. Aveva denaro, e la polizia austriaca apprezzava le persone facoltose. Mio padre non soltanto non ebbe seccature, ma diede persino avvio a un nuovo partito sloveno, e comprò due giornali di Zagabria.
Ebbe amici influenti nell’ambiente più vicino all’erede al trono, l’arciduca Francesco Ferdinando. Mio padre sognava un regno slavo sotto il dominio degli Absburgo. Sognava una Monarchia degli austriaci, degli ungheresi e degli slavi. E a me, che sono suo figlio, sia permesso a questo punto di dire che, se fosse vissuto più a lungo, mio padre avrebbe potuto – così credo, perlomeno – mutare il corso della storia. Invece morì circa un anno e mezzo prima dell’assassinio di Francesco Ferdinando. Io sono il suo unico figlio. Nel suo testamento mi ha designato come l’erede delle sue idee. Non a caso mi aveva fatto battezzare col nome di Francesco Ferdinando. Allora però io ero soltanto un giovane sciocco, per non dire sconsiderato. In ogni caso ero avventato. Vivevo allora, come si suol dire, alla giornata. Anzi, più esattamente: vivevo alla nottata. Di giorno, dormivo.
![]()
II
Una mattina di aprile del 1913, però, mentr’ero ancora semiaddormentato, dopo essere rincasato appena da due ore, mi fu annunciata la visita di un mio cugino: un certo signor Trotta.
Andai nell’anticamera, in vestaglia e pantofole. Le finestre erano spalancate. Nel nostro giardino i merli mattinieri gorgheggiavano assidui. Il primo sole inondava allegramente la stanza. La nostra giovane cameriera, che di mattino non mi era ancora mai capitato di vedere così di buon’ora, mi parve un’estranea nel suo grembiule blu, perché la conoscevo soltanto come una personcina fatta di biondo, nero e bianco, pressappoco come una bandiera. Per la prima volta mi appariva in una divisa blu scuro, simile a quella che indossavano meccanici e letturisti del gas, con in mano uno spolverino color rosso porpora. La sua sola vista sarebbe bastata a darmi un’immagine del tutto nuova e inconsueta della vita. Per la prima volta dopo diversi anni vedevo il mattino in casa mia, e mi accorsi ch’era bello. Mi piaceva la cameriera. Mi piacevano le finestre aperte. Mi piaceva il sole. Mi piaceva il canto dei merli. Era dorato come il sole del mattino. Persino la nostra giovane cameriera vestita di blu appariva dorata come il sole. Abbagliato da tutto quell’oro, a tutta prima non distinsi l’ospite che mi stava attendendo. M’accorsi di lui solo dopo qualche secondo, o forse addirittura dopo qualche minuto. Smilzo, silenzioso, di carnagione bruna, sedeva sull’unica sedia presente nella nostra anticamera; quando io entrai, non si mosse neppure. Benché i suoi capelli e i suoi baffi fossero così neri, e la sua carnagione così bruna, in mezzo all’oro mattutino che inondava l’anticamera lui era simile a un frammento di sole, al frammento comunque di un sole meridionale e lontano. Al primo sguardo mi ricordò il mio povero papà. Anche lui era stato altrettanto smilzo e nero, bruno di carnagione e ossuto, scuro, un autentico figlio del sole, ben diverso da noi, i biondi, che siamo soltanto i figliastri del sole. Io parlo sloveno; era stato mio padre a insegnarmelo. Perciò salutai mio cugino Trotta in sloveno. Lui non parve affatto stupirsene. Era una cosa ovvia. Non si alzò, rimase seduto. Mi porse la mano, sorridendo. Sotto i baffi d’un colore nero bluastro i suoi denti candidi, forti e grandi, rilucevano. Mi diede subito del tu. E dentro di me ebbi la sensazione che quello fosse «un fratello, non un cugino»! Aveva avuto il mio indirizzo dal notaio.
«Tuo padre» cominciò «m’ha lasciato in eredità duemila fiorini e io sono venuto a ritirarli. Sono qui per ringraziarti. Intendo rientrare domani. Ho anche una sorella, e adesso voglio maritarla. Con cinquecento fiorini di dote, si prenderà il coltivatore più ricco di Sipolje.»
«E il resto?» chiesi.
«Quello lo tengo per me» rispose allegro.
Sorrideva, e a me pareva che il sole inondasse ancor più intensamente la nostra anticamera.
«Che farai di questo denaro?» gli chiesi.
«Aumenterò il mio giro d’affari» rispose. E, come se soltanto allora fosse il momento giusto per presentarsi, si alzò da sedere. C’erano un’ardita sicurezza nel suo alzarsi e una commovente solennità nel modo in cui pronunciò il suo nome: «Mi chiamo Joseph Branco» disse.
Solo allora mi resi conto di star di fronte al mio ospite in vestaglia e pantofole. Per questo lo pregai di attendere, e andai in camera a vestirmi.
![]()
III
Quando arrivammo al Caffè Magerl dovevano essere all’incirca le sette del mattino. Stavano già arrivando i primi garzoni dei fornai, bianchi come la neve e con addosso il profumo di rosette croccanti, di trecce ai semini di papavero e di baguettes spruzzate di sale. Il primo caffè appena tostato, vergine e aromatico, aveva il profumo di un secondo mattino. Mio cugino Joseph Branco era seduto al mio fianco, scuro di carnagione, quasi meridionale, allegro, vispo e debordante di salute, mentre io mi vergognavo del mio biondo pallore e della stanchezza che avvertivo dopo la notte insonne. Provavo anche un po’ d’imbarazzo. Che cosa dirgli? Il mio imbarazzo aumentò quando mi sentii dire: «Al mattino non prendo caffè. Vorrei piuttosto una minestra». Naturale! A Sipolje i contadini, alla mattina, prendevano minestra di patate.
Allora ordinai una minestra di patate. Trascorse parecchio tempo prima che la portassero. Nel frattempo, non senza vergogna inzuppai il mio cornetto nel caffè. Finalmente la minestra arrivò: era un bel piatto fumante. Mio cugino Joseph Branco parve infischiarsene del cucchiaio, e con le sue mani scure e villose si portò il piatto fumante direttamente alla bocca. Mentre sorbiva rumorosamente la sua minestra pareva essersi dimenticato anche di me. Interamente dedito a quel piatto fumante, che sorreggeva con le dita sottili e vigorose, dava comunque l’idea di una persona il cui appetito, in realtà, mantiene intatto un nobile impulso e che non tocca il cucchiaio soltanto perché considera più distinto mangiare direttamente dal piatto. Così, mentre lo osservavo sorbire la minestra, trovai quasi incomprensibile che gli uomini avessero inventato un ridicolo arnese come il cucchiaio. Mio cugino mise via il piatto, e io potei notare che era completamente vuoto e lustro, come fosse stato appena lavato e ripulito.
«Questo pomeriggio» disse «andrò a ritirare il denaro.» Gli chiesi allora che genere di affari intendesse portare avanti investendovi quel denaro. «Be’,» rispose «piccole cose, che però assicurano a una persona di poter superare l’inverno.»
E così appresi che, nella primavera, in estate e in autunno, mio cugino Joseph Branco faceva l’agricoltore, dedicandosi al lavoro nei campi, mentre d’inverno arrostiva le castagne. Aveva una pelle di montone, un mulo, un carretto, un paiolo e cinque sacchi di castagne. Così equipaggiato, tutti gli anni a inizio novembre girava per diverse zone della vecchia Monarchia. Se però in una determinata località si trovava particolarmente bene, allora ci restava per tutto l’inverno, fino all’arrivo delle cicogne. Dopodiché legava al mulo i suoi sacchi vuoti e s’avviava per raggiungere la stazione ferroviaria più vicina. Caricava l’animale, rientrava a casa propria e tornava a fare il contadino.
Gli chiesi come intendesse ingrandire un’attività così modesta, e lui mi fece capire che vi si potevano aggiungere tante altre cose. Ad esempio, oltre alle castagne si potevano vendere anche mele al forno e patate arrostite. E poi il mulo ormai era diventato vecchio e debole, e se ne sarebbe potuto comprare un altro. In ogni caso aveva già messo da parte duecento corone.
Indossava una magnifica giacca di raso e un panciotto di felpa a fiori con bottoni di vetro colorato e, attorno al collo, aveva una pesante catena da orologio, in oro, finemente intrecciata. E io, che ero stato educato da mio padre all’amore per gli slavi del nostro Impero, e che di conseguenza tendevo a considerare un simbolo ogni espressione folcloristica, m’invaghii immediatamente di quella catena. La volevo a tutti i costi. Così chiesi a mio cugino quanto valesse.
«Non ne ho idea,» rispose «l’ho ricevuta da mio padre, e lui a sua volta dal suo. Cose del genere non si possono comprare. Ma, visto che sei mio cugino, te la vendo volentieri.»
«Allora quanto fa?» gli chiesi.
E in cuor mio, memore degli insegnamenti di mio padre, pensai che un contadino sloveno fosse troppo nobile d’animo per badare al denaro e al suo valore.
Mio cugino Joseph Branco rifletté a lungo, poi disse: «Ventitré corone».
Non osai chiedergli come fosse arrivato proprio a quella cifra. Gliene diedi venticinque. Le contò accuratamente, senza per nulla accennare a volermi rendere le due corone che erano in più, estrasse dalla tasca un grosso fazzoletto rosso a quadretti blu e ci nascose dentro il denaro. Richiuse il fazzoletto, facendovi un doppio nodo, e soltanto dopo si slacciò la catena, estrasse l’orologio dal taschino del panciotto e mise catena e orologio sul tavolo. Era un orologio d’argento, massiccio, alla vecchia maniera, con una chiavetta per dargli la carica. Mio cugino indugiò un momento prima di sfilarlo dalla catena, lo guardò per un istante con tenerezza, quasi con affetto, e alla fine disse: «Soltanto perché sei mio cugino! Se mi dai altre tre corone ti vendo anche l’orologio!».
Gli allungai una moneta da cinque corone. Non mi diede il resto neppure stavolta. Estrasse di nuovo il fazzoletto, disfece lentamente il doppio nodo, ripose la moneta assieme alle altre, infilò il tutto nella tasca dei calzoni e poi mi guardò ingenuamente negli occhi.
«Mi piace anche il tuo panciotto!» dissi dopo qualche secondo. «Vorrei che mi vendessi pure quello!»
«Soltanto perché sei mio cugino» rispose «ti venderò anche il panciotto.»
E, senza esitare neanche un istante, si tolse la giacca, poi si sfilò il panciotto e me lo allungò sopra al tavolo.
«È di buona stoffa» disse Joseph Branco «e i bottoni sono deliziosi. Soltanto perché sei tu, fa due corone e mezza.»
Gliene diedi tre e notai nettamente nei suoi occhi la delusione perché non erano state di nuovo cinque. Parve contrariato, non sorrideva più; alla fine però ripose il denaro in maniera altrettanto meticolosa e complicata che le volte precedenti.
Adesso possedevo – così mi parve – le cose essenziali per essere un vero sloveno: una catena antica, un panciotto colorato e un orologio che aveva smesso di funzionare, pesante come un sasso e munito della sua chiavetta. Non indugiai neppure un istante. Mi misi addosso immediatamente tutte e tre le cose, pagai e feci chiamare un vetturino. Accompagnai mio cugino all’albergo: alloggiava al Corno verde. Lo pregai di aspettarmi quella sera stessa: sarei passato a prenderlo. Avevo intenzione di presentarlo ai miei amici.
![]()
IV
In modo puramente formale, come scusante e anche per tranquillizzare mia madre, mi ero iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Però ovviamente non seguivo le lezioni. Di fronte a me si apriva la grande vita, un prato variopinto, delimitato appena dalla remota, remotissima linea dell’orizzonte. Vivevo nell’allegra, anzi sfrenata compagnia di giovani aristocratici, il ceto sociale del vecchio Impero che, insieme a quello degli artisti, era il mio preferito. Condividevo con loro la scettica leggerezza, la malinconica impertinenza, la scandalosa trascuratezza e l’arrogante dissolutezza: tutti segni del decadimento, che noi a quell’epoca non vedevamo ancora profilarsi. Al di sopra dei bicchieri da cui spavaldamente bevevamo, la morte già intrecciava, invisibile, le sue mani ossute. Imprecavamo allegramente e, con aria spensierata, addirittura bestemmiavamo. Carico d’anni e solitario, remoto e quasi irrigidito, eppure a noi tutti vicino e onnipresente nel grande e variopinto Impero, viveva e regnava il vecchio imperatore Francesco Giuseppe. Forse da qualche parte, nelle oscure profondità delle nostre anime, sonnecchiavano quelle certezze che vengon dette presentimenti: soprattutto la certezza che il nostro vecchio imperatore, ogni giorno che aggiungeva alla propria vita, moriva un po’, e che insieme a lui moriva anche la Monarchia. Quello che stava finendo, in verità, non era la nostra patria, ma piuttosto il nostro Impero, cioè qualcosa di più grande, di più vasto, di più elevato di una pura e semplice patria. Dai nostri cuori grevi nascevano facezie leggere; dalla nostra consapevolezza di essere destinati alla morte derivava in noi un insensato piacere per tutto ciò che ci recava l’affermarsi della vita: balli, locali col vino novello, ragazze, buoni cibi, gite in carrozza, follie di ogni genere, assurde avventure, ironia a nostro stesso danno, critica feroce, Prater, Grande Ruota, teatro delle marionette, balli in maschera, balletti, frivoli giochi amorosi tra i palchi discreti dell’Opera imperiale, esercitazioni militari che noi snobbavamo, e addirittura le malattie di cui di tanto in tanto l’amore ci gratificava…
Si potrà facilmente capire che salutai con favore l’arrivo inaspettato di mio cugino. Nessuno dei miei frivoli amici aveva un cugino del genere, né tanto meno un simile panciotto, una simile catena d’orologio e un rapporto così stretto con una terra d’origine quale la favolosa Sipolje, in Slovenia, la patria dell’allora non ancora dimenticato e comunque già leggendario eroe di Solferino.
Alla sera andai a prendere mio cugino. La sua luccicante giacca di raso fece un’enorme impressione su tutti i miei amici. Lui balbettava un tedesco incomprensibile, rideva molto, esibendo i suoi forti denti di un bianco lucente, accettava che gli si pagasse ogni cosa, prometteva di acquistare in Slovenia per i miei amici altri panciotti e catene, accettando volentieri degli acconti. Il fatto è che tutti mi invidiavano il panciotto, la catena e l’orologio. E tutti, soprattutto, si sarebbero comprati volentieri mio cugino per intero, il mio parentado e la mia Sipolje.
Mio cugino promise di tornare in autunno. Lo accompagnammo tutti alla stazione. Io gli procurai un biglietto di seconda classe. Lui lo prese, andò in biglietteria e riuscì a farselo cambiare con uno di terza.
Dal suo scompartimento accennò, con la mano, ancora un saluto. E a tutti noi si spezzò il cuore, quando il treno sferragliando lasciò la stazione. Amavamo infatti la tristezza con la stessa identica spensieratezza con cui amavamo il piacere.
![]()
V
Nella nostra allegra brigata si continuò a parlare di mio cugino Joseph Branco per diversi giorni. Poi tornammo a dimenticarlo; o meglio, per così dire lo mettemmo momentaneamente da parte. Le ultime bravate della nostra vita chiedevano infatti di essere discusse e apprezzate.
Solo sul finire dell’estate, all’incirca il 20 di agosto, ricevetti da parte di Joseph Branco una lettera in sloveno che tradussi ai miei amici la sera stessa. Descriveva i festeggiamenti per il compleanno dell’imperatore a Sipolje, i festeggiamenti organizzati dall’associazione dei veterani. Lui era un riservista ancora troppo giovane per far parte dei veterani. Però aveva marciato assieme a loro fino alla Waldwiese, dove ogni 18 agosto veniva organizzata una festa popolare, semplicemente perché nessuno degli anziani aveva più la forza di portare il grande timpano. C’erano cinque suonatori di corno e tre clarinettisti. Ma cos’è una banda senza il timpano?
«Questi sloveni» disse il giovane Festetics «sono proprio strani! Gli ungheresi negano loro i diritti nazionali più elementari, loro oppongono resistenza, di tanto in tanto si ribellano perfino, o perlomeno danno l’apparenza di ribellarsi, però festeggiano il compleanno del sovrano.»
«In questa Monarchia» rispose il conte Chojnicki che tra noi era il più anziano «niente è strano. Tolti gli idioti che ci governano» (amava le espressioni forti) «non ci sarebbe sicuramente niente di strano, neppure all’apparenza. Con questo voglio dire che per l’Impero austroungarico, quel che viene definito strano è l’ovvio. Con questo intendo anche dire che l’ovvio appare strano soltanto a questa pazza Europa degli stati nazionali e dei nazionalismi. Ovviamente a cantare Gott erhalte!1 sono gli sloveni, i galiziani polacchi e ruteni, gli ebrei di Boryslaw col loro caffettano, i mercanti di cavalli della Bacska, i musulmani di Sarajevo e i caldarrostai di Mostar. Ma gli studenti tedeschi di Brno e di Eger, i dentisti, i farmacisti, gli aiutanti parrucchieri, i fotografi di Linz, di Graz e di Knittelfeld e...