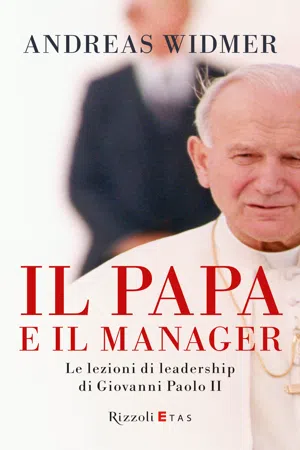![]()
1
Conosci te stesso
L’importanza della vocazione
Prima che io ti formassi nel grembo, ti ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal seno, ti ho santificato; profeta per le genti ti ho costituito.
Geremia 1:5
Qualunque cosa farete nella vita, qualunque chiamata sceglierete, ricordate che la vocazione fondamentale per ogni essere umano è di avere umanità. E dovete sempre realizzare tale vocazione fondamentale, io tengo fede sempre e dovunque alla mia vocazione nella misura in cui possiedo vera umanità (…) Solamente chi è sinceramente umano è veramente figlio di Dio.
Beato Giovanni Paolo II*
Quando entrai nelle guardie svizzere avevo vent’anni e, al pari dei miei compagni, ero in condizioni fisiche perfette; ma per quanto fossimo vigorosi e in piena forma, Giovanni Paolo II era ancora in grado di superarci di gran lunga.
Le sue attività iniziavano ogni mattina prima delle 6, quando si alzava, pregava, si vestiva e poi si recava nella sua cappella privata per un ulteriore momento di preghiera. Alle 7, piccoli gruppi di dignitari in visita, di pellegrini cattolici o di dipendenti del Vaticano si univano a lui per la messa. Dopo la messa, gli ospiti si univano a lui per la colazione, cui seguivano una o due ore di lavoro d’ufficio. Prima di accogliere i visitatori ufficiali, alle 11, aveva un breve incontro con i linguisti per rivedere i problemi principali delle diverse lingue che avrebbe usato con i visitatori o con i dignitari. Poi, iniziavano le udienze.
A volte parlava a migliaia di persone, a volte solo a poche; in ogni caso, tali udienze duravano fino all’una o alle due del pomeriggio; poi pranzava, di solito assieme a qualche membro dello staff del Vaticano. Finito il pranzo, si dedicava ancora alla preghiera, recandosi spesso nel giardino pensile del Palazzo Apostolico, per passeggiare e parlare con Dio.
Dopo la preghiera, altro lavoro d’ufficio e altre udienze, che si protraevano ininterrottamente fino all’ora di cena, alle 20, quando spesso gli ospiti cenavano con lui. Alla fine del pasto, il Papa si dedicava alla lettura, alla scrittura e ad altri lavori fino a notte inoltrata; nella sua camera, la luce si spegneva intorno a mezzanotte o anche più tardi. In qualche modo, in mezzo a tutte queste attività, trovava anche il tempo per chiedere a una guardia svizzera com’era andata la giornata, per chiacchierare con le suore addette alla cucina e per stare in contatto con i vecchi amici.
Ma questo era solo il suo programma quando si trovava a Roma. Rispetto al programma dei viaggi, era relativamente leggero. Giovanni Paolo II ha fatto lunghi e frequenti viaggi, più di qualunque altro Papa nella storia: 104 in 129 Paesi; in pratica, ha viaggiato per 1.250.000 chilometri, ovvero l’equivalente di 32 volte la circumnavigazione del globo.
Mentre mi preparavo a scrivere questo capitolo, cercai di ricordare le volte in cui vidi il Papa affaticato per tutti questi impegni. Non ci riuscii. Rammentai moltissime occasioni in cui io mi ero sentito esausto; mi ricordai di guardie che avevano viaggiato con lui e che al ritorno, con stupore e ammirazione, dicevano: “Non so come quell’uomo ce la faccia”. Non ricordo neppure una volta in cui l’abbia visto con gli occhi stanchi; in effetti, era esattamente l’opposto.
Quando tornava in Vaticano, dopo settimane in giro per il mondo, non andava direttamente nei suoi appartamenti per riposarsi, come avrebbe fatto chiunque altro; al contrario, si fermava a salutare tutto il personale che si era riunito per dargli il bentornato a casa. Come un generale che passa in rassegna le sue truppe, ci “ispezionava”, le guardie allineate in formazione d’onore, parlandoci e stringendoci la mano. Avrebbe avuto tutto il diritto e ogni ragione di non prestarci attenzione e di tornare alla calma e alla quiete delle sue stanze, ma sapeva che era suo sacro dovere fare dono a noi di tutto se stesso, come aveva fatto con le folle che lo avevano accolto nei Paesi stranieri.
Giorno dopo giorno, Giovanni Paolo II si donava agli altri per ottemperare a ciò che Dio esigeva da lui. E lo poteva fare, gioiosamente e inesauribilmente, perché sapeva ciò a cui Dio l’aveva chiamato. Conosceva la propria vocazione.
I TRE LIVELLI DELLE VOCAZIONI
Il significato del termine “vocazione” è molto più profondo della normale definizione che ne danno i dizionari come “percorso di carriera o progressione nel lavoro”; è più una “chiamata” che un “mestiere”. Se doveste riassumere in una sola frase la visione cattolica riguardo alla parola “vocazione”, potreste dire che la vocazione di una persona è la sua missione nella vita. È lo scopo per cui Dio vi ha creati.
Potreste anche dire che è ciò che fate per il Signore. Dio vi ha dato la vita e ora, per mezzo della vocazione, gliela rendete.
In qualunque modo la consideriate, la vocazione dà un senso alla vostra esistenza. Secondo Giovanni Paolo II, la vocazione risponde alla domanda: “Perché sono vivo?”; inoltre, lui credeva fermamente che solo quando si vive in pieno la propria vocazione si può trovare appagamento nella vita terrena. La vocazione – compresa, abbracciata e vissuta – è ciò che vi fa sentire veramente e pienamente vivi.3
La vocazione universale
Qui sopra ho dato una semplice spiegazione di vocazione, ma il concetto è molto più complesso. Infatti, vi sono tre diversi livelli, che si focalizzano su differenti aspetti della vita e che differiscono per importanza.
Il primo di questi tre livelli è la vocazione universale, quella che noi tutti condividiamo. Indipendentemente da chi siate o dove – o quando – viviate, avete la medesima vocazione universale di ogni altro essere umano: conoscere, amare e servire Dio in questa vita in modo tale che possiate conoscerlo, amarlo e servirlo eternamente nell’altra. Il vostro obiettivo è ricevere la grazia ora per potervi poi guadagnare il paradiso, ovvero, detto in parole più semplici, collaborare con Dio nella sua opera intesa a salvare la vostra anima.
Dio chiama tutti noi a partecipare con Lui alla sua creazione e ci assegna il compito di dare la vita agli altri: vita fisica o spirituale. Ci incarica di dare vita alle idee: creare opere d’arte, congegni e prodotti, o sistemi di pensiero e servizi. Giovanni Paolo II credeva fermamente che tale partecipazione alla creazione sia l’essenza dell’amore, la realizzazione più piena delle possibilità insite nell’uomo. Lui descrisse la nostra capacità di dare la vita – di far nascere un essere umano, di inventare, di creare, di immaginare e di costruire – come la vera grandezza dell’amore. Quando creiamo, facciamo ciò per cui Dio ci ha creati; portiamo avanti la nostra missione e facciamo dono a Dio della nostra vita.4
La vocazione primaria
Dopo la vocazione universale, la questione si fa più specifica. Dopo tutto, una cosa è dire che tutti i cristiani condividono la vocazione all’amore, un’altra cosa è vivere effettivamente tale vocazione. La maniera in cui la viviamo, lo stile di vita secondo il quale amiamo e serviamo Dio e il nostro prossimo, è la nostra vocazione primaria. Secondo la Chiesa cattolica, ci sono quattro vocazioni primarie: la vita matrimoniale, il celibato impegnato (vivere nel mondo), il sacerdozio e la vita consacrata (vivere in comunità religiose).
Ciascuna di tali vocazioni è uno stile di vita permanente e basato sulla libera scelta. Ciascuna di esse implica il fare dono di sé. Nello scegliere una vocazione primaria, cedete a qualcun altro la proprietà inalienabile e non trasferibile del vostro “io”. In altre parole, nella vostra vita date la priorità a Dio e alla vita consacrata o al vostro sposo/alla vostra sposa e alla famiglia.
Questo dono di sé imprime nella vostra vita una direzione e uno scopo concreti; stabilisce un certo ordine fra desideri, priorità e responsabilità, almeno in linea generale. Se sono sposato e ho un figlio, sono responsabile non solo verso me stesso, ma anche verso la mia sposa e mio figlio; sono tenuto a provvedere non solo ai loro bisogni fisici e materiali, ma anche a quelli intellettuali, emotivi e spirituali. La cura della loro anima, come del loro corpo, è affidata a me; è “compito” mio aiutarli ad andare in paradiso, proprio come è “compito” loro aiutarmi a fare altrettanto. Le scelte che faccio, le azioni che compio e le responsabilità che mi assumo sono tutte decisioni che devono essere prese alla luce delle mie responsabilità verso di loro.
Lo stesso vale per quanto riguarda i sacerdoti e coloro che conducono una vita religiosa. Le suore pensano al bene della loro comunità prima che al proprio; la loro via verso il paradiso è lastricata con le regole e i doveri della loro vita con le altre suore. I sacerdoti sono parimenti incaricati di provvedere al benessere spirituale dei loro parrocchiani e di aiutare il loro vescovo nell’insegnamento e nella difesa della fede; il loro stile di vita e l’impiego del loro tempo devono essere indirizzati a tali finalità di più ampia portata.
Le nostre moderne idee di libertà ci possono confondere circa il valore di questo tipo di vocazione. Molto spesso, consideriamo le limitazioni alla nostra libertà dovute a un impegno permanente come ostacoli all’“espressione del nostro essere”. Ma la vera libertà non è libertà dai vincoli esterni; la vera libertà è la libertà di amare e dare pienamente noi stessi. La libertà, in effetti, esiste in quanto esiste l’amore; è il mezzo per conseguire il fine che tutti noi desideriamo: la comunione amorosa con Dio e con gli altri. È nel momento in cui ci doniamo senza alcuna riserva che ci realizziamo più compiutamente; è in quel momento che siamo veramente liberi.5
La vocazione secondaria
La vocazione universale stabilisce la finalità generale della vostra vita, il vostro scopo ultimo. La vocazione primaria vi assegna un quadro di riferimento entro il quale conseguire quello scopo. Imposta determinati parametri o, per esprimerci in maniera un po’ differente, stabilisce un percorso che dovete seguire nel vostro viaggio verso il paradiso. Il terzo livello della vocazione – la vostra vocazione secondaria – è ciò che fate lungo quel percorso. È il modo in cui, mentre seguite le vocazioni universale e primaria, usate le vostre doti e i vostri talenti al servizio di Dio e del vostro prossimo. Per la maggior parte di noi, ciò si riferisce al nostro lavoro o alla nostra professione; tuttavia può riferirsi anche al nostro impegno nella società e nella comunità, all’opera di apostolato, o semplicemente al fatto di sopportare le croci e le tribolazioni che si presentano durante il nostro cammino. È il piano d’azione secondo il quale condurre la nostra esistenza.
Per quanto riguarda il lavoro, Giovanni Paolo II riteneva che la nostra professione fosse parte integrante di ciò che siamo in quanto esseri umani. Lo affermò nei riguardi non solo di professioni apparentemente esaltanti e importanti – come quella di fare il Papa – ma anche delle forme più dure di lavoro manuale. Riferendosi a quest’ultimo, il Santo Padre sapeva di cosa parlava. Infatti, negli anni giovanili in Polonia durante la Seconda guerra mondiale, il futuro Papa lavorò a lungo in una cava di pietra e in uno stabilimento chimico; in seguito a tali esperienze, quindi, sapeva bene quanto il lavoro possa essere duro e impegnativo.
Ma sapeva anche cosa succede quando un uomo perde il lavoro, oppure quando non è libero di cercare l’occupazione per la quale Dio l’ha creato; lo apprese come seminarista, sacerdote e vescovo nella Polonia assoggettata al potere sovietico, dove la pianificazione economica centralizzata portò alla soppressione della proprietà privata e dell’attività imprenditoriale.
Giovanni Paolo II fu testimone della mutilazione della libertà, della denigrazione dei lavoratori, della violazione della dignità umana. Si rese conto che per diventare le persone che Dio ci ha destinati a essere, ciascuno di noi deve essere libero di scegliere, di creare, e persino di fallire nella propria vita professionale. Il Papa sosteneva che quando ci comportiamo così, quando andiamo liberamente alla ricerca del lavoro per il quale siamo stati creati e delle doti, dei talenti, della natura e delle circostanze che si adattano a noi, allora scopriamo chi siamo veramente.6
Egli si rese pure conto che mediante il nostro lavoro non ci limitiamo semplicemente a fare qualcosa di più, ma ci sviluppiamo, cresciamo. Il lavoro ci plasma, ci perfeziona e ci spinge a scoprire e affinare le nostre doti naturali; ci mette in grado di amare, di diventare un mezzo attraverso il quale possiamo servire la nostra famiglia, i clienti, il nostro prossimo e le comunità. Così il lavoro diviene un mezzo per offrire la nostra vita a Dio.
Se lo vedete sotto questa luce, vi accorgerete che anche il lavoro, come la vocazione primaria, non rappresenta un vincolo per la vostra libertà. Non è qualcosa che vi impedisce di fare ciò che realmente vi piace: andare a pesca, cucinare o controllare i risultati della vostra squadra preferita; è qualcosa che vi dà la capacità di vivere con maggiore pienezza la vita che Dio desidera che viviate.
Il fatto che talvolta il lavoro sia difficile, monotono o penoso non sminuisce il valore dell’impegno richiesto, anzi, lo accentua. Tutta la difficoltà, la monotonia e la pena cui andate incontro sono cose che potete unire all’opera, alla Passione e alla morte di Cristo; sono qualcosa che potete – per citare quanto ribadito dalle madri cattoliche nel corso dei secoli – “offrire in sacrificio al Signore” al fine di ottenere la grazia per voi stessi e per il vostro prossimo.
Tale capacità è qualcosa di santo, e il lavoro, infatti, può essere un fattore di santità. Ogni lavoro, non solo quello dei sacerdoti e dei religiosi, può essere fonte di santità se svolto come atto d’amore, con spirito di servizio e di sacrificio in conformità con le intenzioni di Dio. È ciò che fu reso possibile dall’Incarnazione, ed è la ragione per cui san Tommaso d’Aquino poté affermare con tanta sicurezza che “Non ci può essere gioia nella vita senza gioia nel lavoro”.
IL DISORDINE PROVOCATO DA PRIORITÀ CONFLITTUALI
Dunque, per quale motivo è importante la questione delle vocazioni? Che cosa ha a che fare con la guida di un’azienda, grande o piccola che sia?
La risposta è: “Tutto”.
Quel che Giovanni Paolo II comprese così bene – la sua vocazione universale (la sua chiamata alla santità), quella primaria (il suo sacerdozio) e quella secondaria (il suo essere sacerdote, poi vescovo e infine Papa) – è proprio ciò per la cui comprensione la maggior parte di noi impiega l’intera esistenza. Vogliamo sapere chi siamo, perché esistiamo e per quale scopo siamo stati creati; sono le eterne domande che si è posto ogni essere umano, in ogni epoca. Rispondere non è mai facile, e le esigenze della vita – i diversi ruoli, anche in conflitto fra loro, che giochiamo e le priorità fra le quali ci destreggiamo – rendono quelle risposte ancora più difficili.
In questa vita, tutti noi – non importa se si è il Papa, che guida milioni di persone, o un capo azienda, che ne guida centinaia, o un padre di famiglia, che ne guida solo alcune – svolgiamo più di una funzione. Potete essere datore di lavoro o dipendente, ma siete anche figlio o figlia, fratello o sorella, marito o moglie, madre o padre, leader di una comunità o volontario, cittadino o soldato, vicino di casa o amico; e l’elenco non finisce qui. Tutti questi diversi ruoli vi danno molteplici possibilità di servire gli altri e di mettere a frutto le vostre doti, ma fanno anche sorgere una molteplicità di obiettivi e di aspettative che spesso sono in conflitto fra loro.
Tanto per cominciare, vi tirano in direzioni opposte, in quanto ciascuna, oltre a esigere tempo da sottrarre alle altre, sembra richiedere virtù e qualità opposte. Quel che ci vuole per avere successo nel business può sembrare tutt’altra cosa rispetto a quello che è necessario per essere un buon padre o un buon discepolo cristiano. Ciascun ruolo ha in sé una “cultura di priorità” conflittuale con le al...