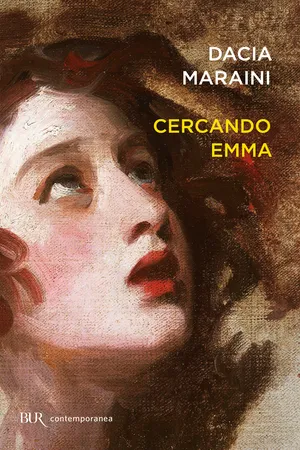![]()
Emma Bovary è una di quelle persone «di casa» nella nostra città interiore, ci sembra di conoscerla da tanto, la sua storia ci è familiare.
Per anni abbiamo sentito dire che Emma è la creatura più amata da Flaubert, tanto da spingerlo a identificarsi pubblicamente con lei: «Madame Bovary c’est moi». Abbiamo sentito dire che l’adulterio di Emma viene annunciato, spiato, seguito dal suo autore con profonda comprensione, quasi che il romanzo fosse una giustificazione della libertà d’amore femminile all’ interno delle strettoie del matrimonio borghese, in un ambiente saturo di banalità e di luoghi comuni.
Eppure nel mio ricordo - quando ho letto il romanzo per la prima volta, con l’avidità dell’adolescenza, avevo sedici anni - conservo un sentimento di sconcerto e di malessere. Ma non per la scabrosità del tema e neanche per la orribile punizione finale, che pure mi ha lasciata senza fiato, ma per il modo dileggiante e rabbioso con cui mi veniva fatta conoscere questa donna.
Allora non capivo che si tratta di una questione di prospettiva. Da lettrice inesperta mi ero immersa nelle acque tetre, bellissime del romanzo e non distinguevo, non capivo da dove mi venivano i colpi. Ma erano colpi severi per chi, come me, desiderava capire e simpatizzare con il personaggio.
Emma si presentava come una figura tragica, la vittima di un matrimonio soffocante, tenuta in ostaggio da un marito vile e inetto.
Oggi, ripercorrendo il libro, Emma mi appare sì un ostaggio, ma non del marito, bensì del suo autore che la incalza con un accanimento e una tenacia che sfiorano il grottesco, attraverso una determinazione amara e sbeffeggiante.
«La cosa di cui ci lamentiamo» scrive Henry James, nel saggio D’Annunzio e Flaubert, «è che Emma Bovary, nonostante la natura della sua coscienza e sebbene essa rifletta tanto quella del suo creatore, sia veramente qualcuno di troppo limitato.» E si chiede, accorato, «perché Flaubert scelse, come speciali veicoli della vita che si proponeva di dipingere, degli esemplari umani così inferiori».
È la domanda che mi sono fatta anche io alla prima lettura e che continuo a farmi oggi ed è la ragione per cui ho sentito il bisogno di scrivere queste pagine, cercando di saperne di più. Non solo del rapporto Flaubert-Emma, ma di quello in generale degli autori con i loro personaggi.
Poiché le lettrici sono più dei lettori, poiché queste lettrici amano identificarsi con i personaggi femminili dei romanzi, succede a volte che si ingegnino a trovare, nelle eroine dei libri, qualità che in realtà esse non hanno.
La tenacia delle lettrici è senza limiti, quasi quanto il loro entusiasmo creativo. Esse scavano nei libri come talpe sapienti e cercano di forgiare il personaggio a modo loro, secondo le loro più profonde esigenze, senza curarsi, poi, di controllare che le qualità attribuite al personaggio dei loro desideri, corrispondano davvero al carattere della protagonista.
È successo così che Emma Bovary, regina di un romanzo straordinario per le sue qualità visionarie e per i dettagli realistici, sia stata assunta dalle lettrici come una «portatrice di bandiera», quasi una pilotessa che, in barba alle pidocchierie del matrimonio borghese, si prenda delle «sacrosante» libertà.
Poche si curano di andare a guardare più da vicino il personaggio e come l’autore lo giudichi, momento per momento, disegnando minuziosamente il suo carattere. Le lettrici sono disposte a ogni trasformazione pur di prendere possesso di una merce così rara in letteratura: un carattere femminile forte, con una sua visibile volontà d’azione.
Anch’io, da lettrice ingorda e ingenua, alla prima lettura ho visto in Madame Bovary un personaggio di donna coraggiosa e appassionata a cui mi piaceva accompagnarmi nelle mie passeggiate mentali, come ci si accompagna con una donna dai pensieri decisi, dai piedi forti e leggeri.
Solo anni dopo, rileggendo il bellissimo e sensuale romanzo di Flaubert, mi sono resa conto di quanto sia malvoluta Emma Bovary, di quante miserie la carichi il suo autore, tanto da non poterle trovare neanche una qualità, una sola.
![]()
Il romanzo comincia in modo splendente con la scena, che tutti ricordiamo, del nuovo studente che arriva alla scuola di campagna. Si chiama Charles Bovary ma non sa neanche pronunciare chiaramente il suo nome, che viene storpiato in «Charbovari». È goffo, pesante, impacciato e si muove con lentezza. Al solo suo apparire la scolaresca scoppia a ridere. Tanto che il professore gli fa scrivere venti volte, sul foglio del quaderno: ridiculus sum.
Eppure in questo inizio stesso c’è qualcosa che ci inquieta, ci lascia dubbiosi. L’anomalia consiste nella presentazione di una voce narrante, un io in carne e ossa che poi si perderà misteriosamente senza che si sappia perché.
È strano che un autore così accurato come Flaubert non se ne sia accorto. A meno che questa svista non rappresenti un segno clandestino per aprire una qualche porta segreta del romanzo.
Il primo capitolo inizia così: «Stavamo studiando quando entrò il preside», frase che implica la scelta di un preciso punto di vista: un testimone, un ricordo, qualcuno che ci racconta di un suo compagno di scuola poi finito medico a Yonville, eccetera.
Ma questo io narrante lo perdiamo già alla fine del primo capitolo. Si tratta di una perdita volontaria, di un capriccio, di una dimenticanza, di un lapsus?
Vista la pignoleria quasi maniacale dello scrittore, direi che si tratta piuttosto di una spia messa lì a indicarci uno stato di incertezza prospettica che accompagnerà tutto il libro. Che il lettore si confonda pure, il romanzo è tutto impastato di questa incertezza di punti di vista che ne costituiscono la sottile originalità.
Solo così si può spiegare il «Madame Bovary sono io». La scrittura flaubertiana in questo libro ha la consistenza di uno specchio finto, che, se da una parte ci rimanda l’immagine di una giovane e bella donna dai capelli neri divisi in due bande, dall’altra ci fa intuire che dietro lo specchio c’è un altro corpo ben più robusto e virile, che prova piacere a denigrarsi attraverso i tratti delicati di una donna inquieta e velleitaria. «Egli non può che sognare di essere l’altro» scrive Sartre nell’Idiota di famiglia, «e recitare per la propria soddisfazione il ruolo dell’uomo d’azione.»
Il libro, certo, può essere letto in vari modi, sia come il ritratto impietoso, analitico e realistico di una adultera della provincia francese del secolo scorso, sia come la presa in giro di una mistificazione culturale, sia come la critica di un carattere velleitario, sia come una anatomia del linguaggio comune, sia come il ritratto nervoso e naturalistico di una cittadina di provincia con i suoi ridicoli e meschini personaggi, sia perfino come un romanzo sull’amara risibilità del nulla: «Quello che mi sembra bello, quello che vorrei fare è un libro sul niente» scrive Flaubert a Louise Colet il 16 gennaio 1852.
I vari piani di lettura compresi nel testo sono tutti legittimi. Salvo poi scoprire quei piccoli segnali di malessere che ne fanno un libro perfettamente ambiguo e perfettamente splendido.
Proverò qui a raccogliere i sassolini lasciati cadere da Emma sulla strada del bosco, per vedere se ci portano verso la casa del desiderio impossibile o verso qualcosa di più oscuro e imprevisto.
![]()
La prima volta che la incontriamo, Emma è ancora una ragazza priva di esperienza, che vive nella casa del padre, in una fattoria di campagna.
Quando Charles Bovary alza gli occhi su di lei, Emma sta ritta in piedi sulla soglia di casa con un sorriso gentile sulle labbra e indossa un vestito di «meriinos azzurro guarnito di tre balze».
L’azzurro, il cilestrino, il blu accompagnano spesso le descrizioni della bellezza di Emma. Sebbene i suoi occhi siano neri, come precisa Flaubert quasi con rammarico, qualcosa di celeste l’avvolge sempre come un alone di spiritualità. Ma impareremo presto che di celestiale, in Emma, non c’è assolutamente niente. Il turchino sta li a rivelarci qualcosa che riguarda la sua ambigua avvenenza, la sua abbagliante sensualità.
Il giovane dottore Charles Bovary si è laureato da poco, non senza difficoltà per la sua pigrizia che l’ha portato a trascinare gli studi per anni dimenticando di dare gli esami. Sarà la madre, infine, a costringerlo a prendere la laurea trovandogli, in seguito, sia un posto di medico condotto a Tostes, sia una moglie anzianotta con una buona dote: la vedova Madame Dubuc dalle braccia scheletriche, i piedi freddi e la pelle «ingemmata come la primavera».
Il dottore è stato buttato giù dal letto, quella mattina, da una lettera sigillata con ceralacca azzurra (un annuncio del colore che avvolgerà i suoi sensi per il resto della vita?) che lo chiama alla fattoria Bertaux per aggiustare la gamba rotta del signor Rouault.
«La frattura era semplice, senza complicazioni» spiega Flaubert che mette subito in dubbio le capacità mediche del giovane Bovary. Ma quest’ultimo, preso da un fervore neofita, dà subito ordini perché gli procurino le bende e le stecche per ingabbiare la gamba di père Rouault. La serva viene mandata a cercare dei pezzi di legno nella stalla; a Emma viene chiesto di cucire dei cuscinetti da introdurre fra la pelle e le stecche.
Ancora non ci è stata descritta fisicamente, la giovane Emma, salvo quell’accenno all’abito azzurro di lana merinos, che Flaubert ci dà una indicazione sul suo carattere: il padre, vedendola indugiare nella ricerca dell’astuccio degli aghi, si spazientisce e la rimprovera con sbrigativa impazienza. Emma, per quanto il rimprovero sia ingiusto, non risponde. Si mette rapida a cucire e nella fretta si punge le dita che «porta alla bocca per succhiarne il sangue».
Proprio come la bella addormentata nel bosco, a cui la fata cattiva aveva annunciato che si sarebbe punta e sarebbe caduta in un sonno mortale dal quale si sarebbe risvegliata, aveva aggiunto la fata buona, quando un principe azzurro l’avesse baciata. Ecco, possiamo immaginare che Emma entri, con quella puntura, nel letargo del matrimonio, finché non verrà svegliata dal bacio dell’adulterio.
L’autore ci tiene a presentarcela, all’inizio della storia, come soffusa di azzurro e remissiva. Ma presto scopriremo che quella remissività e quell’amore filiale sono solo tecniche di una rappresentazione teatrale, poiché Emma, lo sapremo in seguito, ama recitare. Non conosce la sincerità e neanche lo spirito critico. E ama anche cambiare rappresentazione altrimenti si annoia.
La prima recita che Emma offre ai lettori è proprio quella della giovane ragazza da marito, pudica e ingenua, brava e obbediente, figlia di un padre bonario e burbero. A questo punto ancora, forse, non sa di recitare. Lo fa d’istinto, come d’istinto modula la voce che «a seconda di quello che diceva poteva diventare chiara o acuta o, coprendosi improvvisamente di languore, trascinava delle modulazioni che finivano quasi in un mormorio quando parlava a se stessa».
L’altra cosa che colpisce lo sguardo di Charles, dopo l’azzurro del vestito, è la bianchezza delle unghie di Emma: «Erano brillanti, fini in cima, più lisce dell’avorio di Dieppe e tagliate a mandorla».
Eppure, precisa l’autore, non si possono dire delle mani proprio belle, perché «non sono abbastanza pallide e perché sono un poco secche sulle falangi e anche troppo lunghe e prive di quelle molli sinuosità delle linee sui contorni».
Invece gli occhi vengono giudicati belli, senza riserve, «per quanto fossero bruni sembravano del tutto neri per il gioco delle ciglia». E quegli occhi si rivolgevano verso il dottore appena conosciuto, con un «candido ardimento».
Uno sguardo attento e non privo di senso critico quello di Charles, un senso critico che gli si affievolirà man mano fino a scomparire del tutto nel corso del matrimonio.
Il signor Rouault invita il medico a «prendere un boccone» con loro prima di tornarsene a Tostes. E così scendono tutti e tre nella sala da pranzo al piano rialzato. «Si sentiva un odore di iris e di panni umidi» nella sala ingombra di sacchi di grano. Sola nota curiosa: una testa di Minerva disegnata con il carboncino, sotto cui spicca, in caratteri gotici, la scritta «al mio caro papà».
Così ci vengono segnalati due dati che contraddicono la prima impressione di remissività e di autocontrollo della signorina Emma Rouault: gli occhi che guardano con «candido ardimento» e la testa di Minerva che, per quanto dedicata umilmente al padre, indica una scelta tutt’altro che arrendevole, quasi un intento bellicoso: Minerva è una dea armata.
Veniamo intanto informati che «mademoiselle Rouault non si divertiva affatto in campagna» dal padre, soprattutto ora che, in seguito alla morte della madre, «aveva dovuto caricarsi quasi da sola tutto il peso della conduzione della fattoria».
Il padre d’altronde non la considerava indispensabile, anzi trovava «che sua figlia aveva troppo spirito per la coltura dei campi, un mestiere maledetto dal cielo, infatti, chi ha mai visto dei milionari in campagna! ».
Sia lui che Charles Bovary guardano alla ragazza come a un fiore troppo prezioso (quella pelle bianchissima, quelle mani delicate, quei piedini da parigina, quei vestiti azzurri e ben agghindati) per essere lasciato a languire in una fattoria, fra vacche e pecore.
«Il collo usciva da un colletto bianco col risvolto. I capelli, di cui le due bande nere sembravano ciascuna fatta di un solo pezzo tanto erano lisce, erano separate al centro da una scriminatura fine che si infossava leggermente secondo la curva del cranio e, lasciando scorgere la punta dell’orecchio, andavano a racchiudersi sulla nuca in una crocchia abbondante, accompagnata da piccole onde dirette verso le tempie che il medico di campagna notò per la prima volta nella sua vita. Gli zigomi erano rosei. Ed ella portava, come un uomo, trattenuto da due bottoni del corsetto, un occhialetto di tartaruga.»
Altro segno che contraddice la visione iniziale. Che ci fa quell’occhialetto da uomo sul vestito tanto femminile (di merinos azzurro, a tre balze) di Emma Rouault? Non sta a dirci che Emma nasconde, o rivela solo in parte, qualcosa di diverso da quello che vorrebbe apparire? Qualcosa che prende significato solo per l’occhio acuto dell’osservatore attraverso i piccoli segni di una personalità contraddittoria?
![]()
«La tua immagine resterà in me tutta imbevuta di poesia e di tenerezza come era ieri notte nel vapore lattiginoso della nebbia argentata.» (6 o 7 agosto 1846)
«Ah le nostre due belle passeggiate in carrozza, che meraviglia! La seconda soprattutto con i suoi lampi. Rammento il colore degli alberi illuminati dalle lanterne, e il dondolio delle molle; eravamo soli, felici, contemplavo la tua testa nella notte e la vedevo nonostante il buio perché i tuoi occhi ti rischiaravano tutta la faccia.» (4-5 agosto 1846)
Questi sono brani di lettere che Gustave Flaubert ha scritto a Louise Colet poco dopo averla incontrata in casa dello scultore Pradier in uno dei suoi rari soggiorni a Parigi, cinque anni prima di mettersi a scrivere Madame Bovary.
Perché li cito? perché leggendo l’epistolario di Flaubert - quest’uomo così avaro con i libri era estremamente prodigo nelle lettere che scriveva di getto, con uno stile fluido e disteso, scintillante di ironia e di intelligenza - non ho potuto fare a meno di riconoscere Emma in Louise e Louise in Emma.
Il romanzo, come hanno detto e ripetuto i suoi amici, si è ispirato (anzi, è stato proposto come tema d’ispirazione dopo che i suoi amici avevano decretato il fallimento del suo Le tentazioni di sant’Antonio) a un famoso fatto di cronaca di quegli anni: il caso Delamare.
Una donna, Delphine Couturier Delamare, si uccide travolta dai debiti e il marito viene a sapere da alcune lettere nascoste che ha avuto degli amanti. Il marito, Eugène Delamare, era un ufficiale sanitario.
Certamente la storia è quella. Ma quando si è trattato di dare un corpo, un carattere al personaggio di Emma, non possiamo non pensare che sia stato più naturale per Flaubert modellarlo su qualcuno che gli fosse più vicino e conosciuto.
Inoltre il romanzo porta le tracce dei sentimenti che hanno caratterizzato la storia di questa «passione» prima impetuosa, violenta, dolente, poi man mano più spinosa, artefatta, impaurita, con incontri sempre più rallentati e sporadici, fino all’intolleranza e all’odio finale.
Emma la ritroviamo nelle lettere di Gustave a Louise, perfettamente disegnata, riconoscibile nelle sue contraddizioni esplosive: da una parte molto femminile nelle sue seduzioni dolci e morbide, nelle sue tenerezze e generosità, nei suoi disamori di sé e nell’attaccamento morboso all’essere amato; dall’altra un poco maschile nelle sue più ardite asserzioni di sé, nella sua smania di indipendenza, nel suo spirito bellicoso, nelle sue aggressività a faccia scoperta.
Allo stesso tempo troviamo in Emma molti caratteri di Louise che, a loro volta, anche se negati e di straforo, appartengono allo stesso autore: certe adolescenziali predilezioni per l’esotismo, una infantile tendenza al feticismo, la capacità di perdersi nei sogni, la spavalderia teatrale, la pigrizia dei sensi, l’amore per le menzogne come fuga, il gusto per le «chincaglierie» che a volte fanno deviare il senso artistico.
Ci sembra di capire meglio Emma conoscendo Louise e di capire meglio Flaubert conoscendo le sue lettere che sono straordinarie nella loro vitalità, profondità, allegria e sincerità.
Il mondo epistolare di Flaubert è popolato, in realtà, soprattutto da figure maschili; alcuni compagni di scuola con cui continua a corrispondere per tutta la vita. Fra questi, Ernest Chevalier con cui fu intimo fino al matrimonio, che Flaubert consid...