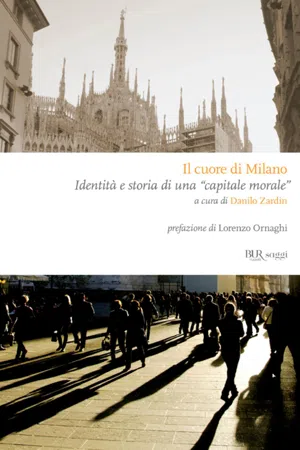![]()
Ruolo guida e leadership mancata.
Milano nella storia della nazione unita
di Alessandro Colombo
Milano è forse la città che per prima ha sentito la vocazione nazionale dell’Italia. Certamente essa ha partecipato con convinzione e intraprendenza alla costruzione della nazione; prima, durante e dopo il Risorgimento. La storia di Milano degli ultimi due secoli è, per molti versi, la storia d’Italia.
Eppure mai Milano è riuscita ad assumere un ruolo di leadership politica nazionale. Sulla storia della città grava il destino paradossale di avere spesso anticipato e avviato i cambiamenti politici e istituzionali, ma sempre consegnato ad altri i risultati di tali innovazioni.
Questo ruolo mancato, tuttavia, non ha mai frustrato l’impegno delle sue classi dirigenti per lo sviluppo (non solo economico) del Paese.
La rapida rassegna di fatti che segue intende raccontare questa storia dalla stagione francese fino ai giorni nostri, nei quali – forse – una nuova stagione si apre.
L’eredità francese. Dalla rivoluzione all’Impero
Napoleone conduce Milano lungo la medesima, contraddittoria, parabola della Rivoluzione francese, che nasce borghese, ma traghetta all’Impero.
Egli aggiunge la Lombardia austriaca, la porzione di Veneto tra Adda e Mincio e la Valtellina alla Repubblica Cispadana. Così, al Lazzaretto, il 9 luglio del 1797, si inaugura quell’embrione di Stato italiano che prende il nome di «Repubblica Cisalpina». Milano risponde con grande entusiasmo, che tuttavia si affievolisce presto a causa del malgoverno francese, fino a scomparire del tutto quando Bonaparte conclude la guerra con l’Austria rinunciando a Venezia. Così, quando gli austriaci riprendono Milano nella primavera del 1799 sono accolti come liberatori. Anche questo entusiasmo dura poco, perché i nuovi padroni non si comportano meglio dei francesi.
La breve parentesi di ritorno degli austriaci è interrotta con il colpo di Stato di novembre, quando Napoleone si reimpossessa della Francia e di Milano. È lui ora, a essere accolto come liberatore. E risponde con un discorso programmatico che adatta la rivoluzione alle tradizioni meneghine: «La Repubblica sarà riordinata sulle basi irremovibili della religione, libertà, uguaglianza, ordine». Al seguito del generale c’è Stendhal, innamorato di una città che egli descrive con parole che poco hanno a che fare con la frenetica metropoli odierna: «L’amore folle per l’allegria, la musica e i costumi molti liberi, l’arte di godere la vita con tranquillità […] tutto questo è il carattere del milanese».
Il 16 gennaio 1802 nasce la Repubblica italiana presieduta da Bonaparte. Una Repubblica di nobili, con vicepresidente il conte Francesco Melzi d’Eril che aveva omaggiato Napoleone a Lodi ai tempi della sua prima discesa; alle Finanze c’è Giuseppe Prina, il più longevo, potente, e odiato dai milanesi.
La Repubblica nasce per liberare i cittadini e ridistribuire il potere strappandolo dalle mani dell’aristocrazia. In poco tempo, tuttavia, essa finisce nella celebrazione dell’Impero e nella restaurazione dei princìpi monarchici. Spariscono da Milano gli alberi della libertà e il titolo di «cittadino»; il Senato francese stabilisce che la Repubblica ha bisogno di un imperatore ereditario. In un solo anno la «Repubblica d’Italia» diventa il «Regno d’Italia» e Napoleone è incoronato con la corona longobarda nel Duomo di Milano: «Dio me l’ha data e guai a chi me la tocca!». Perfino Dio ricompare a legittimare il potere.
Una vocazione politica e nazionale
Negli anni successivi, Milano diventa più bella, pur non attraversando un momento di floridezza. Si pavimentano le strade
e viene ultimata la facciata del Duomo, ma si perdono uomini e
industrie, sacrificati alla causa di una Francia impegnata a conquistare l’Europa. Dei 27.000 soldati del Regno d’Italia partiti per la Russia, solo mille tornano a casa. Così, mentre Napoleone si prepara alla disfatta di Lipsia, a Milano c’è chi comincia a simpatizzare con la causa dei nemici dell’imperatore. Federico Confalonieri fonda il «movimento degli Italici puri», ostile ai francesi.
Il 6 aprile del 1814 Napoleone abdica e il 20 aprile la folla saccheggia la casa del ministro Prina, linciandolo. È uno dei gesti incivili di cui anche Milano è stata e sarà capace. Annibale Sommariva, commissario austriaco, prende il controllo; il 28 torna in città l’esercito austriaco. Milano festeggia ancora un nuovo padrone e il generale Bellegarde annuncia il «felice destino» di tornare parte dell’Impero austriaco.
Felice destino probabilmente sì, anche se, con l’uscita dei francesi, si assopisce (ma non muore) la stagione di sentimento nazionale che ormai ha segnato la città. Con l’ingresso di Napoleone, con il suo esercito di leva nazionale, unitario, convinto, spesso eroico, i milanesi si erano trovati incoraggiati a un protagonismo politico che prima non avevano conosciuto. Milano era capitale di un regno, aveva una bandiera con cui si era scacciato l’invasore; tutto questo aveva dato ai milanesi il senso di una responsabilità politica e nazionale. Fu solo la tassazione centralista e ossessiva, il continuo drenaggio di risorse e uomini a fiaccare nobiltà, borghesia e popolazione meneghina. Ci si stancò delle guerre e delle loro vessazioni, non dell’orgoglio e del senso identitario che l’aria d’Oltralpe aveva portato. E Milano non sarebbe stata più quella di prima. Dopo l’esperienza francese, essa si sente parte della nazione; sa di poter giocare il ruolo di capitale politica.
Eppure, nei due secoli successivi, Milano non riuscirà nell’impresa. Sarà ancora in prima fila nelle rivendicazioni, nelle adesioni al Risorgimento, perfino nelle rivolte e nelle innovazioni istituzionali; ma non guadagnerà mai la leadership politica nel Paese.
La Restaurazione: il Lombardo-Veneto. Gli anni di quiete
Il Congresso di Vienna riporta indietro l’orologio politico di Milano, ora mera porzione del dominio asburgico. Tuttavia, con gli austriaci, si affaccia sulla scena una nuova classe dirigente borghese, rimasta prima esclusa.
Il buon governo asburgico garantisce anni di quiete, ridà respiro alle finanze pubbliche e all’organizzazione delle istituzioni e della società. Il prelievo fiscale è meno oneroso, più equo. L’Austria non è un padrone belligerante come la Francia: toglie molti dei prelievi fiscali che le guerre avevano imposto ai milanesi: il testatico e la tassa di registro, più altre imposte odiose ai milanesi quali quella sull’industria, sulle arti liberali e sui capitali. Nel giugno 1814 viene proclamata l’annessione all’Impero e nell’aprile del 1815 è istituito il Regno Lombardo-Veneto.
Al governo lombardo sono assegnate nove province: Milano, Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Como, Pavia, Lodi-Crema e Sondrio (con la Valtellina definitivamente incorporata). L’organizzazione amministrativa è capillare e complessa, ispirata a princìpi meno centralistici del sistema napoleonico, con maggiore autonomia per le istituzioni intermedie.
Milano vive un periodo di prosperità. È uno sviluppo al quale partecipano istituzioni civiche e classi dirigenti borghesi. Impressionante è la reazione alla terribile carestia del 1817. Si creano commissioni di ricchi che aiutano i poveri con lavoro, danaro e istruzione. Si esige la sovraimposta di un centesimo per ogni scudo di estimo fondiario sulla proprietà immobiliare. Il prelievo frutta un milione, messo a disposizione della Commissione centrale di beneficenza che, da allora, divenne da provvisoria a definitiva, preludio di quella che nel 1823 diverrà la «Cassa di Risparmio».
L’economia riprende quota e assume i caratteri solidi e imponenti che renderanno Milano motore economico. Lo sviluppo del tessile è sostenuto da una crescente domanda di seta dei mercati stranieri e dall’introduzione massiccia delle macchine a vapore. Le industrie chimica, metallurgica e meccanica si consolidano, così come l’artigianato del mobile.
Anche la città si rinnova: nascono l’attuale corso Vittorio Emanuele (Corsia dei Servi), via Manzoni (allora via Giardino) e Monte Napoleone.
Intanto prosegue l’opera di infrastrutturazione già avviata da Napoleone. Riguarda soprattutto strade e canali. Le ferrovie restano sempre un po’ indietro, ma nel 1840 si inaugura la Milano-Monza e nel 1841 compaiono i primi omnibus. Dal 1845 viene introdotta l’illuminazione a gas in città.
Il risveglio sociale
Il buon governo, però, va presto un po’ stretto alla società milanese che si sta risvegliando. È una trasformazione spinta dal ceto medio che, all’aumentare delle proprie disponibilità economiche, fa seguire attivismo culturale e civico. Sono gli anni dei salotti e di una ripresa culturale originale e diffusa. Nel 1816 Berchet pubblica la Lettera semiseria all’amico Crisostomo, che diverrà manifesto del Romanticismo italiano. Il 3 settembre 1818 nasce «Il Conciliatore», giornale della borghesia liberale. Nella dialettica tra cultura milanese e reazione austriaca si polarizza anche la dicotomia tra «romantico» (emblema di liberale) e «classicista» (che invece indica l’austriacante reazionario). È un movimento intellettuale, certo, ma molto esteso. Su una città di 200.000 abitanti, si contano 40 tipografie e 200 torchi. Nella «Società del Giardino» si svolgono feste magnifiche, inaugurando quel club della borghesia meneghina ancora oggi di moda.
Intorno al movimento liberale si raduna la Carboneria, fatta di nomi famosi: Silvio Pellico, Federico Confalonieri, Pietro Borsieri, Pietro Maroncelli, Adeodato Ressi, tutti saranno arrestati e renderanno famoso anche lo Spielberg.
Le persecuzioni non fiaccano il liberalismo romantico. Fenomeno più ampio della Carboneria, esso investe letteratura e politica, con un’unità tra pensiero e azione, tra sapere, sviluppo tecnico e progresso di libertà, che rimarrà la cifra della cultura milanese. I nomi noti sono quelli di Tommaso Grossi, Massimo d’Azeglio e Cesare Cantù.
È la Milano di Carlo Porta, del Teatro alla Scala nel quale debuttano Rossini e, più tardi, Verdi. L’Istituto Lombardo di Scienze Arti e Lettere, voluto da Napoleone per «raccogliere le scoperte, e perfezionare le arti e le scienze» si afferma come fucina di pensiero e produzione rigorosi. Soprattutto è la Milano di Alessandro Manzoni; sarà lui, in una città dove il potere parla tedesco, gli intellettuali francese e il popolo usa il dialetto, a credere, insistere e affaticarsi nella lingua italiana, diffondendola come elemento decisivo di letteratura e, quindi, di civiltà nazionale unitaria.
Giandomenico Romagnosi, padre dell’idea di «incivilimento», aveva collaborato con i francesi alla stesura del codice di diritto penale, proseguendo la sua attività di giurista fino a divieto di insegnamento imposto dagli austriaci. Quando muore (1835) il suo influsso si è già esteso ai giovani allievi che avrebbero giocato un ruolo determinante negli anni successivi: Francesco Restelli, Giuseppe Ferrari, Defendente e Giuseppe Sacchi, e – su tutti – Carlo Cattaneo. Nel 1838 nasce la Società di incoraggiamento arti e mestieri, di cui Cattaneo diventa segretario; nel 1839 fonda la rivista «Il Politecnico». La scienza e la tecnica diventano l’elemento di miglioramento sociale e il suo interprete è la nobiltà illuminata e soprattutto la borghesia.
Intanto, nel 1835, Ferdinando I succede al padre Francesco. Nel 1838, con simbolismo non irrilevante, fa portare da Monza la corona ferrea per farsi incoronare «re del Lombardo-Veneto».
Le Cinque Giornate
Gli anni della maturazione liberale si compiono con le «Cinque Giornate» del marzo 1848. Milano segue il subbuglio d’Europa con una serie di iniziative di disobbedienza civile che culminano con lo «sciopero del fumo». I milanesi di astengono dall’acquistare il tabacco dei monopoli austriaci per ridurre le loro entrate. Il feldmaresciallo Radetzky risponde con eccidi, coprifuoco e legge marziale, convinto che «tre giorni di terrore» avrebbero garantito «trent’anni di pace». Quando dame nobili e borghesi soccorrono le vittime di un inverno particolarmente freddo e di un raccolto scarso, Radetzky relaziona a Vienna che si tratta di «fanatismo [che] ha contagiato ogni età, ogni classe e tutti e due i sessi». Serpeggiano il malumore e aria di rivolta. Al coro di amici che si rivolgono a lui auspicando l’insurrezione, Cattaneo risponde dalle pagine del suo nuovo giornale, «Il Cisalpino», proponendo un’alternativa riformista, un patto federale tra i popoli dell’Impero ispirato a libertà, trasparenza nella finanza pubblica e «fede reciproca tra governanti e governati». L’obiettivo non è l’indipendenza dall’Austria, ma la libertà.
Il podestà Gabrio Casati mira invece a sfruttare la rivolta per sostituire l’Austria con il Piemonte, avendo già ottenuto da Carlo Alberto la promessa di un intervento.
Scoppiata l’insurrezione, il 19 marzo Cattaneo accetta di prendervi parte formando il Consiglio di Guerra che coordina l’insurrezione. Il 23 marzo gli austriaci si ritirano. Sono morti 300 milanesi e 1000 austriaci. L’appello del governo provvisorio istituito e presieduto da Casati ha successo: Carlo Alberto, a cose fatte, giunge con il suo esercito a Milano tra il 26 e 29 marzo per proteggere «i popoli della Lombardia».
Nelle settimane successive a Milano si incontrano e scontrano tre posizioni diverse. Quella dei notabili moderati di Casati, quella dei repubblicani di Giuseppe Mazzini (arrivato l’8 maggio da Londra) e quella dei democratici federalisti di Cattaneo. Mazzini aderisce all’idea dell’annessione al Piemonte. Cattaneo è sconfitto e lascerà Milano deluso, esiliandosi in Svizzera.
Con lui finisce l’occasione di innovazione politico-istituzionale di Milano. Il dominio francese e il secondo periodo austriaco avevano permesso il consolidarsi di una classe dirigente che sentiva di avere una parola da dire sui destini del Paese. L’idea di nazione, il ruolo della borghesia, lo sviluppo della cultura diffusa e del pensiero tecnico scientifico, perfino l’arte e la musica: tutto aveva nutrito un protagonismo politico originale. Le Cinque Giornate avrebbero potuto essere l’occasione di un disegno ampio. Se il riformismo cattaneiano suonava idealista, lo spostamento dei mazziniani verso i moderati consegnò il patriottismo milanese al traino dei disegni piemontesi. Da allora Milano seguirà passivamente il destino del processo di unificazione sabauda, assecondando, non guidando, la costituzione dell’Italia unita.
Il 29 maggio la Lombardia si esprime rispetto all’annessione con 561.002 voti favorevoli e 681 contrari. Ma alla pomposa e retorica presenza militare piemontese non segue la vittoria definitiva. Si perde tempo e gli austriaci si riorganizzano. È il momento delle occasioni perdute.
I mesi successivi sono all’insegna dell’esitazione e della confusione della guida piemontese. Il 25 luglio i soldati sabaudi sono sconfitti a Custoza. Carlo Alberto tratta la resa e Radetzky torna a Milano. Per la prima volta un nuovo padrone non viene acclamato da Milano: le strade sono deserte e i negozi chiusi. Migliaia di milanesi hanno invece seguito le truppe di Carlo Alberto scegliendo la via di un esilio volontario. Ma a nulla serve la riapertura delle ostilità nel marzo successivo, con la disastrosa sconfitta di Novara e l’abdicazione a favore di Vittorio Emanuele II.
L’unità del Paese. Il primo pezzo di Italia unita
Con il nuovo sovrano (e con Cavour) è la diplomazia a inseguire il medesimo obiettivo: Milano, la Lombardia, il Veneto. L’alleato è la Francia di Napoleone III che, col trattato di Plombières (1858), si impegnava a «difendere» il Piemonte da un eventuale attacco austriaco, allontanando l’aquila a due teste dalla Lombardia e dal Veneto, costituendo il Regno dell’Alta Italia, da consegnare a Vittorio Emanuele II.
Si arriva presto alla guerra; dopo le sconfitte di Montebello, Palestro e Magenta, il 5 giugno 1859 gli austriaci abbandonano definitivamente Milano. Napoleone III e Vittorio Emanuele II entrano in città tra ali di folla. L’ambizioso progetto di conquista del Veneto, invece, si ferma nel sangue dei 30.000 morti di
San Martino e Solferino. Napoleone III firma l’armistizio
di Villafranca, con cui Milano e la Lombardia passano sotto la corona piemontese.
La Lombardia sarà così la prima e unica parte del Paese a essere annessa senza plebiscito, con il solo atto diplomatico del trattato di Zurigo. Quando la questione riemergerà più avanti, si giustificherà la mancata legittimazione ricordando il referendum del 1848, all’indomani delle Cinque Giornate. Cattaneo, già contrario a quel referendum, sarà contrario anche all’armistizio di Villafranca, che separava Lombardia e Veneto, l’unica unità vera – a suo avviso – che fosse stata creata in Italia fino a quel momento.
La riorganizzazione amministrativa
Nei mesi che precedono l’unità del Regno, a Milano avvengono fatti importa...