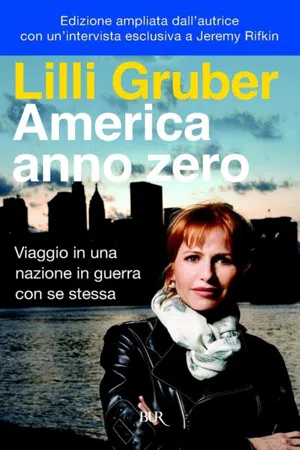![]()
Dedica
A Henry,
l’America che ci manca
![]()
INTRODUZIONE
IL FANTASMA DI LEWIS E CLARK
È IL 23 SETTEMBRE 1806. In una stanzetta nella città di Saint Louis, Stato del Missouri, un uomo sta scrivendo febbrilmente. La lettera, che deve partire subito per Washington, è indirizzata a Thomas Jefferson, presidente degli Stati Uniti d’America. Annuncia la felice conclusione di uno dei più eccezionali viaggi di scoperta della storia: l’esplorazione del Nordamerica dal Mississippi all’Oceano Pacifico.
L’uomo chino sullo scrittoio si chiama Meriwether Lewis. Ha trentadue anni. È alto, ben piazzato, con spalle larghe e mani forti. Il volto dai lineamenti regolari, con il naso pronunciato, è segnato dalla stanchezza. È appena arrivato a Saint Louis, una città vicina alla confluenza tra il Mississippi e il Missouri. Da qui era partito il 14 maggio 1804, diretto verso l’ignoto. Un passo dopo l’altro, un ostacolo dopo l’altro, ma soprattutto una meraviglia dopo l’altra, Lewis, il suo amico William Clark e un gruppetto di ardimentosi hanno attraversato ed esplorato le terre, allora sconosciute agli uomini bianchi, che li separavano dal Pacifico. Sono giunti a destinazione il 24 novembre 1805, impiegando un anno e mezzo. E ci vorrà ancora più di un anno per ritornare al punto di partenza, il 23 settembre 1806. Missione compiuta.
dp n="10" folio="10" ? Mentre su Saint Louis cala la notte Lewis, il capo della spedizione, desidera che Jefferson, colui che ha immaginato e voluto l’impresa, riceva il prima possibile la buona notizia. Gliela comunica con quella missiva scritta in fretta e furia per affidarla a una diligenza che l’aspetta. Lui invece giungerà a Washington il 28 dicembre, giusto in tempo per festeggiare alla Casa Bianca l’arrivo dell’anno 1807. E la vera nascita del Paese destinato a cambiare la storia.
Duecento anni dopo, in un minuscolo negozio di antichità del quartiere De Marollen, a Bruxelles, sto guardando le riproduzioni di due piccoli ritratti. È una giornata grigia e sto approfittando di un’ora di pausa da una riunione in Commissione affari esteri per cercare un regalo di compleanno. Mi sono riparata qui dentro per sfuggire a una pioggia sottile ma persistente. Da come sono accatastati sembra che anche gli oggetti in vendita abbiano fatto lo stesso. La stanza è stipata di mobili, soprammobili, stampe, oggetti. Antichi, pregiati, o semplicemente vecchi. Mentre passo tra un tavolo e una vetrinetta, faccio cadere un portaritratti consunto, di quelli in pelle che possono contenere due foto e volendo si chiudono come un portafoglio e si mettono in tasca. Di solito, ci si trovano bellissime immagini in bianco e nero di coppie d’altri tempi: un uomo azzimato coi baffetti nella cornice di sinistra, una signora snella con il parasole sulla destra.
Questi però sono due uomini. Giovani, avranno forse trent’anni. E non sono foto, ma riproduzioni a colori di ritratti. Due primi piani, mostrano entrambi il viso, il bianco di un’ampia cravatta ottocentesca e il bavero di una marsina nera. L’uomo a sinistra ha i capelli rossicci e lunghe basette, un naso dritto e deciso, e guarda «in macchina» un po’ di sbieco, con espressione altera, forse anche sprezzante. Come se sapesse qualcosa che io non so. Quello a destra invece, che ha radi capelli castani e una bocca morbida e un po’ imbronciata, bizzarramente non «buca lo schermo» del quadro: è voltato verso il suo compagno. E a dire il vero non sembra nemmeno che stia guardando lui, ma qualche cosa dietro o oltre lui, qualche immensità lontana. Da una parte del portaritratti uno sguardo conquistatore, e dall’altra uno sguardo distante.
Chi sono i due uomini? Quale relazione li lega? Il ragazzo dietro al banco del negozietto non lo sa, ricorda solo che ha comprato quell’oggetto di cuoio da un americano. Affascinata, decido di portar via con me i ritratti di quegli sconosciuti, che a quanto pare rimarranno tali. Ma in albergo mi aspetta una sorpresa.
«Ho comprato un mistero» esclamo entrando. Jacques, che mi ha raggiunto da Parigi per un paio di giorni, sta dando gli ultimi ritocchi a un articolo sull’Iran. «Guarda qui» gli dico.
Butta un occhio sui due misteriosi trentenni e si illumina.
«Ah! Ma sono Lewis e Clark! E dove li hai trovati?»
Scopro che ha appena finito di leggere Undaunted Courage (Indomito coraggio), una biografia di Meriwether Lewis scritta dallo storico statunitense Stephen Ambrose. Quest’anno ricorre il bicentenario del viaggio di Lewis e di William Clark attraverso gli Stati Uniti, un’impresa quasi sconosciuta a noi europei ma mitica per gli americani. Per loro, costituisce un vero e proprio momento fondativo della storia nazionale. Il Web brulica di offerte: edizioni dei diari di Lewis e Clark, escursioni che ricalcano il loro itinerario attraverso il Paese, documentari e programmi televisivi.
E io li ho incontrati in un negozietto di antiquariato di Bruxelles. Proprio quando ormai da tempo, dopo tante pagine dedicate al Medio Oriente, sto meditando di spostare la mia attenzione oltreoceano, verso la potenza che tanto conta nel decidere le sorti di quell’area strategica del mondo. L’America ha ormai con l’Europa un rapporto di amore-odio che spesso è di ostacolo alla conoscenza. Forse questo continente di cui ci sembra di sapere tutto andrebbe riscoperto.
Sarà il colpo di fulmine per Lewis e Clark, o la voglia di rimettersi in viaggio, ma Jacques e io decidiamo che si può fare. Quel che ci vuole è la mia amica Caterina Borelli, regista di documentari e bravissima producer. Vive da vent’anni a New York e dell’America sa tutto. Con la sua chioma di capelli biondissimi, quasi bianchi, i vispi occhi neri e il suo gusto creativo in fatto di tessuti e modelli per gli abiti, è una figura che definirei decisamente pop. È efficiente e molto affidabile, e con un elenco di città da visitare e persone da contattare è capace di fare meraviglie. Mentre lei ci organizza lo scheletro del viaggio, cercando di incastrare appuntamenti, alberghi, voli, automobili e visite, Jacques e io consultiamo guide, libri, siti Internet, riviste di ogni genere e soprattutto i nostri carnet di indirizzi americani. Abbiamo lavorato entrambi negli Stati Uniti e abbiamo l’impressione che non basterà mai il tempo per incontrare tutte le persone di cui vogliamo sentire l’opinione.
Man mano che, come Meriwether Lewis, prepariamo la nostra spedizione, la testa mi si riempie di pensieri: è davvero possibile riscoprire l’America? È un Paese che ho sempre amato: la terra delle libertà e dei sogni che si possono realizzare. Ma cinque anni dopo la tragedia dell’ 11 settembre, tre anni dopo l’invasione dell’Iraq e un anno dopo l’uragano Katrina, quel Paese esiste ancora?
L’esplorazione di Lewis e Clark cominciò il 4 luglio 1803. In occasione del ventisettesimo anniversario della Dichiarazione di indipendenza. Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti, aveva appena siglato con Napoleone l’accordo per l’acquisto della Louisiana, raddoppiando con un tratto di penna la superficie della nazione. Un colpo di genio che conferirà all’America la profondità geografica da cui verranno la sua ricchezza e la sua forza. Le nuove terre erano molto vaste: comprendevano due immensi corsi d’acqua, il Mississippi e il Missouri; si estendevano dal Golfo del Messico verso il Canada e includevano il Nord e il Nordovest del continente. Erano popolate da numerose tribù indiane, sparpagliate sul territorio, e da cacciatori di pellicce, in prevalenza francofoni. E soprattutto erano praticamente sconosciute agli americani, che in quel periodo si concentravano lungo la costa atlantica, negli Stati del New England e in quello che era già noto come «il Sud».
Lewis, nato in Virginia nel 1774, apparteneva a una dinastia di soldati e proprietari di piantagioni, e aveva servito nelle milizie territoriali. Jefferson, un amico di famiglia, lo scelse come uomo di fiducia, allo stesso tempo segretario, consigliere, confidente e compagno di mangiate e di bevute. Quando concepì l’idea di un viaggio esplorativo nell’Ovest, dove gli inglesi, i francesi e gli spagnoli si contendevano l’accesso al commercio di pelli pregiate e agli scambi con le tribù indiane, affidò la missione al suo protetto. Lewis cominciò a frequentare le più importanti personalità scientifiche dell’epoca per familiarizzare con la botanica, la zoologia, la cartografia e la medicina, tutte scienze che gli sarebbero state utili durante l’impresa.
Doveva pensare a tutto: progettare una barca dal fondo piatto per risalire il Missouri, l’unica via di accesso alle zone occidentali; escogitare modi per conservare il cibo; procurarsi i medicinali per malattie note e sconosciute; dotarsi di armi e munizioni. Chiese l’assistenza di un uomo che conosceva da anni, con il quale aveva condiviso i pericoli della guerra, un amico, quasi un fratello: William Clark. Anche lui era audace, avventuroso, pronto a venire alle mani per un nonnulla, grande amante del buon cibo e degli alcolici. I due avevano combattuto fianco a fianco durante la Ribellione del Whisky tra il 1791 e il 1794, nello Stato della Pennsylvania, quando i produttori si opponevano, armi in pugno, all’imposizione di una nuova tassa sul prezioso liquore. E ora, insieme, si lanceranno in una nuova avventura.
Lewis è il capo designato della spedizione di 30 uomini, ma Clark è il suo alter ego. Entrambi verranno chiamati «capitano» durante tutto il viaggio. Lewis si occuperà soprattutto di studiare e catalogare flora e fauna, mentre Clark sarà il cartografo. È difficile oggi, nell’epoca delle immagini digitali, capire quanto fosse indispensabile annotare ogni minimo dettaglio, fare schizzi delle piante, dei fiori, degli animali, degli uccelli. Tenere un diario era una necessità, non solo scientifica ma anche sentimentale, per conservare emozioni e ricordi. E consegnare alle generazioni future i frutti e gli insegnamenti di un’esperienza unica.
Ma il viaggio di Lewis e Clark è conquista oltre che scoperta: sottomissione di popoli stranieri. Il messaggio rivolto alle tribù indiane era chiaro: avete un nuovo Padre ed egli risiede a Washington; è con lui che dovete commerciare ed è a lui che dovete obbedire. L’America era alla sua prima esperienza di espansione imperialistica e gettava le radici di una contraddizione che l’assilla ancora oggi: l’incertezza tra i suoi princìpi e le sue azioni, tra l’esigenza di libertà e la sete di potenza.
Furono Lewis e Clark, con la loro determinazione e resistenza fisica e morale, a rivelare al Paese-continente la sua reale misura. Ma i due eroi di questa prima impresa americana conosceranno destini totalmente diversi: uno di loro finirà tragicamente, l’altro avrà invece una vita serena. Come se, fin dalla nascita, l’America potesse scegliere tra successo e fallimento, tra felicità e tormento, tra Bene e Male.
Duecento anni dopo, gli Stati Uniti hanno preso pienamente possesso del loro immenso territorio, e gli americani sono 300 milioni, 60 volte più numerosi rispetto all’epoca della spedizione di Lewis e Clark. L’America è il Paese più ricco e più potente del mondo, e non ha rivali dopo la dissoluzione dell’Urss.
Oggi però è anche una delle nazioni più contestate dall’opinione pubblica internazionale. Uno studio recente del Pew Research Center di Washington lo conferma: «L’antiamericanismo in Europa, in Medio Oriente e in Asia è aumentato con la guerra in Iraq». Vengono guardati con un misto di diffidenza, irritazione e ostilità. Quanto all’immagine dei cittadini statunitensi, definirla controversa è un eufemismo. Alcuni li considerano «laboriosi», «creativi» e «onesti», altri «avidi», «violenti», «volgari» e addirittura «immorali».
Il naufragio della credibilità degli Stati Uniti è associato alla personalità e all’operato di un uomo: George W. Bush. Il quarantatreesimo presidente si è ritrovato padrone dei destini del Paese in un periodo segnato da violenze, povertà, ambizioni, disuguaglianze, ingiustizie. Ingredienti naturali della storia, ma che vanno dominati, non subiti, prima che si trasformino in tragedie. Bush, il suo vicepresidente Richard Cheney e un ristretto circolo di consiglieri hanno scelto dall’inizio di ridurre la complessità di questi problemi a una formula semplicistica: la «guerra contro il terrorismo». È diventata l’unico programma politico, nonché giustificazione morale, obiettivo unico, argomento supremo. Da allora, un misto di messianismo e nazionalismo ha sostituito il pragmatismo e l’esperienza. In nome di questa «guerra» Bush ha concentrato nelle proprie mani tutti i poteri decisionali.
Gli Stati Uniti, guariti dopo l’era di Nixon e dello scandalo Watergate dalle derive autoritarie della Casa Bianca, si ritrovano così nuovamente alle prese con i pericoli di una «presidenza imperiale». Alla famosa frase di Richard Nixon – «È legale perché lo ha deciso il presidente» – ha fatto eco Bush, oltre trent’anni dopo, con il suo celebre «Sono io che decido». Gli effetti si sono fatti sentire subito: le leggi eccezionali, l’erosione delle libertà individuali e le misure arbitrarie si sono moltiplicate.
L’America attraversa un periodo pieno di interrogativi. Ovunque è l’ora di tirare le somme. In nome dei due princìpi fondanti della nazione, la libertà e la giustizia, si alzano voci di denuncia e di protesta. Il Paese sembra risvegliarsi, dopo anni di silenzio, dallo stordimento causato dallo shock dell’11 settembre. E nulla sfugge al nuovo senso critico.
È proprio questo fenomeno di rivolta che voglio capire e valutare. Sono convinta che si debbano attribuire gli errori politici a chi li commette, senza per questo ignorare le qualità di chi li subisce. Non si possono confondere i cittadini con i loro governanti. Questo sbaglio, grave nella maggior parte dei casi, con gli Stati Uniti diventa addirittura capitale. Perché ciò che sono e ciò che diventeranno riguarda ciascuno di noi. Grazie alla loro ineguagliabile potenza – militare, economica, culturale – possono cercare e trovare soluzioni. O al contrario scatenare nuovi conflitti.
Mi metterò alla ricerca dell’America ribelle che vuole sostituire l’intelligenza e l’immaginazione alla forza e all’autoritarismo. È una battaglia campale, uno scontro come quelli che piacciono a Bush: tra il Bene e il Male, tra le forze oscurantiste e quelle più illuminate. Ma oggi la superiorità morale ha cambiato campo: i «cattivi» stanno dietro le quinte del potere, i «buoni» per la strada, su Internet, nelle redazioni, nelle biblioteche, nelle università, sugli schermi dei cinema.
Gli appuntamenti elettorali sono molto vicini. A novembre 2006 ci saranno le cosiddette elezioni di medio termine del Congresso, oggi in mano ai repubblicani. Tutti i 435 deputati della Camera cercheranno di farsi rinnovare il mandato dopo due anni. Stessa sorte per un terzo dei 100 senatori e per 36 governatori di singoli Stati. Si andrà alle urne anche per rinnovare molte amministrazioni locali. Nell’autunno del 2008 sarà la volta delle presidenziali, in cui i democratici tenteranno di riprendersi dopo otto anni il controllo della Casa Bianca.
La squadra che prenderà il posto di Bush riuscirà a infondere nuova vita nel sogno americano?
C’è bisogno di un nuovo inizio, un «anno zero» da cui ripartire per restaurare un’immagine macchiata, deformata negli stereotipi e nelle caricature dell’era Bush. Attraversando il Paese dalla costa orientale a quella occidentale, vorrei capire quali sono i tasselli che comporranno il mosaico della nuova America.
Jacques e io partiremo da New York, la città che gioca d’anticipo sui trend e sulle trasformazioni degli Stati Uniti. E che proprio per questo li rappresenta, perché fonde idee e persone dell’America e del mondo. Ma allo stesso tempo è un’isola autonoma che difende la propria diversità rispetto al resto del continente. Nella Grande Mela resteremo diversi giorni, per ascoltare i battiti del polso della grande nazione. Poi ci inoltreremo nelle singole realtà della sua vita sociale, politica e culturale: Boston piena di storia, Detroit annientata dalla crisi dell’industria automobilistica, San Francisco lanciata verso le nuove frontiere tecnologiche, Los Angeles fabbrica dei sogni e degli incubi, Las Vegas inondata di luci e peccati, New Orleans devastata che cerca di riemergere saranno alcune delle tappe del nostro viaggio. Che si concluderà a Washington, la città del potere – nel bene e nel male.
Voglio incontrare chi non ha mai smesso di pensare, parlare, difendere i princìpi fondamentali: dall’attrice Susan Sarandon all’ex vicepresidente Al Gore, da Kerry Kennedy, nipote di JFK, allo scrittore Ray Bradbury. E poi generali ribelli, veterani di guerre inutili, maghi dell’hi-tech, strateghi della parola, ex pirati redenti di Wall Street, clandestini idoli delle folle, avvocatesse che difendono terroristi, Mata Hari irachene, preti gay paladini dei poveri, talebani cinesi, scrittrici travestite da uomo, leggende del giornalismo d’inchiesta, fondamentalisti cristiani, premi Oscar controversi, patriarchi del jazz, guru dell’ambiente, madri coraggio, futurologhe che leggono lo schermo di cristalli liquidi.
L’America è una realtà complessa, lontana dai luoghi comuni che troppo spesso impediscono a noi europei di apprezzarla. Capire questo significa rilanciare un dialogo tra le due rive dell’Atlantico, che oggi più che mai è vitale per le sorti del mondo.
![]()
CAPITOLO 1
LA FERITA DI GROUND ZERO
BUSH HA COMINCIATO la sua cavalcata verso il potere imperiale sulle macerie ancora fumanti di Ground Zero. Me lo ricordo bene con il megafono in mano mentre diceva: «Quelli che hanno distrutto queste Torri molto presto ci sentiranno».
L’11 settembre 2001, con i suoi 2749 morti, ha rappresentato la peggiore catastrofe della storia di New York e ha ampiamente oltrepassato i suoi confini. Mentre le immagini degli aerei che si schiantavano contro le Torri Gemelle del World Trade Center invadevano le televisioni, gli abitanti della più grande metropoli americana e quelli del mondo intero hanno avuto la stessa sensazione: niente sarebbe più stato come prima.
Ero arrivata a New York solo due giorni dopo la tragedia perché tutti gli aeroporti erano chiusi. Un viaggio travagliato: una falsa partenza da Roma, con l’aereo che sopra l’Atlantico invertiva la rotta e tornava indietro; il giorno dopo un nuovo tentativo e un atterraggio a Cincinnati; infine, ultima tappa, un volo interno verso la Grande Mela colpita. Il pilota ci aveva fatto sorvolare Manhattan. Una colonna di fumo e di polvere si levava verso il cielo sopra la voragine in cui erano ammassate le macerie del Wtc. Un alone di luce bagnava la piaga aperta nel cuore della città, e immaginavo le squadre di soccorso al lavoro sotto enormi riflettori nel tentativo di recuperare i superstiti. Mi recai subito sul posto e da lì andai in onda ogni giorno in diretta per cercare di spiegare quanto era successo.
Ci torno ora, 11 aprile 2006, quattro anni e mezzo dopo, per fare un bilancio. Ground Zero è il luogo geogra...