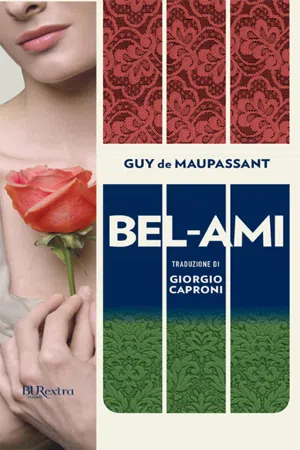![]()
Parte seconda
![]()
I
Georges Duroy aveva ripreso tutte le vecchie abitudini.
Sistemato adesso nell’appartamentino a terreno di Rue de Constantinople, viveva saviamente, da uomo che sta preparandosi a una nuova esistenza. Anche le sue relazioni con la signora de Marelle avevano assunto un andazzo coniugale, come se volesse allenarsi al prossimo evento; la sua amante, spesso meravigliata dal quieto trantran della loro unione, ripeteva ridendo: «Sei diventato un omino tutto casa più di mio marito. Quasi quasi non valeva la pena di cambiare».
La signora Forestier non era ancora tornata. Indugiava a Cannes. Georges ricevette una sua lettera che ne annunciava il ritorno soltanto per la metà d’aprile, senza un’allusione ai loro addii. Aspettò. Se lei pareva tergiversare, lui era decisissimo, ormai, a usar tutti i mezzi per sposarla. Confidava nella propria stella, nella forza di seduzione di cui si sentiva dotato, forza vaga e irresistibile, capace di piegar qualsiasi donna.
Un breve biglietto lo avvertì che l’ora decisiva stava per scoccare.
Sono a Parigi. Venga a trovarmi.
Madeleine Forestier
«Com’è stato buono» mormorò lei «a venir laggiù in quella tremenda circostanza.»
«Qualunque cosa m’avesse ordinato» rispose lui, «l’avrei fatta.»
Si sedettero. Lei chiese notizie dei Walter, di tutti i colleghi e del giornale. Ci aveva pensato spesso, al giornale.
«Ne sento molto la mancanza» disse. «Molto. Ero diventata giornalista nell’animo. Cosa volete, è un mestiere che mi piace.»
Poi tacque. A lui parve di capire, d’intravedere nel sorriso di lei, nel tono della voce, nelle parole stesse una specie d’invito; e sebbene si fosse ripromesso di non precipitar le cose, balbettò: «Ebbene… perché… perché non riprenderlo… quel mestiere… col… col nome di Duroy?».
Bruscamente lei si rifece seria, e posandogli una mano sul braccio mormorò: «Non parliamo, per ora, di queste cose».
Ma lui intuì che accettava e, caduto in ginocchio, le baciò appassionatamente le mani, barbugliando più volte di seguito: «Grazie, grazie, quanto l’amo!».
Lei si alzò. Si alzò anche lui, e s’accorse ch’era pallidissima. Capì allora di piacerle, forse da un pezzo; e poiché si trovavano a faccia a faccia, se la strinse al petto, poi la baciò in fronte, un lungo bacio tenero e casto.
Dopo essersi liberata scivolandogli di fra le braccia, lei disse seria: «Senta, mio caro, per il momento non ho ancora preso nessuna decisione. Ma potrebbe anche essere un sì. Deve però promettermi di mantenere il più assoluto segreto finché io non la proscioglierò».
Lui giurò e se n’andò col cuore traboccante di gioia.
Da allora fu molto discreto nelle visite, e non sollecitò mai un consenso più esplicito, anche perché il modo che aveva lei di parlar dell’avvenire, di dire «più in là», di far progetti che coinvolgevano entrambe le loro esistenze, costituiva una continua risposta, migliore e più delicata d’un’accettazione formale.
Duroy lavorava sodo, spendeva poco, cercava di raggranellar qualche soldo per non trovarsi all’asciutto al momento delle nozze; e quant’era stato prodigo prima, ora s’era fatto avaro.
Passò l’estate, poi l’autunno, senza che in nessuno sorgesse un sospetto, giacché si vedevano poco, e nel modo più naturale del mondo.
Una sera Madeleine gli disse, guardandolo in fondo agli occhi: «Ne ha già parlato, del nostro progetto, alla signora de Marelle?».
«No, mia cara, le avevo promesso di serbare il segreto, e non ho aperto bocca con anima viva.»
«Be’, forse è venuto il momento d’avvertirla. Coi Walter me ne prenderò io la briga. Lo farà in settimana, vero?»
Lui era arrossito: «Sì, domani stesso».
Lei volse altrove lo sguardo, discreta, per non aver l’aria d’aver notato il suo turbamento, e riprese: «Se vuole, potremmo sposarci ai primi di maggio. Mi sembra l’epoca adatta».
«Mi rimetto in tutto a lei, e con gioia.»
«Il dieci maggio, che cade di sabato, mi piacerebbe molto: compio gli anni.»
«Vada dunque per il dieci maggio.»
«I suoi genitori stanno vicino a Rouen, vero? Almeno, così m’ha detto.»
«Sì, vicino a Rouen, a Canteleu.»
«Che fanno?»
«Sono… dei piccoli possidenti.»
«Ah, muoio dalla voglia di conoscerli!»
Lui esitò, piuttosto perplesso. «Ma… per la verità, sono…» Prese il coraggio a quattro mani, e da uomo risoluto proseguì: «Cara, son dei contadini, due poveri osti che si son cavati il pan di bocca per farmi studiare. Non me ne vergogno affatto, ma la loro… semplicità… i loro… modi rustici, forse potrebbero urtarla».
Lei sorrideva deliziosamente, illuminata in volto da una bontà piena di dolcezza.
«Tutt’altro. Gli vorrò molto bene. Andremo a trovarli. Lo desidero. Riparleremo di questo. Anch’io son figlia di gente modesta… sennonché, io li ho perduti, i genitori. Non ho nessun altro al mondo all’infuori di…» Gli porse la mano e terminò: «… di lei».
Lui si sentì intenerire, commosso e conquistato come non gli era ancora accaduto con una donna.
«M’è venuta in mente una cosa» disse lei, «ma è così difficile dirla.»
«Che cosa?» domandò lui.
«Be’, vede, mio caro, io son come tutte le donne di questo mondo. Ho anch’io… le mie debolezze, le mie piccinerie. Mi piacciono le cose che luccicano… le cose risonanti. Ho sempre sognato di portare un cognome nobile. Non potrebbe, in occasione del nostro matrimonio… nobilitarsi un poco?»
Era arrossita lei, adesso, quasi avesse commesso un’indelicatezza.
«Ci ho pensato spesso» rispose lui con semplicità. «Ma non mi par cosa facile.»
«E perché mai?»
«Perché» rise «temo di rendermi ridicolo.»
Lei alzò le spalle: «Ma figuriamoci, figuriamoci. Lo fanno tutti quanti e nessuno ride. Divida il suo cognome in due: Du Roy. Andrà a pennello».
Con l’aria dell’intenditore, lui rispose subito: «No, non va. È un procedimento troppo semplice, troppo comune, troppo conosciuto. Semmai, avevo pensato d’assumere il nome del mio paesello come pseudonimo letterario, per poi aggiungerlo, a poco a poco, al mio; e soltanto più in là di spezzare il mio cognome in due, come propone lei».
«Il suo paese si chiama Canteleu?»
«Sì.»
«Non mi piace come finisce» osservò lei, perplessa. «Vediamo, non la si potrebbe modificare un tantino, la parola Canteleu?»
Aveva preso sul tavolo una penna e s’era messa a scarabocchiar nomi per veder che figura facevano. Tutt’a un tratto esclamò: «Ecco, ecco qua!».
E gli porse un foglietto su cui era scritto: «Signora Duroy de Cantel».
Georges rifletté un istante, poi disse serio: «Sì, ottimo».
Lei era entusiasta e badava a ripetere: «Duroy de Cantel, Duroy de Cantel, signora Duroy de Cantel. È stupendo, stupendo».
Poi aggiunse convinta: «E vedrà come sarà facile farlo accettare da tutti. Basta non lasciarsi sfuggir l’occasione, giacché dopo sarebbe troppo tardi. Da domani, lei firmerà i suoi articoli D. de Cantel, e gli echi soltanto Duroy. È la cosa più normale del mondo, in giornalismo, e nessuno si meraviglierà che lei abbia assunto un nome di battaglia. Al momento del nostro matrimonio, potremo fare un’altra piccola modifica dicendo agli amici che lei aveva rinunciato al du per modestia, data la sua posizione; o magari, non diremo proprio un bel nulla. Come si chiama suo padre?».
«Alexandre.»
Madeleine mormorò due o tre volte di seguito: «Alexandre», ascoltando la sonorità delle sillabe, poi scrisse su un foglio intatto: «Alexandre du Roy e consorte si onorano di partecipare alla S.V. il matrimonio del figlio Georges du Roy de Cantel con la signora Madeleine Forestier».
Guardò il biglietto scostandolo un poco, soddisfatta dell’effetto, e disse: «Basta un poco di metodo, e si riesce a tutto».
Quando fu per strada, decisissimo ormai a chiamarsi Du Roy, e addirittura Du Roy de Cantel, a Georges parve d’aver acquistato un’importanza nuova. Camminava con aria più spavalda, con la fronte più alta, più fieri i baffi, come deve camminare un gentiluomo. Si sentiva addosso un’euforica voglia di sbandierare ai passanti: «Mi chiamo Du Roy de Cantel».
Ma appena tornato a casa, il pensiero della signora de Marelle lo turbò, e le scrisse subito chiedendole un appuntamento per l’indomani.
«Sarà un affar serio» pensava. «Devo prepararmi a una sfuriata, ma coi fiocchi.»
Vi si rassegnò, con la sua naturale leggerezza, che sempre lo sospingeva ad accantonare ogni fatto sgradevole della vita, e s’accinse a scrivere un articolo brillante sulle nuove tasse da imporre per ristabilir l’equilibrio del bilancio.
Propose cento franchi l’anno per la particella nobiliare, e da cinquecento a mille franchi per i titoli, da quello di barone a quello di principe.
E firmò: D. de Cantel.
Ricevette l’indomani un telegramma della sua amante, la quale gli annunciava che sarebbe giunta da lui al tocco.
La attese con un certo patema, risoluto però a tagliar corto, a spiattellarle tutto senza preamboli, per poi, passata la prima emozione, ragionar saviamente, dimostrandole che non poteva restare scapolo vita natural durante, e che se suo marito s’ostinava a vivere, aveva pur dovuto pensare a un’altra per farne la sua compagna legittima.
Era ansioso, però. E quando sentì squillare il campanello, gli venne addirittura il batticuore.
Lei gli si buttò fra le braccia: «Ciao, Bel-Ami».
Ma trovando piuttosto freddo il suo abbraccio, lo squadrò e gli chiese: «Che hai?».
«Siediti» le disse lui. «Dobbiamo parlare di cose serie.»
Si sedette senza togliersi il cappellino, alzando soltanto la veletta fin sopra la fronte, e attese.
Lui aveva abbassato gli occhi per preparare l’esordio. Cominciò adagio: «Cara, se mi vedi così turbato, così triste e così imbarazzato, è perché ti devo fare una confessione. Ti amo molto, ti amo davvero dal profondo del cuore, tanto che il timore d’addolorarti m’affligge più della notizia stessa che ti devo dare».
Impallidendo, e presa dal tremito: «Che c’è? Parla, presto» disse lei.
Con voce piana ma risoluta, e con quella falsa aria abbacchiata che uno assume nell’annunciare certe felici disgrazie, lui rispose: «C’è che mi sposo».
Lei emise un gran sospiro di donna lì lì per svenire, un sospiro penoso sgorgatole dal profondo del petto, e rimase senza fiato, incapace di dire una parola, ansante com’era.
Vedendo che se ne stava zitta, Georges aggiunse: «Non puoi immaginare quant’ho sofferto prima di risolvermi a questo passo. Ma non ho né posizione né denaro. Sono solo, sperduto in questa Parigi. Mi ci voleva qualcuno a fianco capace di darmi un consiglio, d’esser per me un conforto, un sostegno. È una socia, un’alleata, quella che ho cercato e trovato».
Tacque, sperando che lei rispondesse qualcosa, e già pronto a un furibondo scoppio di collera, a percosse, a ingiurie.
Clotilde si premette una mano sul cuore come per reprimerne i palpiti, sempre sospirando con penosi sussulti che le sollevavano il petto e le scuotevano il capo.
Lui prese la mano rimasta sul bracciolo della poltrona, ma lei la ritirò bruscamente, mormorando come inebetita: «Oh… Dio mio…».
Le si inginocchiò allora davanti, senza tuttavia osar di toccarla, e balbettò, turbato da quel silenzio più di quanto lo sarebbe stato dalle sue escandescenze: «Clo, mia piccola Clo, cerca di capir la mia situazione, di capire in che posizione mi trovo. Oh, se avessi potuto sposar te, che felicità! Ma sei maritata. Che mi restava da fare? Rifletti, su, rifletti! Devo ancora affermarmi, e non ci riuscirò fino a quando non avrò una casa mia. Sapessi!… Ci sono stati dei giorni in cui tuo marito l’avrei ammazzato…».
Parlava con la sua voce dolce, velata, suasiva, una voce che carezzava l’orecchio come una musica.
Vide due lacrimoni gonfiarsi lenti lenti negli occhi attoniti della sua amante, poi scorrerle sulle gote, mentre altri due già stavan formandosi agli angoli delle palpebre.
Mormorò: «Oh, non piangere, Cl...