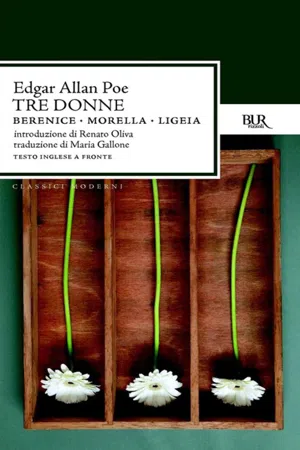
- 158 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Berenice, Morella e Ligeia, tre donne protagoniste di tre tra i più agghiaccianti racconti di Edgar Allan Poe in cui, in un groviglio indissolubile, si mescolano necrofilia, vampirismo, revenant e incubi del nostro più oscuro subconscio. Il sorriso inquietante e i denti scintillanti di Berenice diventano per chi li ammira quasi un'ossessione; la bramosia di conoscenza di Morella la consuma fino all'annichilimento; la forza di Ligeia le permette di ritornare dalla morte per un terribile attimo incarnandosi nel corpo della sua rivale in amore. Tre donne capaci di gettare sugli uomini che le hanno amate il loro fascino più morboso, trascinandoli nell'inferno dell'orrore e forse della dannazione.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Tre donne di Edgar Allan Poe in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788817122566eBook ISBN
9788858628652CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE
1809 Il 19 gennaio Edgar Poe nasce, a Boston, da David Poe, attore, ed Elizabeth Arnold Hopkins, attrice. David Poe abbandona la moglie e scompare. Elizabeth muore, nel 1811.
1811 Rimasto orfano, Edgar Poe viene adottato da John Allan, ricco commerciante di Richmond, e da sua moglie. Poe frequenta la scuola a Richmond. Nel 1815 segue gli Allan in Inghilterra, dove continua gli studi. Nel 1820 ritorna in America insieme agli Allan.
1826 Entra all’Università della Virginia. Dopo meno d’un anno, avendo accumulato debiti di gioco che John Allan si rifiuta di pagare, deve abbandonare l’università. Le sue relazioni con il padre adottivo — l’adozione, però, non venne mai legalizzata — sono sempre più tese.
1827 Poe litiga con John Allan, e lascia Richmond per Boston. Si arruola nell’esercito come soldato semplice. Pubblica, anonimo, Tamerlane and Other Poems (Tamerlano e altre poesie).
1829 Si congeda dall’esercito. Muore la signora Allan. Viene pubblicato Al Aaraaf, Tamerlane and Minor Poems (Al Aaraaf, Tamerlano e poesie minori).
dp n="6" folio="6" ? 1830 Entra all’accademia militare di West Point, ma la sua carriera dura poco. Le spese di un cadetto sono eccessive per Poe, aiutato poco e malvolentieri da John Allan.
1831 Viene espulso dall’accademia. Pubblica i Poems (Poesie). Va a vivere a Baltimora, presso una zia vedova, Maria Clemm. Qui rimarrà fino al 1835.
1833 Vince un premio letterario con il racconto Ms. Found in a Bottle (Manoscritto trovato in una bottiglia).
1834 Muore John Allan, senza menzionare Poe nel testamento.
1835 Diventa vicedirettore del «Southern Literary Messenger» di Richmond, dove si stabilisce con la zia e la cugina, Virginia Clemm. Escono Berenice e Morella.
1836 Sposa sua cugina, Virginia Clemm, non ancora quattordicenne.
1837 Licenziato dal «Southern Literary Messenger», va a New York.
1838 Esce The Narrative of Arthur Gordon Pym (Storia di Gordon Pym). Poe si sposta a Philadelphia. Pubblica Ligeia sull’«American Museum of Literature and the Arts».
1839 Diventa redattore de «The Gentleman’s Magazine». Pubblica diversi racconti, tra cui William Wilson e The Fall of the House of Usher (Il crollo della casa degli Usher).
dp n="7" folio="7" ? 1840 Esce la sua prima raccolta di racconti, Tales of the Grotesque and Arabesque (Racconti grotteschi e arabeschi). Progetta di fondare una sua rivista letteraria.
1841 Diventa redattore del «Graham’s Magazine». Pubblica, tra l’altro, The Murders in the Rue Morgue (I delitti della via Morgue) e A Descent into the Maelström (Una discesa nel Maelström).
1842 Lascia il «Graham’s Magazine», sempre sperando di poter dar avvio alla sua rivista. Virginia, cantando, si rompe un vaso sanguigno. Poe è disperato per la malattia della moglie, tisica. Abusa sempre più dell’alcool. Pubblica tuttavia, tra il 1842 e il 1843, alcuni dei suoi racconti più significativi: Eleonora, The Oval Portrait (Il ritratto ovale), The Mystery of Marie Roget (Il mistero di Marie Roget), The Pit and the Pendulum (Il pozzo e il pendolo), The Tell-Tale Heart (Il cuore rivelatore), The Black Cat (Il gatto nero), e The Gold Bug (Lo scarabeo d’oro) che gli fa vincere un premio letterario.
1844 Si trasferisce a New York.
1845 Pubblica la sua poesia più famosa, The Raven (Il corvo) sull’«Evening Mirror» di New York. Nello stesso anno escono i Tales (Racconti) e The Raven and Other Poems (Il corvo e altre poesie). Poe diventa redattore del «Broadway Journal».
1846 Il «Broadway Journal» cessa le pubblicazioni. Poe si trasferisce a Fordham, poco lontano da New York.
dp n="8" folio="8" ? 1847 Virginia Poe muore. Poe cade in uno stato di profonda prostrazione.
1848 Pubblica Eureka. Avvia quasi contemporaneamente due relazioni amorose con Sarah Helen Whitman (cui propone di sposarlo) e con Annie Richmond. Rotto il fidanzamento con la Whitman progetta di sposare Sarah Elmira Royster.
1849 Muore a Baltimora, il 7 ottobre.
NOTA INTRODUTTIVA
Il palazzo dell’immaginazione
Le stanze di Ligeia: lo studio segreto dove il narratore viene visitato da Ligeia mentre è chino sui libri, intento a studi rari per seguire le orme della sua misteriosa e dottissima maestra; e poi l’interno dell’abbazia riattata, con quel suo décor così sfacciatamente teatrale: la stanza pentagonale nella torre, soffitto gotico, bruciaprofumi saraceno, talamo nuziale indiano, sarcofagi egiziani, a formare un ibrido mélange — già quintessenza, e quasi parodia, del futuro gusto decadente — animato da effetti speciali, come quello dei tendaggi fantasmagorici agitati da un perenne, e artificialmente prodotto, soffio di vento.
La stanza di Morella, non descritta ma sottintesa, anch’essa, come in Ligeia, centro di studi arcani, dove si sviluppa il rapporto mistico-intellettuale — l’unico, poiché l’amor sensuale vi è bandito — tra il narratore e la moglie. La stanza di Berenice, tappezzata di libri, ovattato rifugio del sognatore che si è escluso dal mondo e dal reale (e anche qui i richiami a simbolisti e decadenti, ad Axël e a Des Esseintes, sono immediati).
Quante altre se ne potrebbero citare di stanze: quella in cui si è segregato l’ultimo degli Usher — deboli bagliori di luce vermiglia, drappeggi scuri, mobili pesanti, libri e strumenti musicali, angoli perduti nell’ombra — , e quella del suo ospite — tetro mobilio e gli immancabili panneggi cupi, ondeggianti e fruscianti, alle pareti; quella de L’appuntamento – miscela di luce naturale e artificiale, profumi esalanti dai turiboli e cortinaggi vibranti al suono di una musica sommessa; la stanza nella torre de Il ritratto ovale — arazzi e quadri alle pareti, cortinaggi di velluto nero intorno al letto.
Stanze. Perché gli eroi di Poe vivono poco all’aperto, all’aria libera, sono costantemente e ossessivamente chiusi, nella stiva di una nave, nel castello, nel sotterraneo, nella cripta, nella tomba, nella bara. Ma il luogo della loro libertà fantastica è la stanza. Nel chiuso della stanza vivono le creature della mente. La stanza è metafora della mente, anzi, è la mente, la mente del malato di nervi, dell’ipersensibile e dell’ipereccitabile, dell’oppiomane, del sognatore. Nella stanza (nella mente) del sognatore — Poe è un romantico e tende a concepire l’immaginazione come sogno — è possibile la fuga dal mondo esterno, dall’apparentemente reale, dai limiti imposti all’uomo dalla sua fisicità e dalla materia. Nella stanza la pericolosa libertà del mondo interiore, vago labile cangiante e ancora inesplorato, si sostituisce alla rigida convenzionalità del mondo esterno con le sue leggi già codificate.
«Sognare — dichiara lo straniero de L’appuntamento — , sognare è stato lo scopo della mia esistenza. Ecco perché mi sono costruito questo pergolato di sogni... Lei vede attorno a sé, è vero, un miscuglio eterogeneo di stili architettonici. La purezza ionica è offesa da bizzarrie antidiluviane, e le sfingi d’Egitto si allungano su tappeti d’oro. Le convenzioni di luogo, e soprattutto di tempo, sono gli spauracchi che terrorizzano l’umanità e la distolgono dalla contemplazione del magnifico.» E il narratore di Eleonora afferma: «I sognatori diurni conoscono molte cose che sfuggono a chi sogna solo di notte; nelle loro grigie visioni essi colgono bagliori d’eternità, e tremano, svegliandosi, nell’accorgersi che sono stati sul punto di ghermire il grande segreto». Non v’è dubbio che i personaggi siano qui dei portavoce delle idee di Poe, che amava indulgere alla rêverie e illustrava, in alcune pagine raccolte in Marginalia, questo stato psicologico, quest’inclinazione al sogno ad occhi aperti, questa specie di «malattia del pensiero». La fantasticheria per Poe diventa metodo: attraverso di essa si può spingere alle soglie dell’inconscio ed estrarne quelle specie di sogni che sono gran parte dei suoi racconti e delle poesie. Poe usa la fantasticheria come una tecnica sperimentale per soppiantare i cinque sensi con «miriadi di altri sensi ignoti ai mortali» e cogliere qualche barlume del mondo dello spirito.
Il luogo più propizio a questi esperimenti è la stanza. La stanza, si legge in Morella, è «il palazzo dell’immaginazione», il luogo privilegiato della visione dove i sogni diventano «l’unica vera vita». Nel palazzo dell’immaginazione cadono barriere ritenute invalicabili: anima e corpo, spirito e materia, vita e morte si confondono, comunicano, diventano interscambiabili. La materia può anche non obbedire alle leggi che secondo ragione dovrebbero regolarla. Osserviamo ad esempio il corpo dello straniero ne L’appuntamento: «Di statura era piuttosto inferiore che superiore alla media normale, sebbene vi fossero momenti di intensa passione in cui la sua persona letteralmente si allungava smentendo quanto ho detto prima». E leggiamo Il crollo della casa degli Usher. Osserveremo che — conformemente alla teoria di. Roderick Usher, secondo il quale tutto è animato di vita, anche l’inorganico, anche la pietra — il castello non è pietra inanimata, ma organismo, corpo malato che sta morendo. Questa non è che una delle sorprendenti corrispondenze che vengono istituite nel racconto: la mente malata di Usher corrisponde al (è il) corpo malato della sorella; la malattia-morte di fratello e sorella è la malattia-morte della natura che circonda il castello e del castello stesso; i corpi dei due ultimi rappresentanti della casata degli Usher sono il castello, la materia organica di quelli è la materia inorganica di questo. Allo stesso modo la vita equivale alla (è la) morte. Roderick Usher, in apparenza ancora vivo, è in una condizione di morte in vita, o, addirittura, un morto che parla. La sorella morta, all’inverso, continua a vivere: da molti giorni il fratello la sente, avverte i suoi movimenti, è convinto di averla calata viva nella tomba. Entrambi, come diversi altri personaggi di Poe, sono morti viventi, e la loro identità è suggellata dal vampiresco abbraccio finale che li ricongiunge.
Tutto ciò avviene nella mente malata (nella stanza) di Roderick Usher, ed è filtrato dalla mente scossa e sconvolta del narratore, ma è anche vero, reale. Nella stanza immaginario e reale coincidono, la realtà della mente è la realtà tout court. Perciò la pazzia di Usher e il vacillare della ragione del narratore terrorizzato — il sospetto di pazzia, o le giustificazioni fornite da una sensibilità morbosa o dall’oppiomania, servono, qui come altrove, a render credibile la storia anche da un punto di vista razionale — non inficiano l’autenticità di quanto essi provano e riferiscono. La pazzia, anzi, vale più della salute mentale perché apre una porta su verità altrimenti inaccessibili. La pazzia non è forse, come si domanda il narratore di Eleonora, la forma più alta di intelligenza? Ciò si applica anche alla presunta follia dei narratori di Ligeia, Morella e Berenice, racconti caratterizzati da quella confusione, cui si è appena accennato, tra realtà che il senso comune vorrebbe opposte ed eterogenee e che qui sono invece omogenee ed interscambiabili, parti di un unico Tutto.
Cominciamo con Berenice. Qui un narratore affetto — male romantico, ma poi ancor più tipico dei decadenti — da una morbosa ipersensibilità si esercita infaticabilmente al fantasticare fino a perdere ogni sensazione di esistenza fisica. Nell’ambigua atmosfera della stanza («Era frutto della mia immaginazione eccitata, o della influenza nebbiosa dell’atmosfera, o del crepuscolo incerto della stanza, o erano forse i grigi panneggi che cadevano in pieghe attorno alla sua figura, che provocavano in questa un aspetto così vacillante e vago?») la solidità della materia e lo spessore del corpo si dissolvono: la corporeità viene negata (superata?). L’amore fisico vi è sconosciuto; le passioni del narratore sono tutte mentali, il che d’altronde si addice a Berenice, la quale, più che un essere terreno, più che una donna, è un’astrazione di essere femminile, un fantasma, un’idea. E appunto, per la mente allucinata del narratore, i suoi denti sono, paradossalmente, delle idee. Egeo trasforma tutto in realtà mentali: il mondo perde peso, consistenza e sostanza; la mente di Egeo lo corrode e lo trasforma in idea. Fusione e confusione di materia e spirito, dunque. Ma anche di vita e morte. Con un rovesciamento necrofilo tipicamente poeiano il fascino della corporeità e il desiderio non sono collegati alla vita ma alla morte: insensibile all’ineguagliata bellezza di Berenice nei giorni del suo splendore, il narratore è invece attratto dall’esangue e occhivitrea Berenice prossima al trapasso; è attratto cioè da una Berenice cadavere, da una Berenice fantasma, da una Berenice vampiro. La Bellezza nasce dal Terrore; e il desiderio — di essere vampirizzato, posseduto da quei denti, e di possederli, cioè di possedere finalmente con atto necrofilo Berenice — nasce non dalla vita ma dalla morte; in altri termini non tiene conto del confine apparentemente invalicabile tra quelle due dimensioni, e lo valica con un gesto di trasgressione che dà i brividi al lettore il quale giudichi nell’ottica della normalità e non in quella, diversa, del sognatore. È significativo che solo l’intervento del domestico costringa il narratore, alla fine del racconto, a confrontarsi con la normalità; altrimenti continuerebbe a sognare, solo nella sua biblioteca, cosciente soltanto di essersi appena svegliato da un sogno «eccitante e confuso». Naturalmente, come in molti altri casi, Poe gioca abilmente su una serie di allusioni che permettono, a chi voglia, di costruirsi anche una spiegazione razionale dell’accaduto: il narratore, Egeo, è pazzo; Berenice va soggetta ad attacchi di epilessia che la fanno cadere in catalessi, e viene quindi sepolta viva, per errore o fors’anche per un delittuoso e vampiresco disegno dello stesso Egeo.
Anche in Morella e in Ligeia non c’è soluzione di continuità tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Morella si reincarna nella figlia; Ligeia entra nel corpo di Rowena; solo che mentre in Morella l’accento vien posto sul principio d’identità (un essere torna al mondo identico a se stesso), in Ligeia si sottolinea piuttosto la potenza della volontà individuale che permette a una creatura di superare le barriere della morte. D’altra parte non sembrano già fin dall’inizio, Ligeia e Morella, appartenere all’aldilà? Ligeia, di cui perfino il marito ignora la provenienza, sembra uscita dal nulla, un essere fantomatico dal passo inavvertibile, una donna-ombra, una bellezza del regno dei morti dalla fredda mano marmorea, un sogno da oppio, un’idea di donna, un simbolo d’arcana sapienza. Altrettanto immateriale ci appare Morella, anch’essa dalla fredda mano, anch’essa depositaria di un sapere misterioso e arcano.
Il confine tra vita e morte, dunque, vien mostrato come valicabile in ogni direzione: si pensi, in particolare, al finale di Ligeia con il gioco dei ripetuti passaggi dalla vita alla morte e dalla morte alla vita di Rowena-Ligeia....
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Tre donne (Berenice, Morella, Ligeia)