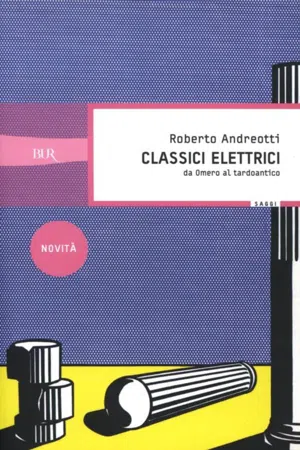![]()
Dedica
Alla memoria di mio padre
![]()
Ringraziamenti
Anche se scaturisce da una serie relativamente recente di articoli, questo libro parte da lontano, riferito com’è all’arco di almeno due stagioni esistenziali. La prima è descritta nel saggio introduttivo, imbastito durante una vacanza all’isola della Maddalena nell’estate 2005 (con forzati ritiri pomeridiani in un appartamento di gusto berlinese), e della cui prima stesura è stato lettore esatto e generoso un maestro dell’interpretazione come Mario Lavagetto: senza il suo incoraggiamento non sarei andato avanti. Preziosi suggerimenti mi sono venuti dagli amici classicisti, in particolare Alessandro Fo e Marina Di Simone, tante volte consultati con profitto anche per la mia rubrica sulla «talpa libri».
La seconda stagione (tuttora in corso) è quella romana della critica militante. Qui la lista dei crediti sarebbe lunga, a cominciare da Alessandra Orsi e Stefania Giorgi, che al «manifesto» diedero fiducia alle mie incursioni classiche. Del gruppo di amici che costituisce la fucina critica di «Alias» mi limiterò metonimicamente a ricordare Federico De Melis – col quale condivido da anni il lavoro quotidiano, l’amicizia e numerose passioni linguistico-visive – e Marco Belpoliti, che è stato decisivo per la realizzazione di questo progetto.
La mia riconoscenza va infine a Lorenzo Fazio per avere accolto il volume nella Bur, a Mariarosa Bricchi – la mia prima, autorevolissima editor – e a Manuela Calandra, che ne ha curato la redazione con rigore ed entusiasmo. Ma più di tutti devo ringraziare mia moglie Tiziana, per la dolcezza e la pazienza con cui mi ha affiancato e sostenuto.
Il libro è dedicato a mio padre, Lucio. È stato lui a farmi capire, sin da bambino, la necessità dello stile, e del Witz.
R.A.
![]()
Filologia della gioventù
In queste pagine d’introduzione a una serie di letture militanti che mi è piaciuto chiamare «elettriche» – perché l’energia del moderno entra sistematicamente in frizione con le letterature classiche – vorrei tentare di rispondere ad alcune domande di bilancio storico-culturale e biografico. Si può affermare con qualche ragione che è esistita una stagione «modernista» della filologia classica? È lecito connotare storicamente come «moderno» un certo metodo di analisi e interpretazione dei testi antichi, analogamente a quanto è avvenuto per le letture novecentesche del romanzo e della poesia contemporanei, e – in parallelo – nel campo della teoria della critica?
Confesso che io stesso non mi sarei immaginato, solo pochi anni fa, di voler tornare ad aggredire con fame da ventenne (e più robusti denti) questioni come «statuto e ideologia della critica», un rango che tutti noi credevamo sistemato. Ma deve trattarsi evidentemente di personali prefigurazioni, privati dèmoni del lontano: neppure il bambino che nel 1969 «inseguiva» Enea ascoltando alla hit-parade le canzoni degli Aphrodite’s Child poteva prevedere con quanta pietas e quali capogiri una quindicina di anni dopo avrebbe sacrificato all’Eneide una significativa porzione della propria gioventù.
Si sa, la mia generazione si è imbevuta come poche del mito della critica: ha vissuto gli aspri scontri tra scuole e indirizzi contrapposti; ha parteggiato, e anche militato, in questo o quello schieramento; molti, poi, hanno assunto quella sfida giovanile come una lezione di metodo per la vita e, una volta adulti, l’hanno giocata nelle diverse forme e occasioni del lavoro intellettuale.
Bisogna subito specificare però che il quartiere degli studi classici non si è mai trasformato, neppure negli anni bollenti delle ideologie critiche, in un campo di Agramante, come invece è accaduto in altri settori; e questo grazie, credo, a una saldissima tradizione filologica, modellata quasi come un vestito sui propri oggetti di studio. I filologi classici cioè hanno elaborato e teorizzato per tempo una propria metodologia per la conservazione e il consumo delle testimonianze letterarie, istituendo contemporaneamente un organico apparato metalinguistico di discipline intercomunicanti, dalla paleografia allo studio dei generi e delle forme, dall’intervento minuto su fatti di stile alla ricostruzione dei flussi di produzione e ricezione dei testi.
Così, intrinsecamente, l’apprendistato di sistemi linguistici e culturali «altri» come il greco e il latino comporta sempre per il filologo una radicale consuetudine con le ragioni elementari del testo antico: che un passo oscuro di Tacito o un verso corrotto di Orazio costituiscano un problema finché non «danno senso», è l’imprescindibile abc di ogni tipo di formazione filologica. Ma poi, a parte obiecti, una specie di argine istituzionale a stravolgimenti didattici o analitici è stato e rimane l’altissimo coefficiente di convenzionalità della pratica letteraria antica, definita nei secoli, dalla Grecia a Roma, attraverso una controllatissima serie di «modelli di discorso» (basta richiamare qui il ruolo strategico svolto dai generi letterari).
In questo senso, anche quando le battaglie critiche degli anni Settanta e Ottanta spaccavano aspramente la comunità antichistica sul piede dell’engagement intellettuale (persino politico e istituzionale, per una certa fase), e all’università il vento del Testo soffiava inarrestabile per ogni dove, in uno schieramento come nell’altro il filologo classico era in fondo il meno impreparato di tutti a fare i conti con l’invasione manu militari delle teorie formaliste.
Quella stagione, com’è noto, è stata archiviata, ma anche certe ideologie novecentesche dell’Antico sono entrate definitivamente in crisi: chi sono i Classici per noi? Che compito dovrebbero svolgere all’interno del nostro sistema culturale, a scuola, all’università, nella società global? Ma poi, quali Classici?1 Per rispondere a interrogativi di questo genere non sembra più sufficiente l’impalcatura epistemologica valida ancora vent’anni fa, e perciò, se mai è esistita una tipologia «modernista» di studio dell’antico, probabilmente essa è anche tramontata insieme ad altri modelli culturali coevi.
Non è mia intenzione però svolgere qui alcuna tesi teorica, vorrei piuttosto procedere a un esercizio di carattere sperimentale. In queste pagine cercherò di attribuire statuto metodologico a una serie di personalissime riflessioni storico-critiche: maestri, libri, apparizioni, figure, effetti di lettura, tracce di memoria «di scuola», per lo più provenienti da quell’ideale zona mista in cui l’apprendimento culturale (la parola nobile è Ausbildung) si compromette e s’interseca, spesso in modo definitivo, con le ragioni della vita.
Una breve precisazione, allora, sulle cornici storiche. L’arco temporale di questa ipotetica stagione «modernista» della filologia – compreso grosso modo tra il secondo dopoguerra e la prima metà degli anni Ottanta – verrà indagato (e rievocato) attraverso la ricostruzione soggettiva, persino un po’ psicagogica, di una certa educazione istituzionale a quella che si sarebbe detta un tempo, con fragore di ottoni, Altertumswissenschaft, cioè la scienza dell’antichità pensata e teorizzata dai tedeschi nell’Ottocento. E vorrei subito rammentare ai lettori più giovani che in fondo si è trattato – per noi allevati sui carboni non ancora spenti del Sessantotto – di una vera e propria sfida generazionale: una generazione che ha fatto i conti cioè con il primo, provvisorio bilancio di eredità – in parte corroborante, in parte già fallimentare – di quella speciale richiesta di liberazione politico-esistenziale che era esplosa alla fine degli anni Sessanta (ma non c’erano più molti Dreamers in giro per le aule di filologia solo un decennio più tardi).
L’altra cornice di riferimento è a contrasto – qui il compasso inevitabilmente si allunga fino ai giorni nostri – e comprende più che altro gli effetti (tuttora in pieno corso) di una diffusa crisi epistemologica. Diciamo, in sintesi, la parabola postmoderna e il tramonto dei pensieri forti: una crisi che ha posto termine (la «letteratura postuma», «la fine della critica»...) a canoni e sistemi ermeneutici un tempo sovrani, introducendo di converso, persino nelle vaccinatissime discipline antichistiche, pratiche come l’ipercomparativismo e la critica neotematica o contenutistica di chiara marca anglosassone.
Dato il loro carattere asistematico – tracce intellettuali e sentimentali, paroles più che langue – cercherò di mettere in forma questi appunti agendo di volta in volta su pedali diversi, adottando cioè due tipi di esposizione, in Bildern e in Begriffen, come dicono i tedeschi, per immagini e per concetti.
Biblioteche parlanti
Tra le impronte formative va annoverata senz’altro la tradizione delle biblioteche di filologia. Già, le biblioteche!
Per ogni studente e studioso di antichità la biblioteca è, anzitutto, un luogo rituale che funziona da serbatoio e da laboratorio critico. Lì viene conservato e venerato, come dentro a un recinto di culto, il grande corpo dei classici, l’insieme (discreto, ordinato, consultabile) dei testi sopravvissuti al setaccio dei secoli, via via trasformati in veri e propri dispositivi scientifici interattivi. Degli antichi scrittori ogni biblioteca di filologia custodisce, sistema, e per così dire metabolizza i manufatti letterari, le opere. Sin dalle origini le opere non sono state tramandate «nude», ma sempre «vestite» di una ragionata «ideologia della forma», attraverso il filtro di una Kulturkritik, all’incrocio di saperi e modelli di comportamento, di civiltà. Ora, mentre il corpus totale dei testi è sostanzialmente fissato per sempre (compresa la produzione secondaria, dalla traditio indiretta alla esegesi antica, le quali a loro volta appunto «fanno testo»), non si è mai arrestato il processo moderno di rielaborazione culturale della – più o meno fittizia, più o meno astratta – Antichità: e perciò anche dei suoi data, testuali e letterari (oltre che storici e archeologici). Così quel corpus dei classici ha prodotto diverse gamme di standard – valori politici, sentimenti, paradigmi – performati volta a volta dalla mentalità e dalla ideologia di lettori posteri, il cui atteggiamento cognitivo ha potuto orientare anche pesantemente il profilo della ricostruzione storica e persino filologica. In questo senso, dai testi e con i testi noi riceviamo sempre – e dobbiamo ogni volta sceverarlo – anche il feedback delle letture che essi si sono caricate fino a noi; e una biblioteca di classici antichi efficiente sarà certo in grado di mostrare le tracce dei successivi turni epistemologici, cosicché ogni nuovo contributo di studio, per quanto obiettivante sia il gesto culturale da cui è scaturito, dovrà sempre rendersi comprensibile e utile a partire da tutto quello che era stato inciso prima, e porsi in ideale relazione con quanto si scriverà dopo.
C’è un altro elemento a proposito della figurazione del pianeta-biblioteca, pianeta che si mostrava un po’ più familiare solo a mano a mano che si imparava a praticarlo: gli autori classici vengono tradizionalmente catalogati e disposti a dizionario, cioè alfabeticamente e non cronologicamente, e suddivisi in due continenti linguistici, diciamo da Alceo a Tucidide, da Agostino a Vitruvio. La biblioteca «moderna» degli antichi cioè è costituita convenzionalmente come un grande organismo bipartito, per disegnare il quale si sacrifica alla sistemazione sincronica la naturale successione diacronica delle generazioni di auctores, così importante del resto per stabilire parentele, influenze, confronti, imitazioni. Il Classico perciò come insieme interlinguistico coeso e solidale, perfettamente conchiuso; l’unità inscindibile delle lingue classiche come garanzia «positiva» di scientificità; i testi letterari come il luogo deputato a conoscere, in definitiva, il senso della storia, lo spirito e la coscienza della civiltà greco-romana... Una versione spavalda dell’autonomia del sapere antichistico che rimonta ad August Böckh.
La nostra fretta di stabilire connessioni («only connect!») ci avrebbe spinto persino a immaginare una figurazione alla Borges: la biblioteca classica come luogo dove tutto il sapere canonicamente «si tiene» (erano proprio gli anni del dilagante culto di Borges, quelli). In realtà lo «spazio» della letteratura antica, come del resto avevano celebrato i filologi tedeschi con la grande caccia ai loci similes e alle influenze tra autore e autore, è l’esatto contrario di un mosaico decostruttivista – in cui chi viene dopo «può» avere contagiato chi è venuto prima.
La classicità che ancora la mia generazione aveva ricevuto, sin dalla scuola, appariva come un mondo raffreddato e compatto, lontano sì, ma dai contorni in fondo familiari; in realtà tale immagine sintetica era convenzionale, essendo stata via via composta attraverso una lunga serie «calda» di letture ideologiche e interpretazioni con effetto retroattivo, la proiezione cioè di un nostro modo «interessato» di pensare gli Antichi (più «la» Grecia che «le» Grecie, per esempio). Ormai questo guscio olistico con cui il Novecento tendeva a figurarsi la semiosfera classica si sta definitivamente frantumando. Oggi noi lavoriamo a quel sistema con maggiore cautela interpretativa, approfondendo le pluralità e le contraddizioni, le differenze di scala e di valori nell’avvicendarsi storico delle civiltà classiche – epoche, ideologie, istituti letterari – e delle loro autorappresentazioni. Soprattutto, facciamo attenzione a stagliare dialetticamente questi «oggetti» sul nostro schermo culturale, sia per comprenderne meglio la potente diversità – e le ricadute effettive su di noi, sia per allontanare il rischio di schiacciare gli Antichi contro un indistinto fondale piatto, privato di orografia.
Il secolo tedesco
Nelle sterminate collezioni delle biblioteche di letteratura greca e latina l’Erudizione ci si rivelava senza apparenti ferite, dopo la stagione dell’antinozionismo sessantottino: un’erudizione maiuscola, dalla fisionomia ancora abbastanza germanica, e non solo nei criteri di smistamento disciplinare. D’altronde l’Ottocento, secolo fondante della filologia classica, aveva messo a punto un ordinamento ideologico d’acciaio, dove il contributo tedesco era stato superiore a quello delle altre lingue. Onori e oneri: anche, inevitabile, una sarcastica nomea, per cui ad esempio già negli anni Venti il «pisano» Ezra Pound, in un testo in cui pure lamentava le vistose carenze del sistema critico-letterario americano (e inglese) di inizio secolo, poteva concludere con questa feroce stoccata: «Ma per carità non ci dimentichiamo di alludere alla "filologia" e al "sistema tedesco". Storicamente parlando, "noi" possiamo dire che questo sistema fu concepito per inibire il pensiero. Dopo il 1848 venne osservato, in Germania, che qualcuno pensava. Era necessario delimitare questa perniciosa attività, ai pensanti fu dato un uovo di porcellana con l’etichetta "erudizione", e man mano essi furono resi inabili alla vita attiva, o ad alcun contatto con la vita in genere. La letteratura fu permessa solo come oggetto di studio. E il suo studio fu così calcolato da allontanare la mente dello studioso dalla letteratura e attirarla entro il vuoto».2
Cinquant’anni dopo questa maligna caricatura, il virus marmorizzante della filologia teutonica poteva dirsi debellato? La sfilza dei trapassati (eruditissimi) filologi tedeschi, e di tutti quei terrificanti libri-pipistrello addormentati sugli scaffali, avrebbe finito per avvelenarci strappandoci a poco a poco alla letteratura di vita? Intanto ...